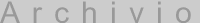| |
"L'ORDA D'ORO"
INTRODUZIONE ALL'EDIZIONE TEDESCA
Qui si può osservare che, al contrario delle falsificazioni postume, il massimo di conflitto coincise nel Paese-Italia con una stagione di dilatazione della sfera delle libertà individuali e collettive, che non aveva avuto eguali nei decenni precedenti; infatti se è vero che conquiste come il divorzio o la legge sull'aborto erano già patrimonio acquisito di molte democrazie occidentali, la caratteristica saliente del caso-Italia è consistita nell'aver imposto dal "basso", con un'azione di "movimento", queste conquiste, che quasi sempre erano tiepidamente sostenute dai partiti della sinistra istituzionale. Nella vicenda giuridica, poi, dello "Statuto dei Lavoratori" ci troviamo di fronte a un risultato che non ha eguali nella storia del movimento operaio occidentale.
Quando nel 1987 io e Balestrini, con l'aiuto prezioso di Sergio Bianchi, iniziammo a scrivere L'Orda d'oro eravamo alla vigilia del ventennale del Sessantotto. Dalla stampa apprendevamo che erano in preparazione molti libri sul medesimo argomento. Per la gran parte si trattava di "memorie" soggettive di protagonisti più o meno importanti della stagione di lotte degli anni Settanta. In televisione infuriavano già le polemiche sugli esiti politici e sociali di quel conflitto. Tutto sommato un clima interessante, ravvivato dal fatto che sugli schermi TV erano passate alcune trasmissioni dedicate a un'altra scadenza, quella del "movimento '77".
Non ci soddisfaceva però la sensazione che il ricordo, la celebrazione (già di per sé un brutto termine) si sarebbero mossi tra una specie di imbalsamazione di quelle vicende storiche e una demonizzazione che tendeva a separare i "buoni" dai "cattivi".
Spartiacque di questa separazione sarebbe stata, secondo queste interpretazioni, la questione dell'uso della violenza. Una banalità in sé, perché un conflitto durato almeno dieci anni e che aveva coinvolto centinaia di migliaia di soggetti sociali non poteva essere ridotto nell'ambito angusto del supposto giudizio etico da dare sulle forme di lotta. Ovvio che la querelle era del tutto funzionale a confermare il riciclaggio istituzionale di coloro che la conducevano e, ragione non meno efficace, funzionale a separare il destino di alcuni da quello di coloro che ancora a centinaia giacevano nelle carceri della Prima Repubblica.
E in realtà a partire dalla fine degli anni Settanta è stato messo in opera in Italia un gigantesco meccanismo di falsificazione della storia di quel decennio, che nella desolante definizione di "Anni di Piombo" trovava la sua sintesi linguistica.
E se l'occultamento e la falsificazione hanno avuto nel PCI (Partito Comunista Italiano) di Enrico Berlinguer il motore principale e il braccio giudiziario; gli ex "dirigenti" dei "gruppi extraparlamentari" non sono stati da meno nella loro ansia di negare e separare il loro passato dagli interessi del presente.
Ed è con questi sentimenti che ci siamo, quasi per caso, messi a scrivere L'Orda d'oro.
Eravamo a Roma in un'estate caldissima, ospiti in una deliziosa casa fresca e accogliente vicino al Pantheon. Nanni Balestrini aveva incontrato il suo vecchio compagno di liceo Massimo Pini della SugarCo, una casa editrice che negli anni Sessanta aveva svolto un ruolo meritorio nel panorama culturale italiano (aveva pubblicato W. Reich, Burroughs, Trotsky, Beckett, Lukács, Korsch ecc.) infastidendo la sinistra ufficiale, da sempre censuratrice degli "eretici".
Negli anni Ottanta però la SugarCo si era avvicinata al PSI (Partito Socialista Italiano) di Bettino Craxi, diventandone in breve una specie di struttura editoriale ufficiale. Lo stesso Massimo Pini era stato chiamato a ricoprire incarichi di grande rilevanza nell'industria di Stato.
Nonostante ciò fu proprio lui a sollecitarci a scrivere un testo sui "movimenti" degli anni Sessanta e Settanta che fosse il più possibile fedele alla complessità espressa da quell'ondata rivoluzionaria.
Ovviamente questo progetto non voleva dire che noi avremmo tentato di essere, come si usa dire, "obiettivi", cosa come noto pressoché impossibile, ma che il nostro essere "di parte" avrebbe significato lo stare criticamente e generosamente a fianco e dentro la storia dei "movimenti", contro il potere costituito, le versioni della storia istituzionali e neo-istituzionali e le loro falsificazioni. La nostra difficile e desiderata imparzialità sarebbe stata quindi relativa al progetto-intenzione di voler "raccontare" la storia di quei conflitti senza privilegiare l'una o l'altra delle infinite sfaccettature ideologiche e organizzative prodotte dai "movimenti extraistituzionali" di quel periodo storico.
Ciò significava confrontarsi con un autentico labirinto, con un laboratorio politico dentro il quale, e per necessità "storica", erano confluiti i rivoli e le correnti principali dei movimenti rivoluzionari ortodossi o eretici dell'ultimo secolo.
Abbiamo così cominciato a costruire tutta una serie di "indici", di possibili "scalette" per trovare una metodologia che desse conto, passo per passo, dell'origine e dello svilupparsi delle molteplici "anime" delle componenti interne del movimento e del conflitto che lo aveva opposto non solo all'organizzazione capitalistica dello Stato e del lavoro, ma anche ai partiti storici della sinistra.
Il libro è stato scritto in quattro-cinque mesi, prima a Roma e poi, ospiti di Barbara e Sergio Bologna, a Milano.
Abbiamo riempito una stanza di decine di libri, oramai fuori commercio, prodotti negli anni Settanta, di centinaia di riviste e documenti provenienti dall'archivio storico della Libreria Calusca o dalle biblioteche personali di compagni.
Abbiamo parlato per mattinate intere con compagni che poi avrebbero dato contributi significativi al testo definitivo (Giairo Daghini, "Bifo", Letizia Paolozzi ecc.): per un mese non abbiamo scritto una riga, ma lentamente siamo riusciti a enucleare alcune linee forti all'interno delle quali far "viaggiare" la narrazione e selezionare l'enorme massa di materiali a carattere documentario.
Abbiamo anche delimitato la vicenda dentro un preciso spazio cronologico (dal luglio 1960 al dicembre 1977).
Ci siamo rapidamente resi conto che non era possibile un taglio storico approfondito (in realtà nessuno di noi è propriamente uno "storico") supportato dai documenti (solo con i documenti per così dire "indispensabili" ne sarebbe sortito un volume di circa mille pagine) e che era preferibile tenersi a metà strada tra la oral-history e il racconto diretto supportato da documenti e testimonianze particolarmente significativi dei passaggi cruciali da una fase all'altra.
Sostanzialmente, più che una storia complessiva ed esaustiva � che rimane comunque da fare � abbiamo pensato di fornire ai lettori, e soprattutto a quelli più giovani, un affresco sufficientemente vasto e semplice di quella straordinaria rivolta esistenziale e politica. Un affresco che però contenesse al suo interno una filigrana interpretativa delle motivazioni che avevano mosso prima la protesta e poi la ribellione. Da un lato quindi uno strumento di lavoro, una bussola per muoversi nel labirinto; dall'altro le contraddizioni irrisolte che avevano così pesantemente inciso sugli esiti storici essendone nel contempo un "motore" indispensabile.
I criteri che quindi ci hanno guidato, sono legati al raccontare, al "rappresentare" la complessità dei "movimenti rivoluzionari" prodotti da un'esemplare generazione della rivolta.
Siamo partiti da quella che Agnes Heller e altri hanno chiamato la "generazione della rivolta esistenziale" (gli anni Cinquanta-Sessanta) per rintracciare le radici di tutti i "Sessantotto": dai beat americani agli hippies e alle Pantere Nere; dalla rivolta contro la "forma partito" e dal rifiuto della "delega" all'autorganizzazione politica orizzontale; dal profondo bisogno di "autonomia del soggetto" al rifiuto della società dei consumi che produce l'"uomo a una dimensione"; dal bisogno-condizione di inventare, creare una "Costituzione materiale della classe" alla contestazione critica, e spesso violenta, della democrazia formale e delle "Costituzioni formali".
Fondamentale era far capire la "globalità" dei nuovi processi di autodeterminazione esistenziale e politica che a partire dalla critica radicale della famiglia nucleare si estendevano alla scuola, al mondo del lavoro, al partito, alle "istituzioni totali" e allo Stato per confluire nell'opposizione globale contro la forma massima di dominio che è l'imperialismo. Con una sorprendente armonia si realizzava così, e a partire dal proprio quotidiano, la saldatura tra "la liberazione di sé come condizione indispensabile per la liberazione di tutti", e lo schierarsi con le lotte di liberazione di tutti i Sud del mondo. Su questo percorso la "contestazione globale" trovava la sua unificazione a livello internazionale.
Al primo posto quindi l'analisi di una ribellione contro il principio di autorità e di dominio con il profondo bisogno di autodeterminazione della soggettività, all'interno di un periodo storico che vedeva il Paese-Italia passare da una fase di ricostruzione industriale post-bellica (un mix tra mondo contadino e mondo operaio urbano) a una fase più capitalisticamente matura, dove l'estensione del fordismo determinava sia la trasformazione dell'universo della fabbrica sia lo spostamento di enormi masse di lavoratori dalla campagne del Sud alle zone industrializzate del Nord.
Il fordismo portava con sé, come processo indispensabile, la società dei consumi e la razionalizzazione di un modello gerarchico della società che dalla fabbrica si estendeva a tutto il resto della società e alle forme di rappresentanza politica. Il neocapitalismo italiano (così verrà chiamato) degli anni Sessanta è stato un formidabile intreccio di innovazione democratica e di repressione poliziesca.
Un sistema politico bloccato e arretrato non riuscì a dare risposte concrete a un sociale contraddistinto tanto dal bisogno di rifiuto dei nuovi disciplinamenti produttivi quanto dall'intrinseca necessità di un grande processo di modernizzazione della società.
In questo contesto si inserirono con forza i movimenti rivoluzionari continuamente sospesi tra la volontà di opporsi e governare in modo diverso le trasformazioni in atto e la tendenziale "fuga" controculturale in un'ideale società separata come forma del rifiuto complessivo.
E, in effetti, nel nostro testo viene frequentemente sottolineata la frattura tra l'area controculturale e quella politica. Una frattura che si era consumata verso la fine del 1968, che aveva avuto un suo generoso e fallito tentativo di ricomposizione con il Festival di Parco Lambro nel 1976, per poi trasformarsi nella breve e drammatica stagione del "movimento '77".
Negli ultimi anni alcuni prestigiosi storici democratici hanno dato un contributo assai interessante allo studio della genesi dei '68. Si può dire che le interpretazioni si muovono su almeno tre filoni.
Da un lato c'è chi vede (come Sidney Tarrow) nel lungo ciclo della protesta italiana un formidabile contributo alla formazione della modernità. Per Tarrow (che nel suo Democrazia e Disordine ha analizzato circa cinquemila episodi di conflitto tra il 1965 e il '75) il ciclo della protesta ha dato un contributo di particolare risonanza allo sviluppo della democrazia in Italia: gli individui hanno acquisito una nuova autonomia dalle organizzazioni politiche che pretendevano una delega da loro, nuovi soggetti politici sono entrati in scena e le "domande eccessive" del movimento al suo apice nel '68 e '69 sono state poi mediate attraverso la realizzazione di alcune riforme. Tarrow è d'accordo con coloro i quali pensano che si trattò di "una grande ondata che travolse quasi tutto ma che ha lasciato dietro di sé dei depositi alluvionali". E così il '68 viene recuperato come contributo essenziale alla modernità, mentre il drammatico conflitto italiano sarebbe stato causato essenzialmente dall'arretratezza del quadro politico istituzionale.
Qui si può osservare che, al contrario delle falsificazioni postume, il massimo di conflitto coincise nel Paese-Italia con una stagione di dilatazione della sfera delle libertà individuali e collettive, che non aveva avuto eguali nei decenni precedenti; infatti se è vero che conquiste come il divorzio o la legge sull'aborto erano già patrimonio acquisito di molte democrazie occidentali, la caratteristica saliente del caso-Italia è consistita nell'aver imposto dal "basso", con un'azione di "movimento", queste conquiste, che quasi sempre erano tiepidamente sostenute dai partiti della sinistra istituzionale. Nella vicenda giuridica, poi, dello "Statuto dei Lavoratori" ci troviamo di fronte a un risultato che non ha eguali nella storia del movimento operaio occidentale.
Un'interpretazione completamente opposta a quella di Tarrow è quella che vede nel '68 l'ultima fiammata di una visione arcaica e utopistica insieme. Il '68, lungi dall'aver dato un contributo significativo al mondo moderno, fu l'ultimo tentativo di realizzare un sogno irrealizzabile. La visione del '68, secondo questa interpretazione, con la sua insistenza sulla vita comunitaria e il suo estremismo sociale, si collocava tra le grandi visioni utopistiche, sia cristiane che comuniste. Il '68, allora, come ultimo tentativo di contrapporre alla modernità un'antica rappresentazione di società ideale.
Noi abbiamo invece tentato di evitare sia l'interpretazione rassicurante sia quella liquidatoria, sia pure a carattere "generoso". Abbiamo cercato di sottolineare come i movimenti degli anni Settanta abbiano fatto uno sforzo enorme per elaborare una concezione alternativa della modernità, una concezione che si opponeva in profondità al modello del capitalismo consumista del dopoguerra e in definitiva all'intrinseca e formidabile efficienza del modello gerarchico fordista-taylorista facendolo "saltare" nella sua espressione sociale e ancor più dentro le fabbriche.
Il movimento quindi come "rovesciamento" speculare del paradigma dominante, come espressione radicale e irriducibile della maturità raggiunta dal conflitto capitale-lavoro.
Se molti hanno lamentato la caducità, la parzialità e, a volte, la genericità, delle proposte alternative al capitalismo elaborate dai vari spezzoni del movimento, da parte nostra abbiamo privilegiato invece una visione dei movimenti che non contempla un esito definitivo tipo presa del "Palazzo d'Inverno".
I movimenti degli anni Settanta sono stati molto probabilmente l'ultimo grande "bang" di una storia di rivolte iniziate con la stessa nascita del capitalismo moderno. Dentro la storia e le sue contraddizioni hanno contribuito a portare a termine la parabola alta e definitiva del modello fordista-taylorista, con tutta la sua intelligenza sociale e politica. Hanno dimostrato che la maggior parte di quel modello era sostanzialmente da "buttare" scardinandone dall'interno meccanismi più che sperimentati. Da quel conflitto l'assetto politico-economico italiano è uscito sconvolto in maniera irreversibile e la decadenza del "sistema dei partiti" (compresi quelli di sinistra), che si è verificata alla fine degli anni Ottanta, non è che l'onda lunga di quel conflitto. La tragedia del sindacato e del PCI sta proprio nel non aver compreso e recepito la straordinaria carica innovativa di quell'ondata rivoluzionaria: l'hanno invece duramente repressa alleandosi con il capitale oligarchico e con i corpi repressivi dello Stato e, così facendo, si sono anche sostanzialmente suicidati. La ristrutturazione del sistema produttivo era probabilmente e comunque un'esigenza storica dell'organizzazione capitalistica, una modifica profonda del modello keynesiano-fordista-taylorista un'esigenza strutturale del capitalismo internazionale; ma ciò non poteva e non doveva significare necessariamente l'accettazione passiva del "piano del capitale", così come si stava evidenziando. E se è vero che i "movimenti" hanno dato un contributo determinante nel portare a conclusione e nel rendere impraticabile il modello di comando del ciclo capitalistico degli ultimi cinquant'anni, non si può non sottolineare che la sinistra istituzionale ha accettato passivamente e delegato al capitale stesso il governo delle trasformazioni produttive e sociali.
Nel nostro testo manca del tutto un capitolo dedicato all'analisi della "politica dell'emergenza", che si sviluppò a partire dal 1977 e che vide una complessa alleanza tra le forze moderate e quelle della sinistra istituzionale. Abbiamo tentato di ovviare parzialmente a questa mancanza con un capitolo intitolato "Prime conclusioni", ma indubbiamente l'incidenza di questo fenomeno avrebbe meritato ben altri approfondimenti. E in realtà la pratica dell'"emergenza" divenne una vera e propria forma di governo nel corso di tutti gli anni Ottanta. E la logica dell'emergenza ha definitivamente disarticolato e distrutto l'impianto democratico della Prima Repubblica travolgendo in questo processo buona parte delle dinamiche democratiche degli ultimi decenni della storia repubblicana. Tutto il "sistema dei partiti" ha sostanzialmente contribuito al funzionamento di questa distorta forma di governo delegando alla magistratura enormi poteri giudiziari e discrezionali, elaborando una legislazione "speciale" che avrebbe dovuto avere una funzione transitoria e che invece è stata trasferita nel corpo delle leggi "normale", costruendo decine di "carceri speciali" con trattamento "differenziato", governando continuamente per "decreti" e frequentemente in stridente contrasto con i princìpi della Costituzione. Per fare ciò si è provveduto ad agitare in continuazione un supposto "pericolo per la democrazia", di volta in volta individuato nel "terrorismo", nella criminalità organizzata o in altri fenomeni sociali che mai, in ogni caso, hanno rappresentato un'autentica minaccia per il quadro democratico.
Che questo percorso di trasformazioni istituzionali fosse il riscontro speculare del mutato panorama produttivo, che la violenta modifica dello "Stato di diritto" fosse una necessità intrinseca delle esigenze del "nuovo capitalismo" appare abbastanza evidente e non è questo il luogo per tentarne un'analisi approfondita; ma occorre osservare che il violento conflitto italiano, con il suo produrre migliaia e migliaia di inquisiti e carcerati, con le decine e decine di morti (dall'una e dall'altra parte) che l'hanno drammaticamente segnato, contiene in sé buona parte delle spiegazioni e delle motivazioni profonde utili per comprendere l'attuale quadro politico.
Molti nel mondo occidentale pensano, a ragione, che il caso italiano sia uno dei laboratori sociali e produttivi più rilevanti per decifrare il passaggio epocale da una fase del capitalismo a un'altra. La nuova fase è persino difficile da definire. C'è chi la definisce genericamente post-fordista, chi toyotista, chi semplicemente post-industriale.
Gli anni Ottanta appena conclusi sono stati un periodo oscuro e tormentato del Paese-Italia. Molte sono state le mistificazioni e le ideologie adatte a occultare i processi reali (fra tutte "il pensiero debole", le pagliacciate del "nuovo rinascimento", l'Italia come grande Paese industriale ecc. ecc.). In realtà sono stati anni in cui il capitale a livello nazionale e internazionale si ristrutturava e operava una profonda trasformazione interna, che molti definiscono un'autentica "rivoluzione".
Intorno a questi processi "alti" il grande ciclo dell'eroina, il dilatarsi del "capitale illecito", la distruzione delle soggettività, le generose e drammatiche risposte delle controculture giovanili metropolitane e infine, gli operai chiusi nelle fabbriche, impotenti e attanagliati dall'angoscia per il proprio futuro.
Durante un'inchiesta (1985-1986) ricordo la frase esagerata, ma significativa, di un lavoratore anziano: "Siamo come gli ebrei; ora ci aspetta la soluzione finale". A quell'inchiesta, mai pubblicata, avremmo voluto dare il titolo La paura operaia. La paura, infatti, sembrava essere la tonalità emotiva dominante, la "Stimmung" prevalente tra quei lavoratori che si vivevano come un gruppo di naufraghi. Il loro orizzonte era pesantemente occupato dal problema della droga, di cui quasi tutti, sorprendentemente, mostravano di avere avuto esperienza diretta (ovviamente tra i più giovani) o indiretta per il tramite di parenti e conoscenti (ciò anche a sfatare le banalità che riconducono il problema droga esclusivamente alle fasce marginali giovanili). L'immagine dell'ambiente di lavoro appariva dominata dall'irruzione dell'innovazione tecnologica, percepita nella sua brutale quanto reale valenza di sostitutrice del lavoro umano.
Alla luce odierna molte delle nostre analisi di allora appaiono in parte limitate perché se pure avevano capito come fosse in corso una "rivoluzione interna" del sistema politico, forse non avevano colto appieno come quella fosse una necessità intrinseca della sfera della produzione; non venne compreso fino in fondo che stava avvenendo un'autentica svolta epocale nelle strategie complessive del capitalismo maturo. Ciò a partire, per esempio, dal concetto di "sconfitta operaia", la quale indubbiamente ci fu ma che era la conseguenza di più profonde implicazioni e che così ridotta finiva per cogliere esclusivamente la dimensione politica di quanto, in realtà, è, prima di tutto, era e rimane un gigantesco processo di trasformazione sociale indotto puramente e semplicemente dalla necessità di cambiare in profondità il modo di produrre. Una necessità che nel caso italiano interveniva con un considerevole ritardo, se rapportata ad altre aree economiche capitalistiche; e il ritardo era stato causato principalmente dalla capacità conflittuale e dalla maturità raggiunte sia dai movimenti antagonisti sia, soprattutto, dalla forza autonoma e organizzata del corpo centrale della classe operaia. In questo senso diventa più comprensibile che la mutazione in Italia abbia assunto contorni molto più drammatici che altrove e che per realizzarsi abbia dovuto "far fuori" sia i movimenti antagonisti sia la stessa centralità operaia.
Oggi in Italia abbiamo un governo "liberista" e conservatore, che ha al proprio interno dei ministri fascisti. Lo storico e difettoso "sistema dei partiti" è andato letteralmente in pezzi e tutte quelle forze che avrebbero potuto opporsi a questa miserabile deriva istituzionale sono state disperse e represse nel corso dell'ultimo decennio. La sinistra istituzionale è annichilita dalla sconfitta e priva di un qualsiasi programma politico credibile e in grado di interpretare il profondo sconvolgimento dei processi materiali. Nuove e ambigue "forme di rappresentanza" si sono affacciate sulla scena politica, ma il grande giacimento minerario dei movimenti degli anni Settanta appare disperso e cancellato.
In questo quadro il nostro libro aspira a essere uno strumento della memoria; e poi, citando un autore che peraltro non amo, non è forse vero che "la lotta degli uomini contro il potere è anche la lotta della memoria contro l'oblio"?
Primo Moroni
|