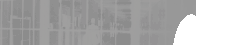AI CONFINI DELLO SPIRITO.
Sia prudente, mi consigliò un amico mosso da buone intenzioni, quando venne a conoscenza del mio progetto di parlare dell'intellettuale ad Auschwitz. Mi raccomandò fermamente di indugiare il meno possibile su Auschwitz, e di soffermarmi invece sulle questioni spirituali. Era inoltre dell'idea che fosse opportuno rinunciare, nei limiti del possibile, a proporre sin dal titolo la parola Auschwitz, a causa delle prevenzioni del pubblico nei confronti di questo termine geografico, storico, politico. Disse che su Auschwitz d'altronde vi sono già libri e documenti d'ogni sorta: chi volesse descriverne le atrocità non racconterebbe alcunché di nuovo. Dubito che il mio amico abbia ragione e perciò, quasi certamente, non potrò seguire il suo consiglio. Non ho la sensazione che su Auschwitz sia stato scritto quanto, ad esempio, sulla musica elettronica o sul Parlamento di Bonn. Inoltre continuo a pensare che sarebbe forse necessario introdurre determinati libri su Auschwitz come letture d'obbligo nelle classi superiori delle scuole secondarie e che più in generale, sarebbe doveroso usare meno riguardi nell'affrontare a livello politico la storia dello spirito. E' vero: in questa sede non ho intenzione di parlare genericamente di Auschwitz, non intendo fornire un resoconto documentaristico e mi sono invece proposto di affrontare il tema del confronto tra Auschwitz e "spirito". Non potrò tuttavia evitare di parlare delle atrocità, di quegli avvenimenti al cospetto dei quali, come una volta disse Brecht, i cuori sono forti, ma deboli i nervi. Il mio tema è «Ai confini dello spirito»; non ho colpa io se questi confini sono segnati proprio da sgradite atrocità.
Volendo parlare dell'intellettuale o come si sarebbe detto in passato dell'«uomo dello spirito» ad Auschwitz, mi pare necessario definire dapprima l'oggetto del mio studio, appunto l'intellettuale. Chi è, nell'accezione da me proposta, un intellettuale o un uomo dello spirito? Non certo chiunque eserciti una cosiddetta professione dell'ingegno; una formazione superiore rappresenta forse, in questo senso, una condizione necessaria ma non sufficiente. Ognuno di noi conosce avvocati, ingegneri, medici, probabilmente anche filologi, che sono certo intelligenti e nei loro ambiti di competenza magari anche eccellenti, e che tuttavia si esiterebbe a definire intellettuali. Un intellettuale, come io vorrei fosse qui inteso, è un essere umano che vive all'interno di un sistema di riferimento che è spirituale nel senso più vasto. L'ambito delle sue associazioni è essenzialmente umanistico o filosofico. Ha una coscienza estetica bene sviluppata. Per tendenza e attitudine è portato al ragionamento astratto. Ad ogni occasione gli si propongono catene associative dalla sfera della storia del pensiero. Se ad esempio gli fosse chiesto quale famoso nome associ alle sillabe «Lilien», non gli verrebbe in mente Otto von Lilienthal, il precursore del volo a vela, bensì il poeta Detlev von Liliencron. Il termine «società» non lo intende in senso mondano, ma sociologico. Il fenomeno fisico che porta al corto circuito non lo interessa; tuttavia conosce bene Neidhart von Reuenthal, il poeta cortese che s'ispirò al mondo contadino.
Un intellettuale di tal fatta, dunque, un uomo che sa a memoria le strofe dei maggiori poeti, che conosce i quadri del Rinascimento e del Surrealismo, e si sa orientare nella storia della filosofia e della musica, questo intellettuale lo collocheremo dunque nel luogo in cui gli si pone il problema di avvalorare la realtà e l'efficacia del suo spirito, ovvero di dichiararle nulle; lo collocheremo in una situazione di confine: ad Auschwitz.
In tal modo, naturalmente, do una collocazione a me stesso. Nella mia doppia qualità di ebreo e di esponente della resistenza belga, ho soggiornato, oltre che a Buchenwald, a Bergen-Belsen e in altri campi di concentramento, per un anno anche ad Auschwitz e più precisamente nel "Nebenlager" [campo secondario] Auschwitz-Monowitz. La parolina «io» si riproporrà più frequentemente di quanto mi sia gradito, e in particolare ogniqualvolta non posso senz'altro attribuire anche a terzi la mia esperienza personale.
In questo contesto è necessario innanzitutto considerare la condizione "esteriore" dell'intellettuale, condizione che egli divideva con tutti, anche con gli esponenti non intellettuali delle professioni cosiddette dell'ingegno. Era una posizione spiacevole che trovava la sua espressione più drammatica nella questione - decisiva per la vita o la morte - dell'inserimento nel lavoro. Ad Auschwitz-Monowitz coloro che esercitavano un lavoro manuale - se, per motivi che non approfondiremo in questa sede, non venivano mandati subito alle camere a gas - abitualmente venivano inquadrati in base al loro mestiere. Un fabbro ad esempio era un privilegiato, poiché poteva tornare utile nella fabbrica della I.G.-Farben allora in costruzione e aveva quindi la possibilità di lavorare al chiuso in un'officina, non esposto alle intemperie. Lo stesso dicasi per l'elettricista, l'idraulico, il falegname o il carpentiere. Il sarto o il ciabattino potevano magari avere la fortuna di finire in un locale dove si lavorava per le S.S. Per il muratore, il cuoco, il radiotecnico, il meccanico per automobili esisteva la possibilità, sia pure quanto mai ridotta, di trovare un posto di lavoro sopportabile e quindi di farcela.
Diversa la situazione per chi esercitava una professione dell'ingegno. Al pari del commerciante, era parte del "Lumpenproletariat" del campo e ne condivideva il destino: era aggregato a un Kommando di lavoro destinato a scavare, posare cavi, trasportare sacchi di cemento o traversine di ferro. Nel campo diventava un operaio non qualificato, costretto a fare la sua parte all'aperto, e ciò solitamente significava che il suo destino era segnato. Vi erano naturalmente delle differenze. I chimici ad esempio, nel campo in questione, venivano utilizzati nella loro professione: accadde al mio compagno di baracca Primo Levi, autore di "Se questo è un uomo", un libro dedicato alla sua esperienza ad Auschwitz. Per i medici esisteva la possibilità di rifugiarsi nei cosiddetti "Krankenbauten" [infermerie]. Ma naturalmente non ci riuscivano tutti. Il medico viennese Viktor Frankl, ad esempio, oggi psicologo di fama mondiale, ad Auschwitz-Monowitz per anni fece lo sterratore. In generale si può dire che gli esponenti delle professioni dell'ingegno per quanto concerne il lavoro si trovavano in una pessima situazione. Non a caso molti cercavano di celare la loro attività originaria. Chi aveva un minimo di abilità pratiche, chi era magari capace di fare qualche lavoretto si spacciava arditamente per operaio, rischiando tuttavia la vita nel caso la bugia fosse stata scoperta. La maggior parte comunque cercava di salvarsi sminuendo la propria posizione. Interrogato circa la propria professione, il professore di liceo o universitario rispondeva timidamente «insegnante», onde non provocare la furia selvaggia della S.S. o del Kapo. L'avvocato si trasformava nel più modesto contabile, il giornalista poteva magari spacciarsi per tipografo, tanto più che difficilmente avrebbe corso il rischio di dover dimostrare le sue capacità artigianali. Ed era così che docenti universitari, avvocati, bibliotecari, storici dell'arte, economisti, matematici si ritrovavano a portare rotaie, tubi e legname per costruzione. La loro abilità e la loro forza fisica erano di norma limitate e solitamente non si doveva attendere a lungo prima che fossero eliminati dal processo produttivo e trasferiti nell'adiacente campo principale, dove vi erano le camere a gas e i forni crematori.
Se era difficile la loro situazione sul lavoro, altrettanto si può dire per la condizione all'interno del campo, dove la vita richiedeva soprattutto agilità fisica e un coraggio che per forza di cose assomigliava molto alla brutalità. Entrambe qualità che i lavoratori dell'ingegno raramente possedevano; il coraggio morale che spesso volevano impiegare in sostituzione di quello fisico, non valeva un fico secco. Si poteva ad esempio porre il problema di impedire a un borsaiolo professionista di Varsavia di rubarci le stringhe. In questi casi poteva tornare utile un buon cazzotto mentre era inservibile quell'ardimento spirituale che spinge un giornalista politico a mettere a repentaglio la propria esistenza pubblicando un articolo sgradito. Inutile precisare che solo molto raramente l'avvocato o l'insegnante liceale erano in grado di dare un pugno a regola d'arte e che anzi il più delle volte erano loro a subirlo: e in questi frangenti dimostravano di non essere, nell'incassare, molto più abili che nel dare. Gravi erano anche le questioni inerenti alla disciplina del campo di concentramento. Chi in precedenza aveva esercitato una professione dell'ingegno di norma non era molto abile nel "Bettenbau" [farsi il letto]. Ricordo compagni colti e istruiti, costretti ogni mattina a lottare, madidi di sudore, con il saccone e le coperte, senza per questo giungere a un qualunque risultato accettabile, cosicché durante il lavoro erano dominati dall'angosciosa idea che una volta tornati al campo per punizione sarebbero stati percossi o privati del cibo. Non erano all'altezza né del rifarsi il letto, né dell'energico «Mźtzen ab!» [giù i berretti!], né, tantomeno, azzeccavano, nei confronti del "BlockŠltester" [anziano della baracca] o della S.S., quel modo di parlare vagamente deferente eppure consapevole, che talvolta consentiva di scansare un pericolo. Nel campo non godevano quindi della stima degli "HŠftlingsvorgesetzten" [superiori prigionieri] e dei compagni, e sul lavoro erano disprezzati dai lavoratori civili e dai Kapo.
Ma c'è di peggio: essi non riuscivano nemmeno a farsi degli "amici". Nella maggior parte dei casi erano costituzionalmente impediti a utilizzare spontaneamente il gergo del campo, l'unica forma accettata di comunicazione reciproca. Si discute molto oggi delle difficoltà di comunicazione dell'uomo moderno, sostenendo non di rado tesi assurde che sarebbe opportuno tacere. Ebbene, nel campo "esisteva" il problema dell'incomunicabilità tra l'uomo dello spirito e la maggior parte dei suoi compagni: si poneva in ogni istante in maniera reale, direi tormentosa. Il prigioniero abituato a un modo di esprimersi relativamente differenziato, solo al prezzo di un grande sforzo su sé stesso riusciva a dire "Hau ab!" [levati di torno!] o ad apostrofare esclusivamente con "Mensch" [tipo] il suo compagno di prigionia. Rammento sin troppo bene il disgusto fisico che mi afferrava perché un compagno, per altri versi dabbene e socievole, si rivolgeva a me usando esclusivamente l'espressione "mein lieber Mann" [caro mio]. L'intellettuale era insofferente a espressioni come "Kźchenbulle" [letteralmente: toro da cucina; cuoco], "organisieren" [organizzare; termine con il quale si definiva l'appropriazione illecita di oggetti], e persino formulazioni come "auf Transport gehen" [essere trasferiti], le proferiva molto malvolentieri.
Detto questo arrivo ai fondamentali problemi psicologici ed esistenziali della vita nel campo, e all'intellettuale nell'accezione limitata del termine che ho tratteggiato in precedenza. La questione di fondo potrebbe essere riassunta nel modo seguente: la cultura e il sostrato intellettuale nei momenti decisivi sono stati di ausilio al prigioniero del campo? L'hanno aiutato a resistere? Quando mi posi questa domanda, dapprima non pensai alla mia esistenza quotidiana ad Auschwitz, ma al bel libro di un amico e compagno di sventura olandese, lo scrittore Nico Rost, intitolato "Goethe in Dachau". Lo ripresi in mano dopo molti anni e vi ritrovai alcune considerazioni che mi parvero quasi irreali. Lessi ad esempio: «Questa mattina avrei voluto riprendere in mano i miei appunti sull'"Hyperion".» Oppure: «Letto nuovamente su Maimonide, del suo influsso su Alberto Magno, Tommaso d'Aquino, Duns Scoto.» E ancora: «Oggi durante l'allarme aereo mi sono sforzato di nuovo di pensare a Herder...» E infine, con mia grande sorpresa: «Leggere ancora di più, studiare ancora di più e con maggiore intensità. In ogni minuto libero! La letteratura classica come surrogato ai pacchi della Croce Rossa.» Rileggendo queste frasi e confrontandole con i miei ricordi del campo, avvertii una profonda vergogna, non avendo io nulla da accostare alla condotta ammirevole, radicalmente spirituale di Nico Rost. No, io non avrei certamente letto nulla su Maimonide, anche se mi fosse capitato fra le mani un volume sull'argomento, il che ad Auschwitz era quasi impensabile. E certamente durante l'allarme aereo non avrei fatto alcun tentativo per riflettere su Herder. E la pretesa di considerare eventualmente la letteratura classica un surrogato ai pacchi alimentari l'avrei respinta più con disperazione che con sarcasmo. Come dicevo, il libro del compagno internato a Dachau suscitò in me un senso di vergogna; alla fine tuttavia riuscii a trovare qualche argomento a mia discolpa: non tanto la circostanza che Nico Rost lavorava in una posizione relativamente privilegiata come infermiere in una "Krankenbaracke", mentre io facevo parte della massa anonima di prigionieri, quanto piuttosto il fatto decisivo che l'olandese si trovava a Dachau e non ad Auschwitz; e i due campi avevano in effetti poco in comune.
Dachau fu uno dei primi campi di concentramento nazionalsocialisti e aveva quindi, se si vuole, una certa tradizione alle spalle. Auschwitz era invece stato creato solo nel 1940 e sino al termine fu soggetto a quotidiane improvvisazioni. A Dachau fra i detenuti prevaleva l'elemento "politico", ad Auschwitz la stragrande maggioranza dei prigionieri era composta da ebrei apolitici e da polacchi politicamente assai instabili. A Dachau la gestione interna era in gran parte in mano ai prigionieri politici, ad Auschwitz dominavano i criminali comuni tedeschi. A Dachau esisteva una biblioteca del campo, ad Auschwitz per il prigioniero normale un libro era qualcosa di inimmaginabile. In linea di principio a Dachau - così come a Buchenwald - per i prigionieri esisteva la possibilità di contrapporre allo stato delle S.S., alla struttura delle S.S., una struttura spirituale: lo spirito vi svolgeva quindi "una funzione sociale", anche se questa si esprimeva soprattutto a livello politico, religioso, ideologico e solo raramente, come nel caso di Nico Rost, anche a livello filosofico ed estetico. Ad Auschwitz invece l'uomo dello spirito era isolato, del tutto abbandonato a sé stesso. Il problema dell'impatto tra spirito e orrore vi si poneva in maniera più radicale e, mi sia consentita l'espressione, in forma "più pura". Ad Auschwitz lo spirito non era che sé stesso e non vi era alcuna possibilità di collegarlo a una qualche struttura sociale, per quanto precaria, per quanto clandestina. L'intellettuale si trovava quindi solo con il suo spirito che altro non era se non pura consapevolezza, e non poteva rinfrancarsi e rafforzarsi al contatto con una realtà sociale. Gli esempi adducibili in questo senso sono in parte banali, in parte invece riferiti a un vissuto esistenziale solo difficilmente comunicabile.
L'intellettuale - quantomeno all'inizio - era sempre alla ricerca della possibilità di una manifestazione sociale dello spirito. Mentre parlava con il compagno di letto che dettagliatamente gli spiegava le ricette della moglie, egli avrebbe ad esempio accennato volentieri alle sue abituali letture. Ma dopo aver ricevuto per l'ennesima volta la stessa risposta: "Scheisse, Mensch!" [merda], lasciava perdere. Ad Auschwitz ogni spiritualità assumeva così progressivamente una forma in duplice senso inedita: era da un lato, a livello psicologico, un'entità assolutamente irreale, e dall'altro, in termini direi sociali, una sorta di lusso vietato. Talvolta si sperimentavano queste situazioni inedite in strati più profondi di quelli raggiungibili conversando col proprio compagno di cuccetta: allora lo spirito perdeva improvvisamente la sua qualità di fondo, la trascendenza.
Ricordo una serata d'inverno, quando dopo il lavoro ci trascinavamo verso il Lager dall'area della I.G.-Farben, mantenendo faticosamente il passo all'odioso "Links zwei, drei, vier" [sinistra, due, tre, quattro] dei Kapo. Davanti a un edificio in costruzione notai una bandiera, esposta per chissà quale motivo. «Die Mauern stehn sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen» [Al freddo muti se ne stanno i muri, nel vento stridono le banderuole], mormorai seguendo meccanicamente un'associazione. Ripetei i versi ad alta voce, rimasi in ascolto del suono delle parole, cercai di tener dietro al ritmo, confidando che emergesse il riferimento emozionale e spirituale che da anni per me si ricollegava a questa lirica di Hšlderlin. Non accadde nulla. La poesia non trascendeva più la realtà. Era lì ed era ormai solo asserzione concreta: questo e quest'altro, e il Kapo grida "links" e la zuppa era liquida e nel vento stridono le banderuole. Forse il sentimento hšlderliniano racchiuso nell'humus psichico si sarebbe manifestato se vi fosse stato un compagno in uno stato d'animo simile al mio, al quale avrei potuto citare la strofa. Il problema più grave era che questo buon compagno non esisteva, non esisteva nella fila del Kommando, non esisteva in tutto il campo. E se per caso si riusciva a scovarlo da qualche parte, di solito, a causa del proprio isolamento, era così estraniato spiritualmente da non essere più in grado di reagire. Mi viene in mente a questo proposito l'incontro con un famoso filosofo di Parigi prigioniero al campo. Ero venuto a conoscenza della sua presenza nel campo e, non senza difficoltà e correndo qualche rischio, ero andato a trovarlo nella sua baracca. Mentre con le nostre gamelle sotto il braccio trottavamo lungo le strade del campo, cercai invano di avviare un dialogo intellettuale. Il filosofo della Sorbona rispondeva meccanicamente, a monosillabi e infine ammutolì del tutto. Non vorrei si parlasse di «abulia». No, egli non era abulico, così come non lo ero io. Semplicemente non credeva più alla realtà del mondo spirituale, e rifiutava un gioco linguistico-intellettuale che in quel luogo non aveva più alcun nesso sociale.
Il problema della funzione o della non funzione sociale dello spirito si poneva in modo particolarmente acuto all'intellettuale ebreo di "formazione culturale tedesca". Qualunque cosa egli cercasse di evocare non apparteneva a lui bensì al nemico. Beethoven. Ma a Berlino lo dirigeva FurtwŠngler, e FurtwŠngler era una rispettata personalità del Terzo Reich. Su Novalis il «Všlkische Beobachter» pubblicava articoli che non erano proprio da gettare. Nietzsche non apparteneva solo a Hitler, il che tutto sommato sarebbe stato ancora accettabile, ma anche a Ernst Bertram, il poeta amico dei nazisti; lui lo capiva. Dalle "Formule magiche" di Merseburgo a Gottfried Benn, da Buxtehude a Richard Strauss, il patrimonio spirituale ed estetico era ormai divenuto indiscussa e indiscutibile proprietà del nemico. Un compagno aveva suscitato la micidiale ira di una S.S., quando, interrogato circa la sua professione, aveva insensatamente detto la verità definendosi germanista. Credo che in quello stesso periodo Thomas Mann laggiù negli Stati Uniti abbia affermato: «Dove sono io è la cultura tedesca.» L'ebreo tedesco detenuto ad Auschwitz non avrebbe potuto avanzare una tesi tanto ardita, nemmeno se per caso fosse stato un Thomas Mann. Non poteva dichiarare di sua proprietà la cultura tedesca, perché la sua rivendicazione non aveva alcuna giustificazione sociale. Nell'emigrazione una piccola minoranza poteva costituirsi in cultura tedesca, anche se Thomas Mann non vi avesse fatto parte. Ad Auschwitz invece il singolo individuo isolato doveva cedere anche all'ultima S.S. tutta la cultura tedesca, compresi Dźrer e Reger, Gryphius e Trakl.
Tuttavia anche quando si riusciva a evocare l'ingenua e discutibile illusione di una Germania «buona» e di una «malvagia», dell'ignobile Thorak, che si cedeva volentieri a Hitler, e del grande Tilman Riemenschneider, al quale veniva imposta la propria solidarietà, anche in queste occasioni lo spirito alla fine necessariamente doveva dichiararsi impotente di fronte alla realtà. I motivi in questo senso sono molteplici ed è difficile analizzarli dapprima separatamente e quindi giungere a una sintesi, come sarebbe opportuno fare. Voglio prescindere da quelli meramente fisici, sebbene non sappia se questo modo di procedere sia legittimo, dato che ogni prigioniero sottostava alla legge della sua più o meno accentuata capacità di resistenza fisica. E' comunque evidente che la questione dell'efficacia dello spirito non può essere posta quando il soggetto, alle soglie della morte per inedia e sfinimento, non è solo despiritualizzato ma letteralmente disumanizzato. Il cosiddetto "Muselmann", come nel linguaggio del Lager veniva chiamato il prigioniero che aveva abbandonato ogni speranza ed era stato abbandonato dai compagni, non possedeva più un ambito di consapevolezza in cui bene e male, nobiltà e bassezza, spiritualità e non spiritualità potessero confrontarsi. Era un cadavere ambulante, un fascio di funzioni fisiche ormai in agonia. Dobbiamo, per quanto dolorosa ci appaia la scelta, escluderlo dalle nostre considerazioni. Io non posso che prendere lo spunto dalla mia condizione personale, dalla condizione di un prigioniero che pativa la fame ma non "moriva" di fame, che veniva percosso ma non ucciso di botte, che era ferito, ma non mortalmente, che quindi oggettivamente ancora possedeva quel sostrato sul quale in linea di principio lo spirito può poggiare e sopravvivere. Poggiava, non vi è dubbio, su fragili basi e sopravviveva malamente: e questa è tutta la triste verità. Ho già accennato al fallimento o meglio al dissolversi di catene associative e reminiscenze estetiche. Nella maggior parte dei casi non rappresentavano una consolazione, talvolta apparivano dolorose e beffarde; il più delle volte si disperdevano in un sentimento di assoluta indifferenza.
Le eccezioni si verificavano in determinati momenti di ebbrezza. Penso a quella volta che un infermiere mi regalò un piatto di semolino dolce che divorai voracemente, raggiungendo uno stato di straordinaria euforia spirituale. Con profonda commozione pensai dapprima al fenomeno della bontà umana, al quale associai l'immagine del probo Joachim Ziemssen, un personaggio della "Montagna incantata" di Thomas Mann. E improvvisamente la mia coscienza si colmò caoticamente del contenuto di libri, di frammenti musicali, e di riflessioni filosofiche che mi apparivano come mia produzione originale. Investito da un impetuoso desiderio di spiritualità e da un penetrante senso di autocompassione, proruppi in lacrime. Uno strato non offuscato della mia coscienza era tuttavia perfettamente consapevole del carattere fallace di questa breve esaltazione spirituale. Si trattava di un vero e proprio stato di ebbrezza, provocato da un fattore fisico. In colloqui avuti successivamente con compagni ho potuto constatare che non fui l'unico a vivere, in situazioni analoghe, un breve momento di conforto spirituale. Anche nei miei compagni di sventura si verificarono spesso simili stati di ebbrezza provocati dal cibo o da un'ormai rara sigaretta. Come ogni ebbrezza, lasciavano dietro di sé un desolante sentimento di vuoto e di vergogna. Erano profondamente falsi, nei loro confronti il valore dello spirito solo difficilmente poteva rafforzarsi. In ogni caso l'immaginazione estetica e tutto ciò che essa in qualche modo cagiona, occupa uno spazio limitato e non di primo piano nell'economia complessiva dell'uomo dello spirito. Più significativo è il pensiero analitico: da lui ci dovremmo aspettare che al cospetto del terrore sia per noi allo stesso tempo un sostegno e una guida.
Anche in questo senso il mio bilancio era e resta deludente. Il pensiero analitico-razionale nel campo, e in specifico ad Auschwitz, non solo non era di alcun aiuto, ma anzi conduceva direttamente verso una tragica dialettica di autodistruzione. Qualche esempio chiarirà facilmente il mio pensiero. In primo luogo l'uomo dello spirito era più restio dei suoi compagni non intellettuali a prendere semplicemente atto di quelle inimmaginabili condizioni. L'antica abitudine a mettere in discussione i fenomeni della realtà quotidiana gli impediva la mera accettazione della realtà del Lager, poiché questa era in contrasto troppo stridente con tutto ciò che sino ad allora egli aveva considerato possibile e accettabile dall'uomo. In libertà aveva sempre frequentato persone disponibili all'argomentazione garbata e ragionevole e non riusciva in alcun modo a capire un dato assai semplice e cioè che nei suoi confronti, nei confronti del prigioniero, le S.S. impiegavano una logica dello sterminio che in sé operava con altrettanta coerenza quanto all'esterno la logica della conservazione della vita. Si doveva essere sempre ben rasati, ma era severamente proibito possedere gli strumenti necessari per radersi, e dal barbiere ci si andava solo ogni quindici giorni. Al vestito a righe non doveva mancare nemmeno un bottone, a rischio di una punizione, e tuttavia se lavorando se ne perdeva uno, il che era inevitabile, non vi era praticamente alcuna possibilità di sostituirlo. Si doveva essere in forze, e tuttavia si veniva sistematicamente indeboliti. All'ingresso nel Lager si veniva privati di tutto, e successivamente dileggiati dai depredatori perché non si possedeva niente. Il detenuto meno avvezzo alla riflessione di norma accettava questa situazione con una certa indifferenza, la medesima indifferenza che fuori, in constatazioni del tipo «ricchi e poveri ci sono sempre stati» oppure «le guerre ci saranno sempre», aveva dato buona prova di sé. Prendeva atto dalle circostanze, si adeguava e in casi favorevoli trionfava su di esse. L'intellettuale invece si ribellava nell'impotenza del pensiero. All'inizio per lui valeva una sorta di folle saggezza ribellistica secondo la quale certamente non può esistere ciò che non è lecito che esista. Solo all'inizio, tuttavia.
Il rifiuto della logica delle S.S., la rivolta interiore, il ripetere gli scongiuri di rito («ma non è possibile»), tutto ciò non durava a lungo. Dopo qualche tempo inevitabilmente s'imponeva qualcosa che andava oltre la semplice rassegnazione e che potremmo definire l'accettazione non solo della logica ma anche del sistema di valori delle S.S. E anche in questa occasione il prigioniero intellettuale doveva affrontare maggiori difficoltà rispetto al suo compagno non intellettuale, per il quale non era mai esistita una logica umana generale, ma solo un coerente sistema di autoconservazione. Sì, fuori aveva affermato «ricchi e poveri ci sono sempre stati», ma una volta preso atto della situazione, senza avvertire alcuna contraddizione egli aveva combattuto la guerra dei poveri contro i ricchi. Dal suo punto di vista, la logica del Lager non era altro che un'acutizzazione graduale della logica economica, alla quale reagiva con un'efficace mescolanza di rassegnazione e disponibilità alla difesa. L'intellettuale invece, che dopo il crollo della sua prima resistenza interiore aveva riconosciuto come possa invece esistere ciò che non deve esistere, che sperimentava la logica delle S.S. come una realtà che andava rivelandosi istante dopo istante, nella riflessione procedeva ancora di qualche fatale passo. Il fatto che fossero incontestabilmente più forti non legittimava forse i suoi aguzzini ad annientarlo? La sostanziale tolleranza spirituale e il sistematico dubitare tipici dell'intellettuale divenivano così fattori di autodistruzione. Sì, le S.S. potevano agire come agivano: non esiste alcun diritto naturale e le categorie morali vanno e vengono come le mode. Esisteva una Germania che conduceva alla morte ebrei e avversari politici, ritenendo di potersi realizzare solo in questo modo. Cos'altro si poteva aggiungere? La civiltà greca poggiava sulla schiavitù, e su Milo un esercito ateniese aveva infuriato come le S.S. in Ucraina. Immani erano stati, sin dove è possibile scandagliare le profondità della storia, i sacrifici umani, e l'eterno progresso dell'umanità altro non era che un'ingenuità del diciannovesimo secolo. «Links, zwei, drei, vier» era un rituale come tanti altri. Vi era ben poco da dire contro le atrocità. Ai lati della Via Appia erano state poste file di schiavi crocifissi, e laggiù a Birkenau si diffondeva l'odore dei cadaveri bruciati. Non eravamo i Crasso, ma gli Spartaco della situazione, tutto qui. «DŠmmt den Rhein mit ihren Leichen; Lasst, gestŠuft von ihrem Bein, SchŠumend um die Pfalz ihn weichen» [Arginate il Reno coi loro cadaveri; sbarrato dalle loro ossa, fatelo scorrere intorno al Palatinato]: così Kleist aveva cantato il Reno, e chissà, se fosse stato al potere magari avrebbe realizzato la sua fantasia di morte. Un generale von Kleist aveva il comando da qualche parte sul fronte russo, e forse costruiva sbarramenti con i cadaveri di ebrei e polacchi. Così è sempre andata, così va la storia. Si era finiti sotto le sue ruote e ci si toglieva il berretto quando passava un boia. Una volta affievolitasi la prima resistenza, l'uomo dello spirito con il suo sapere e le sue analisi, aveva, per difendersi dagli aguzzini, meno strumenti del non intellettuale: pronto a scattare sull'attenti, e quindi maggiormente apprezzato, quest'ultimo, imboscandosi sistematicamente e rubando con grande destrezza, sapeva combatterli con spontaneità e incisività ben maggiori del suo pensieroso compagno.
In misura maggiore del prigioniero non intellettuale, l'uomo dello spirito era paralizzato dal suo radicato rispetto per il potere che ha origini storiche e sociologiche. In realtà l'uomo dello spirito si è sempre e ovunque trovato in una situazione di dipendenza totale dal potere. Era ed è abituato a metterlo in discussione spiritualmente, a sottoporlo alla sua analisi critica: e nello stesso istante tuttavia a capitolare di fronte a esso. La capitolazione era inevitabile quando al potere nemico non si opponeva alcunché di tangibile. Fuori potevano anche esserci enormi eserciti che combattevano l'annientatore, ma nel Lager se ne avevano notizie vaghe e non ci si voleva credere più di tanto. Davanti al prigioniero s'innalzava mostruosa e insuperabile la rappresentazione del potere dello stato delle S.S., una realtà che non era possibile eludere e che perciò in ultima analisi appariva "ragionevole". In questo senso chiunque, quale che fuori fosse stata la sua posizione spirituale, nel Lager diveniva un hegeliano: lo stato delle S.S. nel fulgore metallico della sua totalità appariva come uno stato in cui l'idea si era realizzata.
A questo punto è d'uopo fermarsi e aprire una parentesi per parlare del prigioniero di convinzioni "religiose" o "politico-ideologiche", la cui posizione si differenziava sensibilmente da quella del prigioniero intellettuale e umanista.
Dapprima qualche riflessione personale: ero agnostico quando finii in prigione e in campo di concentramento, e da agnostico, liberato il 15 aprile 1945 a Bergen-Belsen dagli inglesi, lasciai l'inferno. In nessun momento ho potuto scorgere in me la possibilità della fede, nemmeno quando mi trovavo legato in cella di isolamento, e, sapendo che su di me pesava l'accusa di "Zersetzung der Wehrkraft" [disfattismo], mi aspettavo in ogni istante di essere condotto davanti al plotone d'esecuzione. Né sono mai stato un seguace impegnato, o vicino a una determinata ideologia politica. Tuttavia devo ammettere di aver avuto, e di avere ancora, una profonda ammirazione e per i compagni religiosi e per quelli politicamente impegnati. Potevano essere più o meno «spirituali» nel senso che abbiamo voluto dare al termine, non aveva alcuna importanza. La fede politica o religiosa nei momenti decisivi era per loro un prezioso sostegno, mentre noi intellettuali scettico-umanistici invano invocavamo i nostri numi letterari, filosofici, artistici. Marxisti militanti, testimoni di Geova settari, cattolici praticanti, eruditissimi economisti e teologi ma anche operai e contadini meno dotti, a tutti loro la fede o l'ideologia forniva quel punto d'appoggio nel mondo che consentiva loro di scardinare spiritualmente lo stato delle S.S. In condizioni indicibilmente difficili dicevano messa, e, sebbene tutto l'anno fossero costretti a sopportare i tormenti della fame, da ebrei ortodossi digiunavano il giorno dell'Espiazione. Analizzavano in termini marxisti il futuro dell'Europa, oppure affermavano ostinatamente che l'Unione Sovietica avrebbe certamente vinto. Sopravvissero meglio o morirono con maggiore dignità dei loro compagni intellettuali non credenti o apolitici, sovente tanto più colti e avvezzi al pensiero esatto. Rivedo il giovane prete polacco che non conosceva nessuna delle lingue vive a me note e che quindi della sua fede mi parlava in latino. «Voluntas hominis it ad malum», diceva, e preoccupato osservava un Kapo noto e temuto picchiatore che passava nei pressi. «La misericordia di Dio però è infinita e per questo trionferà.» I compagni legati da un vincolo religioso o politico non si stupivano, o si stupivano poco, del fatto che nel campo l'inimmaginabile divenisse realtà. Essendosi allontanata da Dio, l'umanità doveva arrivare al punto di commettere e subire le atrocità di Auschwitz, dicevano i cristiani e gli ebrei credenti. Giunto al suo ultimo stadio, quello del fascismo, il capitalismo deve necessariamente sterminare l'umanità, affermavano i marxisti. Nel campo non avveniva nulla di inaudito, solo ciò che gli uomini ideologicamente preparati o credenti, da sempre si aspettavano o avevano comunque ritenuto possibile. La realtà concreta, di fronte alla quale entrambi, cristiani e marxisti, già in precedenza si erano posti con generosità, veniva affrontata anche in questa occasione con un distacco che imponeva rispetto ma al contempo costernava. Il loro regno non era nel presente bensì nel domani e in un luogo imprecisato: il domani millenaristico e assai lontano dei cristiani, e quello utopistico, terreno, dei marxisti. La morsa della realtà dell'orrore era meno forte laddove la realtà da sempre era inserita in uno schema spirituale fisso. La fame non era semplicemente fame, bensì conseguenza necessaria della negazione di Dio o del marciume capitalistico. Le percosse o la camera a gas erano la rinnovata passione del Signore o il naturale martirio politico: così avevano sofferto i primi cristiani, così i contadini dissanguati durante la guerra dei contadini in Germania. Ogni cristiano era un san Sebastiano, ogni marxista un Thomas Mźnzer.
Noi, gli intellettuali scettico-umanisti, eravamo disprezzati da entrambi, da cristiani e marxisti, dai primi con clemenza, dai secondi con impazienza e rudezza. In certi momenti mi chiedevo se il disprezzo non avesse una sua ragione d'essere. Non che per me avessi desiderato, o anche solo ritenuta possibile, la fede politica o religiosa. Non ne volevo sapere di una grazia della fede che per me non era tale, né di un'ideologia della quale credevo di avere riconosciuto gli abbagli e le errate conclusioni. Non volevo fare parte della loro schiera, della schiera dei compagni credenti, ma avrei desiderato essere imperturbabile, tranquillo, forte come loro. Quanto allora credetti di comprendere, ancora oggi mi pare una certezza: l'essere umano che nel senso più ampio è credente, travalica sé stesso, che la sua fede sia metafisica o immanentistica. Egli non è prigioniero della sua individualità e partecipa invece a una continuità spirituale che non viene mai interrotta, nemmeno ad Auschwitz. Egli è al contempo più estraneo e più vicino alla realtà di chi è senza fede. Più estraneo perché la sua posizione finalistica lo porta a trascurare i contenuti di realtà esistenti e a fissare la sua attenzione su un futuro più o meno prossimo; più vicino alla realtà tuttavia perché proprio per questo motivo non si lascia sopraffare dalla situazione di fatto in cui è coinvolto, e può così a sua volta vigorosamente incidere sulla stessa. Per l'uomo privo di fede la realtà è nel peggiore dei casi un dominio che subisce, nel migliore, è materiale da analizzare. Per il credente è creta che egli plasma, ufficio cui adempie.
E' quasi superfluo aggiungere che in Lager fra le due nature, quella credente e quella non credente, non poteva esservi una profonda comprensione, così come non esisteva all'esterno. I compagni di fede religiosa o politica ci ignoravano, chi con spirito caritatevole e tollerante, chi con rabbia. «Ti sarai reso conto - mi disse una volta un ebreo credente - che la vostra intelligenza e la vostra cultura qui non hanno valore. Io invece ho la certezza che il nostro Dio ci vendicherà.» Un compagno tedesco di estrema sinistra, in campo di concentramento sin dal 1933, si espresse con maggior vigore: «Eccovi qui, borghesi di merda sputasentenze, a tremare davanti alle S.S. Noi non tremiamo e anche se ci tocca crepare, sappiamo comunque che dopo di noi i compagni metteranno al muro tutta la banda.» Entrambi travalicavano sé stessi e si proiettavano nel futuro. Non erano monadi chiuse in sé stesse, bensì aperte, verso un mondo che non era il mondo di Auschwitz.
E' certo che un simile atteggiamento colpiva profondamente gli intellettuali non credenti. Gli esempi di conversione di cui sono a conoscenza sono tuttavia rari. Lo scettico uomo dello spirito solo in casi eccezionali si faceva cristiano o marxista militante seguendo l'esempio di qualche compagno. Di norma prendeva le distanze, dicendosi che sebbene ammirevole e salvatrice, quella degli altri era pur sempre un'illusione. Talvolta si ribellava furioso alla pretesa di sapere mostrata dai compagni credenti. Affermare l'infinita bontà di Dio gli appariva scandaloso di fronte alla presenza di un cosiddetto "LagerŠltester" [anziano del campo], un incallito criminale tedesco di gigantesche dimensioni, del quale si sapeva che aveva letteralmente calpestato a morte alcuni prigionieri. Analogamente gli appariva vergognosamente gretta l'insistenza dei marxisti nel definire le S.S. le truppe difensive della borghesia e il campo un normale frutto del capitalismo, quando chiunque fosse nel pieno delle sue facoltà mentali doveva rendersi conto che Auschwitz nulla aveva a che fare con il capitalismo o con qualsiasi altro sistema economico, e che era invece il parto di cervelli malati e di sistemi emozionali pervertiti. Si poteva rispettare i compagni credenti e tuttavia, scuotendo la testa, mormorare: «che illusione, che illusione!» Gli intellettuali però si facevano piccoli piccoli e non trovano alcun argomento quando gli altri, come si è detto in precedenza, rimproveravano loro l'astrattezza dei valori dello spirito. E con questo chiudo la parentesi e ritorno al ruolo dello spirito ad Auschwitz per ripetere chiaramente quanto detto in precedenza: lo spirito, a meno che non si aggrappasse a una fede religiosa o politica, non serviva o serviva molto poco. Ci abbandonava a noi stessi. Ci sfuggiva proprio nei momenti in cui si trattava di quelle cose che un tempo si sarebbero dette «ultime».
L'uomo dello spirito, ad Auschwitz, come si poneva ad esempio di fronte alla morte? Un argomento ampio, complesso che in questa sede possiamo affrontare solo a grandi linee. Tutti sanno, credo, che il prigioniero del Lager non viveva porta a porta, ma addirittura nella stessa stanza con la morte. La morte era onnipresente. Le selezioni per le camere a gas avvenivano a intervalli regolari. Per un nonnulla i prigionieri venivano impiccati nella piazza dell'appello e i loro compagni dovevano, «Augen rechts!» [attenti a destra!], sfilare davanti al corpo penzolante, accompagnati da un'allegra marcetta. Si moriva in massa, sul lavoro, nell'infermeria, nel bunker, nelle baracche. Ricordo momenti in cui passavo noncurante sopra mucchi di cadaveri; eravamo tutti troppo deboli e troppo indifferenti anche solo per trascinare i morti fuori dalla baracca. Ma tutto ciò, ripeto, è noto sino alla nausea, fa parte delle atrocità citate in apertura, che mi hanno amichevolmente consigliato di non stare a ricordare.
Qualcuno forse obietterà che anche il soldato al fronte era costantemente assediato dalla morte e che quindi la morte nel campo non possedeva in fondo un carattere specifico e una sua peculiare problematica. E' necessario aggiungere che il paragone non regge? Come la vita del soldato al fronte, per quanto egli in certe occasioni possa avere sofferto, non è assimilabile a quella del prigioniero del campo, così anche la morte del soldato e la morte del prigioniero sono grandezze incommensurabili. Il soldato dava in sacrificio la propria vita e moriva la morte dell'eroe: il prigioniero quella delle bestie da macello. Il soldato era esposto al fuoco nemico e la sua vita, è vero, non valeva granché; tuttavia lo stato non gli ordinava di morire ma di resistere. Il dovere estremo del prigioniero invece era la morte. La differenza fondamentale consisteva nel fatto che al contrario del prigioniero, il soldato al fronte non era solo bersaglio ma anche "veicolo di morte". Se mi è consentita un'immagine: la morte non era solo la mannaia che lo avrebbe decapitato, ma anche la spada nella sua mano. Gli conservava la facoltà di uccidere anche nell'istante in cui la morte lo ghermiva. La morte era il destino che lo raggiungeva dall'esterno, ma anche volontà che emergeva dal suo intimo: era per lui al contempo minaccia e occasione, mentre per il prigioniero assumeva l'aspetto di una soluzione - la soluzione finale! - matematicamente predeterminata. Erano queste le condizioni in cui l'uomo dello spirito subiva l'impatto con la morte. Davanti a lui era la morte e in lui ancora si agitava lo spirito; questo si confrontava con quella e cercava - per chiarire subito, invano, - di statuire la propria dignità.
Il primo evento era di norma il crollo totale della concezione "estetica" della morte. E' noto a cosa mi riferisco. L'uomo dello spirito, e in particolare l'intellettuale di cultura tedesca, ha in sé una concezione estetica della morte che ha origini remote e i cui impulsi più recenti risalgono al romanticismo tedesco. Possiamo caratterizzarla approssimativamente citando Novalis, Schopenhauer, Wagner, Thomas Mann. Ad Auschwitz non vi era spazio per la morte nella sua forma letteraria, filosofica, musicale. Nessun ponte conduceva dalla morte ad Auschwitz alla "Morte a Venezia". Risultava insopportabile ogni reminiscenza poetica della morte, che si trattasse della «Cara sorella Morte» di Hesse o di Rilke che cantava: «O Signore, dài a ognuno la sua morte.» All'intellettuale la concezione estetica della morte si palesò come espressione di una "vita" estetizzante: dove questa era ormai pressoché dimenticata, anche quella risultava un'elegante futilità. Nel campo, alla morte non s'accompagnava la musica del Tristano, ma solo le urla delle S.S. e dei Kapo. Poiché la morte di un essere umano a livello sociale era un avvenimento che dalla cosiddetta sezione politica del Lager veniva registrato semplicemente con la formula "Abgang durch Tod" [letteralmente: abbandono (del campo) causa decesso], anche a livello individuale essa finì per perdere tanto del suo valore specifico che la sua veste estetica, per colui che l'attendeva divenne in un certo senso una provocazione impudente e, nei confronti dei compagni, sconveniente.
Una volta crollata la concezione estetica della morte, il prigioniero intellettuale si trovava disarmato al suo cospetto Se cercava di stabilire comunque un rapporto spirituale e metafisico con la morte, tornava a scontrarsi con la realtà del Lager che impediva ogni tentativo in questa direzione. Cosa avveniva concretamente? Per dirla nel modo più conciso e banale: al pari del suo compagno non spirituale, anche il prigioniero intellettuale si occupava non della morte, ma del "morire"; il problema nel suo complesso veniva così ridotto a una serie di considerazioni concrete. Nel Lager si narrava ad esempio di una S.S. che aveva sbudellato un detenuto riempiendogli poi la pancia di sabbia. E' evidente che di fronte a simili possibilità non ci si occupava quasi più del "se" o del fatto "che" si dovesse morire, ma solo del "come" sarebbe avvenuto. Si discuteva di quanto tempo impiegasse il gas a fare il suo effetto. Si speculava sulla dolorosità della morte provocata da iniezioni di acido fenico. Era preferibile un colpo sul cranio o la lenta morte per sfinimento in infermeria? E' significativo dell'atteggiamento dei prigionieri nei confronti della morte che solo pochi abbiano deciso di «correre verso il filo», ossia di suicidarsi toccando il filo spinato attraversato dall'alta tensione. Il filo era in fondo una soluzione buona e abbastanza sicura, sebbene vi fosse la possibilità di essere scorti anzitempo, e di finire quindi nel bunker, il che significava morire con maggiori difficoltà e sofferenze. Il morire era onnipresente, la morte si sottraeva.
E' vero che l'angoscia della morte è ovunque sostanzialmente angoscia di morire, e anche per il campo vale ciò che una volta disse Franz Borkenau, e cioè che l'angoscia della morte è il timore di soffocare. Tuttavia quando si è liberi è possibile pensare alla morte senza per forza pensare al morire, senza essere angosciati dal morire. In una condizione di libertà la morte a livello spirituale può, almeno in linea di principio, essere sganciata dal morire: in senso sociale, proiettando su di essa considerazioni sulla famiglia che rimane, sul lavoro che si lascia, e in senso filosofico attraverso lo sforzo di avvertire nell'esistere un alito del Nulla. Superfluo aggiungere che un simile tentativo non porta ad alcun risultato, che la contraddizione della morte è irrisolvibile. In ogni caso però l'anelito trova in sé stesso la propria dignità: nei confronti della morte l'uomo libero può assumere una determinata posizione spirituale perché per lui la morte non si risolve totalmente nell'affanno del morire. L'uomo libero può avventurarsi sino al confine dell'immaginabile perché in lui esiste un sia pure limitatissimo spazio sgombro da angoscia. Per il prigioniero invece la morte non possedeva alcun aculeo: un aculeo che facesse male, che lo spingesse a riflettere. Forse così si spiega perché il prigioniero del campo - e la considerazione vale per tutti, intellettuali e non - abbia conosciuto sì la straziante paura di fronte a determinati modi di morire, ma non la vera e propria angoscia della morte. Se mi è consentito parlare della mia esperienza personale, vorrei assicurare che non ho mai pensato di essere particolarmente coraggioso e che probabilmente non lo sono. Ciò nonostante, quando un giorno, dopo alcuni mesi di campo di punizione, fui prelevato dalla cella e la S.S. mi assicurò gentilmente che sarei stato fucilato, accettai la comunicazione con assoluta imperturbabilità. «Hai paura, eh?» aggiunse quel tale che aveva solo voluto divertirsi un po'. «Sì», risposi io, ma più per compiacerlo e per non provocare, deludendo le sue aspettative, una reazione brutale. No, non avevamo paura della morte. Ricordo con chiarezza come i compagni nelle cui baracche erano previste le selezioni per le camere a gas, non parlassero di queste, bensì, con tutti i segni del timore e della speranza, della consistenza della zuppa che doveva essere distribuita. La realtà del Lager trionfava facilmente sulla morte e sull'insieme delle cosiddette questioni ultime. Anche qui lo spirito s'imbatteva nei limiti che gli erano posti.
Tutti i problemi che per convenzione linguistica definiamo «metafisici», divenivano inconsistenti. Anche in questo caso però, non era l'abulia a rendere impossibile la riflessione, bensì, al contrario, la crudele perspicacia di un intelletto affilato e temprato dalla realtà del Lager. Si aggiunga che venivano a mancare le energie emozionali grazie alle quali si sarebbe magari potuto dare contenuto, e quindi rendere sensati a livello soggettivo e psicologico, vaghi concetti filosofici. Di tanto in tanto qualcuno si ricordava magari di quel tristo mago del paese degli alemanni, il quale aveva detto che agli umani l'Ente apparirebbe solo attraverso la luce dell'Essere, ma che essi pensando al primo avrebbero scordato il secondo. L'Essere, certo, certo. Evidentemente però nel Lager era più facile rendersi conto che l'Ente e la luce dell'Essere erano del tutto inservibili. Si poteva "essere" affamati, "essere" stanchi, "essere" ammalati. Affermare semplicemente che si "era", non aveva senso. E l'Essere poi, era un concetto definitivamente imponderabile e quindi vuoto. Andare con le parole al di là dell'esistenza reale, ai nostri occhi divenne un lusso a noi vietato, un gioco privo di valore, addirittura beffardo e malvagio. Il mondo fenomenico ci dimostrava in ogni istante che alla sua insopportabilità si poteva rispondere solo con mezzi ad essa immanenti. Detto altrimenti: in nessun altro posto al mondo la realtà possedeva una tale forza operante come nel Lager, in nessun altro luogo essa era così fortemente realtà. In nessun altro luogo il tentativo di oltrepassarla si è dimostrato tanto vano e scontato. Al pari dei muri muti e delle banderuole che stridono al vento della poesia, anche le asserzioni filosofiche smarrivano la loro trascendenza e di fronte a noi si trasformavano in parte in constatazioni oggettive, in parte in vacuo cicaleccio: dove ancora significavano qualcosa, apparivano banali, e dove non erano banali, non significavano più nulla. Per riconoscere questo stato di cose non necessitavamo di alcuna analisi semantica né di una sintassi logica: era sufficiente vedere le torrette di guardia, sentire l'odore di grasso bruciato proveniente dai crematori.
Lo spirito nella sua totalità nel Lager si dichiarava incompetente. Rinunciava a porsi come strumento utile ad affrontare i problemi che ci venivano posti. Tuttavia - e qui tocco un punto essenziale - esso tornava utile al "superamento di sé", e non era cosa da poco. Non bisogna infatti pensare che l'intellettuale - a meno che non fosse fisicamente distrutto avesse smarrito la sua spiritualità o fosse ormai incapace di pensare. Era vero il contrario. Il pensiero solo raramente si concedeva un attimo di requie. Tuttavia superava sé stesso, giungendo pressoché a ogni passo che faceva a confini per lui non oltrepassabili. In questo processo andavano in frantumi le coordinate dei suoi tradizionali sistemi di riferimento. La bellezza era un'illusione. La conoscenza si rivelava un gioco sui concetti. La morte si celava dietro tutta la sua inconoscibilità.
Forse qualcuno, se avessimo occasione di discorrere insieme, mi chiederebbe cosa l'uomo dello spirito dal Lager ha potuto trasferire in questo nostro mondo che con molta presunzione chiamiamo «normale», cosa ha imparato, quale patrimonio spirituale io ho conservato dal periodo trascorso nel Lager. Voglio provare a dare una risposta che forse però ho già fornito in quanto ho detto sinora.
Innanzitutto qualche negazione. Ad Auschwitz non siamo divenuti più saggi, se per saggezza s'intende una conoscenza positiva del mondo: nulla di quanto comprendemmo nel Lager non avremmo potuto comprenderlo anche fuori; nulla si trasformò in un'utile guida. Neanche nel campo siamo diventati più «profondi», ammesso che la fatale profondità sia una dimensione spiritualmente definibile. Inutile aggiungere, credo, che ad Auschwitz non siamo nemmeno divenuti migliori, più umani, più "benevoli" nei confronti dell'uomo e più maturi moralmente. Non si assiste a fatti e misfatti dell'uomo disumanizzato senza che vengano messe in discussione tutte le idee circa l'innata dignità dell'uomo. Dal Lager uscimmo denudati, derubati, svuotati, disorientati e ci volle molto tempo prima che riapprendessimo il linguaggio quotidiano della libertà. Ancora oggi del resto nel parlarlo siamo a disagio e senza un'autentica fiducia nella sua validità.
E tuttavia per noi - e dicendo noi intendo gli intellettuali privi di fede e non impegnati in una dottrina politica - la permanenza nel Lager spiritualmente non fu del tutto priva di valore. Vi abbiamo infatti tratto l'incrollabile convinzione che lo spirito in gran parte è effettivamente un "ludus" e che noi non siamo, o meglio, prima di entrare nel Lager, non eravamo che "homines ludentes". Ci siamo così spogliati di parecchie presunzioni, di parecchia boria metafisica, smarrendo però anche gran parte della nostra ingenua gioia spirituale, e qualche fittizio senso della vita. In "Le parole", Jean-Paul Sartre a un certo punto scrive di avere impiegato trent'anni per sbarazzarsi del tradizionale idealismo filosofico. Noi, posso garantirlo, abbiamo fatto più in fretta. Di solito qualche settimana di permanenza nel Lager era sufficiente per provocare questo disincanto verso l'inventario filosofico, per il quale spiriti magari infinitamente più dotati e acuti devono lottare un'intera vita.
Oso quindi affermare che lasciando Auschwitz non eravamo più saggi e più profondi, ma certamente più accorti. «La profondità di pensiero non ha mai rischiarato il mondo; è la chiarezza di pensiero a penetrarlo più profondamente», ha detto una volta Arthur Schnitzler. Per assimilare questa accortezza il luogo più adatto era il Lager e in particolare Auschwitz. Mi sia consentito citare anche un altro austriaco, Karl Kraus, che nei primi anni del Terzo Reich ha affermato: «Il verbo perì, quando si destò quel mondo.» Kraus tuttavia difendeva questo «verbo» metafisico, mentre noi ex prigionieri dei Lager riprendiamo la sua sentenza per esprimere il nostro "scetticismo" nei confronti di questo «verbo». Il verbo perisce ogni qual volta una realtà pretende di essere totalità. Per noi è perito da molto tempo ormai. E non ci è rimasta nemmeno la sensazione che dovessimo dolerci della sua scomparsa.