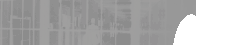A PROPOSITO DELLA PRIGIONE DI ATTICA
(1974).
["Michel Foucault on Attica", intervista con J. K. Simon, in «Telos», n. 19, primavera 1974, p.p. 154-161. (Intervista realizzata sulla base di una conversazione registrata su nastro dopo una visita alla prigione di Attica nell'aprile 1972; trad. francese di F. Durand-Bogaert)].
"Abbiamo da pochissimo visitato la prigione di Attica, e io so che oltre ai suoi lavori sull'esclusione - l'esclusione dei malati, dei folli, l'esclusione in tutte le sue forme - lei si interessa da un anno, un anno e mezzo, alla riforma delle prigioni in Francia. Mi piacerebbe conoscere le sue reazioni a questa visita. Credo che sia la prima volta che lei visita una prigione".
In fede mia sì, dato che in Francia non si ha il diritto di visitare le prigioni. Non si può entrare in una prigione se non si è carcerati, guardiani o avvocati. Di fatto non ho mai appartenuto a una di queste tre categorie. La polizia non mi ha mai trattenuto per più di dodici ore: non ho dunque avuto mai l'occasione di fare veramente conoscenza con le prigioni francesi. E' grazie a lei che ho potuto per la prima volta penetrare in una prigione; è certo che per un francese la visita di Attica è un'esperienza terrificante. Benché io non sia mai entrato in una prigione francese ne ho molto sentito parlare da gente che vi aveva soggiornato, e so che sono luoghi vetusti e decrepiti, in cui i prigionieri sono sovente ammassati gli uni sugli altri in celle di una sporcizia ripugnante.
Attica evidentemente non è affatto una prigione di questo genere. Quel che mi ha colpito forse prima di tutto ad Attica è l'entrata, questa specie di fortezza fittizia in stile Disneyland. Dietro questo paesaggio grottesco che schiaccia tutto il resto, si scopre che Attica è una immensa macchina. E' questo aspetto macchina che maggiormente colpisce, questi interminabili corridoi pulitissimi e ben riscaldati che impongono a coloro che li percorrono delle traiettorie ben precise, calcolate evidentemente per essere le più efficaci possibile e al contempo le più facili da sorvegliare, le più dirette. Sì... e tutto questo termina con degli immensi laboratori, come il laboratorio di metallurgia, dove tutto è pulitissimo e sembrerebbe prossimo alla perfezione. Un ex detenuto di Attica, che ho incontrato l'altro ieri, mi ha detto che questi famosi laboratori, che sono così pronti a mostrarvi, sono pericolosissimi, che numerosi detenuti vi sono stati feriti. Ma a prima vista l'impressione che se ne ha è quella di visitare qualcosa di più che una semplice officina - di visitare una macchina, l'interno di una macchina.
Allora naturalmente la questione che si pone è: che cosa produce la macchina? A che serve questa gigantesca installazione e cosa ne viene fuori? All'epoca in cui sono stati concepiti Auburn e la prigione di Filadelfia, che sono serviti da modello (fino a oggi con poche modifiche) alle grandi macchine d'incarcerazione, si credeva che effettivamente la prigione producesse qualcosa: degli uomini virtuosi. Ma si sa oggi, e l'Amministrazione ne è perfettamente cosciente, che la prigione non produce niente di questo genere. Che essa non produce niente di niente. Che si tratta unicamente di uno straordinario gioco di destrezza, di un meccanismo del tutto singolare di eliminazione circolare: la società elimina spedendole in prigione delle persone che la prigione spezza, schiaccia, elimina fisicamente: una volta che queste persone sono state spezzate, la prigione le elimina liberandole, rimandandole nella società; qui la loro vita in prigione, il trattamento che hanno subìto, lo stato in cui ne sono usciti, tutto concorre a fare sì che immancabilmente la società li elimini di nuovo, rispedendoli in prigione, la quale eccetera. Attica è una macchina per eliminare, una specie di enorme stomaco, un rene che consuma, distrugge, macina e poi rigetta - e che consuma al fine di eliminare quello che è già stato eliminato. Lei si ricorda che, quando abbiamo visitato Attica, ci hanno parlato delle quattro ali della costruzione, e dei quattro corridoi, i quattro grandi corridoi A, B, C, e D. Ebbene ho saputo, sempre dallo stesso ex detenuto, che ne esisteva un quinto, di cui non ci hanno parlato, il corridoio E. Lei sa a cosa serviva questo corridoio?
"No".
E' semplicemente la macchina della macchina o piuttosto dell'eliminazione, dell'eliminazione al secondo grado: l'ala psichiatrica. E' lì che si mandano quelli che non si riescono a integrare nella macchina e che la macchina non riesce ad assimilare secondo le sue norme: quelli che il suo processo meccanico e inadatto a macinare, rendendo così necessario un altro meccanismo.
"Lei ha studiato il processo di esclusione come una sorta di processo astratto, e io so che l'interno degli ospedali, come quello di un certo numero di istituzioni, le è familiare. Avere visitato un posto come Attica - voglio dire essercisi fisicamente trovato - provoca un mutamento affettivo nel suo atteggiamento riguardo il processo d'esclusione? O la visita non fa che rafforzare le sue idee sull'esclusione?"
Penso piuttosto che le abbia fatte vacillare; comunque sia, è emerso un problema che è abbastanza diverso da quelli su cui ho riflettuto precedentemente; è possibile che il cambiamento non sia stato interamente determinato dalla visita, ma essa l'ha certamente affrettato. Finora io consideravo l'esclusione dalla società come una sorta di funzione generale un po' astratta, e mi piaceva pensare a questa funzione come un elemento, per così dire, costitutivo della società - ogni società non potendo funzionare che a condizione che un certo numero dei suoi membri ne siano esclusi. La sociologia tradizionale, vale a dire la sociologia di tipo durkheimiano, pone il problema nella maniera seguente: come può creare la società una coesione tra gli individui? Qual è la forma di rapporto, di comunicazione simbolica o affettiva che si stabilisce tra gli individui? Qual è il sistema di organizzazione che permette alla società di costituire una totalità? Per quanto mi riguarda mi sono in qualche sorta interessato al problema inverso, o se lei preferisce, alla risposta inversa: attraverso quale sistema di esclusione, eliminando chi, creando quale divisione, attraverso quale gioco di negazione e di rifiuto la società può cominciare a funzionare?
Ora invece pongo il problema in termini opposti: la prigione è un'organizzazione troppo complessa perché la si riduca a funzioni puramente negative, di esclusione; il suo costo, la sua importanza, la cura che ci si prende nell'amministrarla, le giustificazioni che si tenta di fornirne, tutto questo sembra indicare che essa possegga delle funzioni positive. Il problema diventa allora scoprire che ruolo la società capitalista assegna al suo sistema penale, quale è lo scopo cercato, quali effetti producono tutte queste misure di castigo e di esclusione. Qual è il posto che esse occupano nei processi economici, quale importanza hanno nell'esercizio e nella conservazione del potere; quale ruolo giocano nei conflitti di classe.
"Mi chiedevo appunto fino a che punto lei abbia potuto rimanere sensibile al contesto politico mentre percorrevamo i corridoi di Attica. Io per quanto mi riguarda ero, sotto il profilo umano, talmente sgomentato dall'impressione di sofferenza latente e di repressione, che ci sono stati dei momenti, per paradossale che possa essere, che ho dimenticato completamente il contesto politico".
Mi è molto difficile rispondere alla domanda sull'orrore umano, e in effetti persino fisico, che emana da Attica. Credo di avere avuto la sua stessa impressione; solo sono forse un po' meno sensibile di lei, oppure un po' più coriaceo. Quando un francese circola in questi lunghi corridoi che, lo ripeto, colpiscono per la loro pulizia, ha l'impressione di entrare in una scuola privata o religiosa un po' austera; dopo tutto i licei e i collegi del diciannovesimo secolo non erano per nulla più attraenti. Ma, al fondo, quando ci ripenso, quello che mi è parso più terrificante ad Attica, è lo strano rapporto tra il centro e la periferia. Penso a questo doppio gioco di sbarre. Quelle che separano la prigione dall'esterno, e quelle che, all'interno della prigione, isolano ogni cella individuale da quella che le è vicina. Per quanto riguarda le prime, le sbarre delle cancellate, so benissimo con quale argomento le giustificano i teorici della prigione: bisogna proteggere la società. (Si potrebbe dire beninteso che i pericoli più grandi che minacciano la società non sono rappresentati dai ladri di automobili, ma dalle guerre, dalla fame, da tutti quelli che le autorizzano e le provocano, ma procediamo oltre...) Una volta superata questa prima serie di sbarre, si potrebbe immaginare di trovare un luogo in cui si riadattano i prigionieri alla vita comunitaria, al rispetto della legge, alla pratica della giustizia. In luogo di questo cosa si scopre? Che il luogo in cui i detenuti passano da dieci a dodici ore al giorno, il luogo che considerano come il loro, è una spaventosa gabbia per animali di circa un metro e mezzo per due, interamente chiusa da sbarre su di un lato. Il posto in cui sono soli, in cui dormono e leggono, si vestono e provvedono ai loro bisogni, è una gabbia per animali selvaggi. E' in questo che risiede tutta l'ipocrisia della prigione. Viene il sospetto che il rappresentante dell'Amministrazione che guida la visita commenti tra sé e sé, sembra quasi di sentirlo dire qualcosa di questo genere: «Ci avete affidato questi ladri e questi assassini perché voi li consideravate come bestie selvagge; ci avete chiesto di farne dei docili montoni, dall'altra parte delle sbarre che vi proteggono; ma non c'è nessuna ragione per cui noi, guardiani, rappresentanti della legge e dell'ordine, strumenti della vostra morale e dei vostri pregiudizi, non li consideriamo anche, su vostro suggerimento, come delle bestie selvagge. Noi siamo come voi, noi siamo voi. E dunque in questa gabbia in cui ci avete rinchiuso con loro, ristabiliamo tra loro e noi il rapporto di esclusione e di potere che la grande prigione instaura tra loro e voi. Siete stati voi a designarli come bestie selvagge; a nostra volta noi ritrasmettiamo loro il messaggio. E quando l'avranno ben appreso dietro le loro sbarre, noi ve li rimanderemo».
E' solo con l'azione collettiva, con l'organizzazione politica, con la ribellione che i detenuti potranno sfuggire a un simile sistema di addomesticamento. Sembra che le prigioni americane possano essere, ben più facilmente che non le prigioni europee, un luogo di azione politica. Le prigioni americane infatti svolgono un duplice ruolo: quello di luogo di castigo, come ne esistono ormai da secoli, e quello di campo di concentramento, come ne esistevano in Europa durante la guerra, e in Africa durante la colonizzazione europea (in Algeria per esempio nel periodo in cui ci si trovavano i francesi). Non bisogna dimenticare che ci sono negli Stati Uniti più di un milione di detenuti, su una popolazione di duecentoventi milioni di abitanti, contro trentamila in Francia, su una popolazione di cinquanta milioni. La proporzione non è per nulla la stessa. D'altra parte negli Stati Uniti un detenuto su trenta o quaranta è nero; è qui che si vede quale funzione di eliminazione di massa assolva la prigione americana. Il sistema penale, l'insieme del sistema delle proibizioni, comprese le più piccole (come l'abuso di alcol, l'eccesso di velocità, il consumo di hascisc) servono da strumento e pretesto a questa pratica di concentramento radicale. Non sorprende affatto che la lotta politica per la giustizia penale sia stata spinta più oltre negli Stati Uniti che non in Francia.
"Tra le domande che mi pongo c'è quella di sapere se, nel contesto della società americana, non si può considerare la prigione come un simbolo, un microcosmo della società in generale, oppure... Lei ha detto prima che la prigione somiglia alle scuole di una volta..."
In Europa, in Europa...
"Sì in Europa, ma lei ora conosce sufficientemente l'America per avere visto tutti questi «no man's land», questi «terrains vagues» ai bordi delle città, nelle periferie; lei mi ha parlato in termini abbastanza precisi dei drugstore negli aeroporti, di questi luoghi che non somigliano a nessun altro luogo. Beninteso, si trovano dovunque nella nostra società delle sbarre come quelle delle prigioni. Lo scarto tra il centro di una città, tra un ghetto per esempio e una prigione è così grande da non potere concepire la prigione come un elemento normale della società americana? O, al contrario, la prigione non è solo un'estensione di questa società che ne raffigura in certo modo l'estremo?"
Trovo la sua domanda molto pertinente, perché è vero che Attica somiglia molto all'America, almeno all'America come appare agli occhi di un europeo un poco smarrito e non troppo spigliato come me - vale a dire gigantesca, tecnologica, un poco inquietante, con questo aspetto piranesiano che impregna la visione che molti europei hanno di New York. E' vero che quello che abbiamo visto somiglia alla società americana, ma non credo che ci si possa accontentare di dire: «Sì, le prigioni americane sono l'immagine della società americana, proprio come le prigioni europee sono l'immagine della società europea», dato che spinta all'estremo questa frase vuol dire che in fondo noi siamo tutti in prigione; che anche in strada, in fabbrica, in un dormitorio, noi siamo in prigione. E' esatto dire che siamo presi in un sistema di sorveglianza e di punizione continue. Ma la prigione non è solo punitiva, essa è anche uno degli strumenti di un processo di eliminazione. La prigione è l'eliminazione fisica delle persone che ne escono, che ne muoiono - a volte direttamente, e quasi sempre indirettamente -, nella misura in cui non possono più trovare un lavoro, non hanno alcun mezzo di sussistenza, non possono ricostruirsi una famiglia. E, a forza di passare da una prigione all'altra, da un crimine all'altro, essi finiscono per essere realmente eliminati fisicamente.
"Ma allora da dove si comincia a riformare le prigioni? Dato che, come per la guerra del Vietnam, quelli che cercano di riformare le prigioni si ingannano, poiché hanno l'impressione di eliminare il male solo facendone scomparire il sintomo più visibile. Non è illusorio attendersi una riforma dall'interno stesso delle prigioni, le prigioni non sono esse stesse un elemento della struttura sociale, tale che non può riuscire nulla che parta di là?"
Il gruppo che abbiamo costituito in Francia non è prima di tutto e principalmente occupato dalla riforma delle prigioni. Anch'io credo che il nostro progetto sia abbastanza radicalmente differente. In Francia - so che in America, a causa dell'esercito, la situazione è un poco diversa - il sistema penale e di imprigionamento riguarda preferibilmente e in modo insistente una certa frangia della popolazione che non è realmente integrata nella classe operaia, che in una certa misura non è controllata dai grandi sindacati. Ci è stato frequentemente detto - dai rappresentanti di alcune organizzazioni politiche - che il problema delle prigioni non rientrava nel quadro della lotta proletaria. Questo avviene per diversi motivi. Il primo è che la frazione di classe operaia che ha costantemente a che fare con la polizia e con la giustizia è in buona parte costituita da persone che sono fuori dalla fabbrica. Che la loro disoccupazione sia volontaria o involontaria, la loro forma di opposizione alla società borghese non si esprime attraverso manifestazioni, lotte politicamente organizzate o pressioni di tipo professionale o economico come gli scioperi. Il secondo è che la borghesia utilizza spesso questa categoria della popolazione contro i lavoratori: essa ne fa all'occasione, una forza lavoro temporanea, o vi recluta perfino la polizia. Il terzo motivo è che il proletariato è, per quello che concerne il furto e il crimine, la moralità e la legalità, totalmente impregnato dell'ideologia borghese.
Ci troviamo quindi attualmente in una situazione in cui diverse categorie di persone cercano di superare dei conflitti e delle opposizioni che il sistema capitalista ha stabilito e mantenuto tra loro; in cui le lotte che hanno luogo all'interno delle fabbriche sono più legate di quanto non lo fossero in passato alle lotte che si sviluppano all'esterno delle fabbriche (che riguardano l'alloggio, il problema della qualità della vita); in cui si riconosce che la lotta ideologica generale è una parte integrante della lotta politica. Per tutte queste ragioni, l'isolamento di questa frazione della classe operaia, che, in origine, era sotto il dominio della pressione poliziesca, si sta lentamente cancellando. La sua reintegrazione all'interno delle lotte politiche è il primo obiettivo del nostro gruppo.
"A questo proposito penso alla storia di Genet che lei mi ha raccontato riguardo alla distinzione che esisteva tra certe categorie di prigionieri... Questo genere di cose è oggi meglio riconosciuto dal proletariato, sia francese o americano?"
Lei fa evidentemente riferimento a quello che Genet mi ha raccontato un giorno a proposito delle prigioni. Durante la guerra, Genet era detenuto alla Santé; un giorno, doveva essere trasferito a Palazzo di giustizia per la sentenza; all'epoca la consuetudine voleva che si incatenassero i prigionieri a due a due con le manette per condurli a Palazzo di giustizia; nel momento in cui si stava per attaccare Genet a un altro detenuto, questo domandò: «Chi è il tipo cui mi state ammanettando?» e il guardiano rispose «un ladro». Allora l'altro detenuto si irrigidì e disse: «Mi rifiuto. Sono un prigioniero politico, sono comunista e mi rifiuto di essere ammanettato con un ladro». Genet mi ha confidato che a partire da quel giorno ha nutrito non solo diffidenza, ma anche un certo disprezzo nei confronti di tutte le forme di movimento e di azione politica che sono state organizzate in Francia...
"Mi chiedo fino a che punto, da quell'epoca in poi, quelli che si occupano di questioni politiche abbiano preso coscienza dell'assenza di differenziazione tra le diverse categorie di prigionieri? Se hanno preso in considerazione la possibilità che questi altri prigionieri, vittime di problemi sociali che sono all'origine delle loro lotte, non siano anch'essi dei prigionieri politici nel senso pieno del termine, e proprio per questo non rimangano più profondamente prigionieri politici di quanto non lo siano i politici stessi?"
Credo che nel corso del diciannovesimo secolo si sia operata quella che si potrebbe chiamare una mutazione storica. E' quasi certo che in Europa, e in particolare in Francia, i movimenti operai e i loro capofila sono stati costretti, per sfuggire alla repressione poliziesca nella sua forma più violenta e selvaggia, a sottolineare la loro differenza nei confronti dell'insieme della popolazione criminale. Ci si ingegnava a presentare questi movimenti come altrettante organizzazioni di assassini, di sicari prezzolati, di ladri, di alcolizzati. Era dunque necessario per loro mettersi al riparo da queste accuse e sfuggire ai castighi che ne derivavano; anche da qui viene l'obbligo che essi sentirono di assumere, come se fosse loro, la responsabilità di tutto un sistema di moralità che proveniva in realtà dalla classe dirigente, e di accettare in fin dei conti la distinzione borghese tra virtù e vizio, il rispetto della proprietà altrui. Essi si videro costretti a ricreare autonomamente una sorta di puritanesimo morale, che era al contempo una condizione necessaria alla loro sopravvivenza e uno strumento utile nella loro lotta. Questa sorta di rigorismo morale è rimasto come uno dei fondamenti dell'ideologia quotidiana del proletariato, ed è certo che, fino a una data recente, il proletariato e i suoi leader sindacali o politici hanno continuato ad approvare la discriminazione tra prigionieri di diritto comune e prigionieri politici. Dopo tutto non bisogna dimenticare tutte le lotte, tutte gli sforzi che furono necessari nel diciannovesimo secolo perché i rappresentanti dei lavoratori non fossero più trattati come volgari malfattori.
E' da poco in Francia, dal momento in cui sono stati imprigionati alcuni maoisti, che il cambiamento si è operato. Quando i maoisti si sono ritrovati in prigione hanno inizialmente reagito, va detto, un poco come i gruppi politici tradizionali, cioè con dichiarazioni come: «Non vogliamo essere assimilati ai criminali di diritto comune, noi non vogliamo che la nostra immagine si confonda con la loro nell'opinione della gente, e chiediamo di essere trattati come prigionieri politici, che hanno i diritti dei prigionieri politici». C'era qui, credo, un errore politico, che è stato rapidamente percepito; sono cominciate delle discussioni al riguardo, ed è in questo momento che abbiamo fondato il nostro gruppo; i maoisti hanno capito presto che in fin dei conti l'eliminazione mediante la prigione dei prigionieri di diritto comune faceva parte del sistema di eliminazione politica di cui erano loro stessi vittima. Se si fa la distinzione, se si accetta la differenza tra diritto politico e diritto comune, questo vuole dire che fondamentalmente si riconosce la morale e la legge borghese in quel che concerne il rispetto della proprietà altrui, il rispetto dei valori tradizionali. Nella sua definizione più ampia, la rivoluzione culturale implica che, almeno in una società come la nostra non si faccia più differenza tra i criminali di diritto comune e i criminali politici. Il diritto è la politica: è proprio in fondo la borghesia ad avere definito, per ragioni politiche e sulla base del suo potere politico, i principi di quello che si chiama il diritto.
"I maoisti non solo hanno capito il loro errore politico, voglio dire dando al pubblico l'impressione che si consideravano a parte, che volevano continuare a essere una élite in prigione; hanno anche imparato qualcosa che riguarda la politica in senso più ampio".
E' giusto, credo che in quest'occasione la loro comprensione delle cose si sia molto affinata, che essi abbiano scoperto che in fondo tanto l'insieme del sistema morale che l'insieme del sistema penale erano il prodotto di un rapporto di potere instaurato dalla borghesia, e costituivano gli strumenti del mantenimento di questo potere.
"Ascoltandola, mi viene in mente una scena del film «La battaglia di Algeri»: è solo un esempio tra i tanti, ma si osserva, da parte dei rivoluzionari, un certo ascetismo che li porta a rifiutare di darsi alla droga, a considerare la prostituzione con disgusto. Penso a questo film in cui gli eroi sono presentati come esseri purissimi, e uno di loro rifiuta di seguire una prostituta. E' un atteggiamento che d'altronde ancora oggi sembra essere diffuso in Algeria. In che misura questo ascetismo di cui danno prova certi rivoluzionari che vogliono restare puri (e che è verosimilmente il risultato di un'educazione borghese) può essere un tratto che impedisce al vero rivoluzionario di riuscire a farsi accettare in seno a un movimento popolare?"
In risposta alla sua prima domanda si può dire che il rigorismo del rivoluzionario è sicuramente un segno delle sue origini borghesi, o almeno di un'affinità culturale e ideologica con la borghesia. Ritengo nondimeno che conviene ricollegare tutto questo a un processo storico. Fino all'inizio del diciannovesimo secolo mi pare, e anche durante la Rivoluzione francese, le rivolte avvenivano dietro l'impulso comune non solo dei contadini, dei piccoli artigiani e dei primi operai, ma anche di questa categoria di elementi agitati, male integrati nella società, che erano per esempio i banditi delle grandi strade, i contrabbandieri... in breve tutti coloro che il sistema giuridico in vigore, la legge dello Stato aveva respinto. Nel diciannovesimo secolo, nel corso delle lotte politiche che permisero al proletariato di farsi riconoscere come potere con delle esigenze ben precise, e malgrado tutto di sfuggire così all'eliminazione e alla costrizione violenta, si fece strada l'obbligo per questo proletariato di sottolineare la sua diversità da questa altra popolazione agitata. Quando si costituì il sindacalismo operaio, questo dovette, al fine di farsi riconoscere, dissociarsi da tutti i gruppi sediziosi e da tutti quelli che rifiutavano l'ordine giuridico: noi non siamo degli assassini, non attacchiamo né la gente né la produzione; se smettiamo di produrre non è in uno slancio di distruzione totale, ma a causa di esigenze tutte particolari. La moralità familiare, che non era assolutamente diffusa tra i ceti popolari alla fine del diciottesimo secolo, divenne all'inizio del diciannovesimo uno dei mezzi che il proletariato utilizzò per in qualche modo fare ammettere la sua rispettabilità. La virtù popolare, il buon operaio, il buon padre, il buon marito, rispettoso dell'ordine giuridico: tale era l'immagine che dopo il diciottesimo secolo la borghesia lasciava apparire e imponeva al proletariato, al fine di distoglierlo da ogni forma di agitazione o di insurrezione violenta, da ogni tentativo di usurpazione del potere e delle sue regole. Questa immagine in effetti il proletariato la fece sua, e la utilizzò in una maniera che molto spesso fu utile alle lotte. In una certa misura questa moralità ebbe il valore di un contratto di matrimonio tra la piccola borghesia e il proletariato durante tutta la seconda metà del diciannovesimo secolo, dal 1848 fino a Zola e Jaurès.
Per quanto riguarda la sua seconda domanda - sapere se il puritanesimo sia un handicap per il capo rivoluzionario - io rispondo che sì, in generale lo è. Nelle nostre società oggi si trovano - questa è almeno l'opinione del nostro gruppo - autentiche forze rivoluzionarie, che sono costituite appunto da tutti questi ceti male integrati nella società, eternamente respinti, e che a loro volta respingono l'ordine morale borghese. Come possiamo associarci a loro nella battaglia politica se non ci sbarazziamo dei nostri pregiudizi morali? Dopo tutto se si considera il disoccupato inveterato che dichiara «preferisco esser disoccupato piuttosto che lavorare», se si considerano le donne, le prostitute, gli omosessuali, i drogati, c'è qui una forza di contestazione della società che penso non si abbia il diritto di trascurare nella lotta politica.
"Se si segue la logica del suo pensiero si può quasi dire che quelli che lavorano alla riabilitazione dei detenuti sono forse i peggiori nemici della rivoluzione. In questo caso - se mi permette di tornare alla prima domanda - il tipo che ha guidato la nostra visita ad Attica, e che ci ha dato l'impressione di essere un uomo pieno di buone intenzioni, del tutto «corretto» direbbe lei, benché totalmente sprovvisto d'immaginazione - quest'uomo potrebbe forse essere il nemico più pericoloso?"
Penso che quello che lei dice sia del tutto vero. Non ho voglia di approfondire, dato che lei ha già posto molto bene il problema. Detto questo, il responsabile dei programmi culturali che ci ha guidato ad Attica lo ritengo pericoloso in maniera immediata. L'ex detenuto di Attica che ho incontrato subito dopo la nostra visita mi ha detto: «E' uno dei guardiani più perversi».
Ma noi abbiamo anche incontrato degli psicologi, che erano manifestamente ottime persone, molto "liberal", che vedevano le cose da una prospettiva abbastanza giusta. Tuttavia se per loro violare la proprietà altrui, rapinare una banca, prostituirsi, uccidere, andare a letto con un uomo quando si è un uomo, se tutti questi atti sono altrettanti problemi psicologici che essi devono aiutare l'individuo a risolvere, non è questo il segno che fondamentalmente essi sono complici del sistema? Non cercano di mascherare il fatto che in fin dei conti commettere un delitto, commettere un crimine, mette in questione in maniera fondamentale il funzionamento della società? In maniera così fondamentale che noi dimentichiamo che si tratta qui di un problema sociale, che noi riteniamo essere un problema morale e che riguardi il diritto degli individui...
E lei ha ben visto in quale maniera si può presentare il problema. Di modo che sottoscrivo integralmente ciò che lei ha detto, e mi domando se tutto ciò che concerne la reintegrazione, tutto ciò che costituisce una soluzione psicologica o individuale alla questione non mascheri la natura profondamente politica dell'eliminazione di questi individui da parte della società e della loro contestazione di questa società. Tutta questa lotta oscura è, io credo, politica. Il crimine è «un colpo di Stato che viene dal basso». La frase è presa da "I Miserabili".