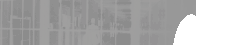2.
Oggi vorrei parlare della storia di Edipo, argomento che da un anno a questa parte è divenuto notevolmente fuori moda. A partire da Freud, si è ritenuto che la storia di Edipo raccontasse la favola più antica del nostro desiderio e del nostro inconscio. Ora, dopo la pubblicazione, l'anno scorso, del libro di Deleuze e Guattari, l'"Anti-Edipo" (8), il riferimento a Edipo gioca un ruolo completamente differente.
Deleuze e Guattari hanno cercato di dimostrare che il triangolo edipico padre-madre-figlio non rivela una verità atemporale e nemmeno una verità profondamente storica del nostro desiderio. Essi hanno cercato di mostrare che questo famoso triangolo edipico costituisce per gli analisti, che lo manipolano nell'ambito della cura, una maniera di contenere il desiderio, di garantire che il desiderio non venga a investirsi, a spargersi per il mondo che ci circonda, il mondo storico; di garantire che il desiderio rimanga all'interno della famiglia e si svolga come un piccolo dramma quasi borghese tra il padre, la madre e il figlio.
Edipo non sarebbe dunque una verità della natura, ma uno strumento di limitazione e costrizione che gli psicoanalisti, a partire da Freud, utilizzano per contenere il desiderio e farlo rientrare in una struttura familiare definita dalla nostra società in un momento determinato. In altre parole, Edipo, secondo Deleuze e Guattari, non è il contenuto segreto del nostro inconscio, ma la forma di costrizione che la psicoanalisi cerca d'imporre, nella cura, al nostro desiderio e al nostro inconscio. Edipo è uno strumento di potere, è un certo modo in cui il potere medico e psicoanalitico si esercitano sul desiderio e sull'inconscio.
Confesso che un problema come questo mi attira molto e che anch'io mi sento tentato di cercare, dietro quella che si pretende sia la storia di Edipo, qualche cosa che ha a che fare non con la storia indefinita, sempre ricominciata, del nostro desiderio e del nostro inconscio, ma piuttosto con la storia di un potere, di un potere politico.
Apro una parentesi per ricordare che tutto ciò che cerco di dire, tutto ciò che Deleuze ha dimostrato con maggiore profondità nel suo "Anti-Edipo", fa parte di un insieme di ricerche che non riguardano, al contrario di ciò che si afferma sui giornali, quella che tradizionalmente si chiama «struttura». Né Deleuze, né Lyotard, né Guattari, né io facciamo mai analisi strutturali, noi non siamo assolutamente «strutturalisti». Se mi si domandasse che cos'è quello che io faccio, e che altri fanno meglio di me, non direi che facciamo una ricerca di struttura. Farei un gioco di parole e direi che facciamo ricerche dinastiche. Direi, giocando con le parole greche "dynamis dynasteía", che noi cerchiamo di fare apparire quello che fino ad ora è rimasto più nascosto, più occultato e più profondamente investito nella storia della nostra cultura: le relazioni di potere. Curiosamente le strutture economiche della nostra società sono meglio conosciute, meglio inventariate, meglio definite delle strutture di potere politico. In questa serie di conferenze mi piacerebbe mostrare in che maniera si sono stabilite, e si sono inserite profondamente nella nostra cultura, le relazioni politiche, dando luogo a una serie di fenomeni che non possono essere spiegati se non li mettiamo in rapporto, non con le strutture economiche, le relazioni economiche di produzione, ma con le relazioni politiche che investono tutta la trama della nostra esistenza.
Desidero mostrare come la tragedia di Edipo, come la si può leggere in Sofocle - lascerò da parte il problema del fondo mitico cui essa si lega - è rappresentativa e in certo modo instauratrice di un determinato tipo di relazione tra potere e sapere, tra potere politico e conoscenza, di cui la nostra civiltà ancora non si è liberata. Mi sembra che ci sia veramente un complesso di Edipo nella nostra civiltà, che non riguarda però il nostro inconscio e il nostro desiderio e nemmeno le relazioni tra desiderio e inconscio. Se c'è complesso di Edipo, questo non si produce a livello individuale, ma collettivo; non a proposito del desiderio e dell'inconscio, ma del potere e del sapere. E' questa specie di «complesso» che mi piacerebbe analizzare.
La tragedia di "Edipo" (9) è, fondamentalmente, la prima testimonianza che abbiamo delle pratiche giudiziarie greche. Come tutti sanno, si tratta di una storia nella quale alcune persone - un sovrano, un popolo -, ignorando una certa verità, riescono, attraverso una serie di tecniche di cui parleremo, a scoprire una verità che mette in questione la sovranità stessa del sovrano. La tragedia di "Edipo" è, quindi, la storia di una ricerca della verità: è una procedura di ricerca della verità che obbedisce esattamente alle pratiche giudiziarie greche di quell'epoca. Per questa ragione il primo problema che si pone è quello di sapere che cosa fosse la ricerca giudiziaria della verità nella Grecia arcaica.
La prima testimonianza della ricerca della verità che abbiamo nella procedura giudiziaria greca risale all'"Iliade". Si tratta della storia della disputa che oppone Antiloco e Menelao durante i giochi organizzati in occasione della morte di Patroclo (10). Tra questi giochi c'è una corsa di carri che, come d'abitudine, si svolgeva in un circuito con andata e ritorno, passando intorno a una pietra cui bisognava passare il più vicino possibile. Gli organizzatori dei giochi avevano collocato in questo posto qualcuno che doveva essere il responsabile della regolarità della corsa, e di cui Omero dice, senza nominarlo personalmente, che egli è il testimone, "ístor", colui che è lì per vedere. Parte la corsa, e in testa al momento di girare ci sono Antiloco e Menelao. Si verifica una irregolarità e, quando Antiloco arriva primo, Menelao protesta e dice al giudice, o alla giuria che deve assegnare il premio, che Antiloco ha commesso un'irregolarità. Contestazione, lite, come stabilire la verità? Curiosamente in questo testo di Omero non ci si appella a chi ha visto, al famoso testimone che stava vicino alla pietra e che avrebbe dovuto attestare quello che era avvenuto. Non lo si convoca per testimoniare e non gli si fa nessuna domanda. C'è solo la contesa tra gli avversari Menelao e Antiloco, che si sviluppa nella maniera seguente: dopo l'accusa di Menelao - «tu hai commesso un'irregolarità» - e la difesa di Antiloco - «io non ho commesso irregolarità» - Menelao lancia una sfida: «Metti la mano destra sulla testa del tuo cavallo; stringi con la mano sinistra la tua frusta e giura davanti a Zeus che non hai commesso irregolarità». A questo punto Antiloco, di fronte a questa sfida, che è una "épreuve", rinuncia alla prova, rinuncia a giurare, e riconosce così che ha commesso un'irregolarità (11).
Ecco una maniera singolare di produrre la verità, di stabilire la verità giuridica. Non si passa attraverso il testimone, ma attraverso una specie di gioco di prova, una sorta di sfida lanciata da un avversario a un altro. Uno lancia una sfida, l'altro deve accettare il rischio o rinunciare. Se per caso egli avesse accettato di correre il rischio, se avesse realmente giurato, la responsabilità di quello che sarebbe accaduto, la scoperta finale della verità, sarebbe stata immediatamente attribuita agli dèi. Sarebbe stato Zeus che, se fosse stato il caso, avrebbe col suo fulmine ristabilito la verità, punendo colui che aveva prestato falso giuramento.
Ecco la pratica vecchia ed estremamente arcaica della prova della verità, che è stabilita giudiziariamente non per mezzo di una constatazione diretta, di un testimone, di un'indagine o di un'inquisizione, ma mediante un gioco di prova. La prova è caratteristica della società greca arcaica. La ritroveremo nell'Alto Medioevo. E' evidente che, quando Edipo e tutta la città di Tebe cercano la verità, non è questo il modello che utilizzano. Sono passati secoli. E' tuttavia interessante osservare che nella tragedia di Sofocle ritroviamo ancora uno o due residui della pratica di stabilire la verità attraverso la prova. Prima di tutto, nella scena tra Creonte ed Edipo. Quando Edipo critica suo cognato per aver troncato la risposta dell'Oracolo di Delfi, dicendo: «Tu inventasti tutto questo semplicemente per togliermi il potere e sostituirmi», Creonte risponde senza tentare di stabilire la verità avvalendosi di testimoni: «Bene, giuriamo. Io giurerò che non ho cospirato contro di te». Tutto questo è detto alla presenza di Giocasta, che accetta il gioco ed è come la responsabile della sua regolarità. Creonte risponde a Edipo secondo la vecchia formula della lite tra guerrieri (12). In secondo luogo, potremmo dire che troviamo in tutta l'opera questo sistema della sfida e della prova. Edipo, quando apprende che la peste che devasta la città di Tebe è dovuta alla maledizione degli dèi, conseguente alla contaminazione e all'assassinio, si impegna a bandire l'autore del crimine senza sapere, naturalmente, che è lui stesso ad averlo commesso. Si trova così avvinto dal suo stesso giuramento, allo stesso modo in cui, nelle rivalità tra guerrieri arcaici, gli avversari si coinvolgevano reciprocamente in giuramenti di promessa e maledizione. Questi resti della vecchia tradizione riappaiono alcune volte nel corso dell'opera. Ma per la verità tutta la tragedia di Edipo è fondata su un meccanismo completamente differente. E' questo meccanismo con cui viene stabilita la verità che vorrei esporre.
Mi pare che questo meccanismo della verità obbedisca inizialmente a una legge, a una specie di forma pura che potremmo chiamare legge delle metà. E' mediante delle metà che si adattano e si incastrano, che procede la scoperta della verità nell'Edipo. Edipo manda a consultare il dio di Delfi, il re Apollo. Se esaminiamo in dettaglio la risposta di Apollo, osserviamo che è formata da due parti. Apollo comincia col dire: «Il paese è colpito da una contaminazione». A questa prima risposta manca, in un certo senso, una metà: c'è una contaminazione, ma chi ha contaminato e chi è stato contaminato? Di conseguenza è necessario porre una seconda domanda, ed Edipo forza Creonte a dare una seconda risposta, domandandogli a che cosa è dovuta la contaminazione. La seconda metà appare: la causa di questa contaminazione è un assassinio. Ma chi dice assassinio dice due cose: dice chi è stato assassinato e chi è l'assassino. Si domanda ad Apollo: «Chi è stato assassinato?». La risposta è: Laio, il re. Si domanda: «Chi l'ha assassinato?». A questo punto Apollo si rifiuta di rispondere, e come dice Edipo: «Non si può forzare la risposta degli dèi». Manca, quindi, una metà. Alla contaminazione corrisponde la metà dell'assassinio, la prima metà: «Chi è stato assassinato», ma manca la seconda metà: il nome dell'assassino.
Per sapere il nome dell'assassino sarà necessario ricorrere a qualcosa, a qualcuno, giacché non si può forzare la volontà degli dèi. Questo altro cui ci si rivolge è il doppio umano, l'ombra mortale di Apollo, è l'indovino Tiresia, che, come Apollo, è un essere divino, "Theios mántis", il divino indovino. Tiresia è molto vicino ad Apollo e anch'egli viene chiamato re, "anas" ma è mortale, mentre Apollo è immortale; e soprattutto Tiresia è cieco, è immerso nella notte, mentre Apollo è il dio del sole. Egli è la metà d'ombra della verità divina, il doppio oscuro che il dio-luce proietta sulla superficie della terra. E' questa metà che si va a interrogare. Tiresia risponde a Edipo dicendo: «Sei tu che hai ucciso Laio».
Di conseguenza, possiamo dire che, dalla seconda scena dell'"Edipo", tutto è stato detto e rappresentato. Si ha già la verità poiché Edipo è effettivamente indicato dall'insieme costituito delle risposte di Apollo da un lato e di Tiresia dall'altro. Il gioco della metà è completo: contaminazione, assassinio, chi è stato ucciso, chi ha ucciso. Abbiamo tutto, ma sotto la forma molto particolare della profezia, della predizione, della prescrizione. L'indovino Tiresia non dice esattamente a Edipo: «Sei stato tu a uccidere»; dice: «hai promesso di esiliare colui che ha ucciso; io ti ordino di tenere fede alla tua promessa e di esiliare te stesso». Allo stesso modo Apollo non aveva detto esattamente: «C'è stata una contaminazione e perciò la città è devastata dalla peste». Apollo ha detto: «Se volete che finisca la peste, è necessario che vi purifichiate dalla contaminazione». Tutto questo è stato detto nella forma del futuro, della prescrizione, della predizione; niente si riferisce all'attualità del presente, niente è indicato direttamente.
Si ha tutta la verità, ma nella forma prescrittiva e profetica che è caratteristica tanto dell'oracolo che dell'indovino. A questa verità che è in un certo modo completa e totale, nella quale tutto è stato detto, manca però qualcosa, che è la dimensione del presente, l'attualità, la designazione di qualcuno. Manca la testimonianza di ciò che è realmente accaduto. Curiosamente, tutta questa vecchia storia è formulata dall'indovino e dal dio nella forma del futuro. Abbiamo bisogno ora del presente e della testimonianza del passato: la testimonianza presente di ciò che realmente è avvenuto.
La seconda metà, passato e presente, di questa prescrizione e di questa previsione, è data dal resto dell'opera. Anch'essa è uno strano gioco di metà. In primo luogo è necessario stabilire chi ha ucciso Laio. Questo è ottenuto nel corso dell'opera dall'abbinamento di due testimonianze. La prima è fornita inavvertitamente e spontaneamente da Giocasta quando dice: «Vedi bene, Edipo, che non sei stato tu a uccidere Laio, contrariamente a ciò che dice l'indovino. La miglior prova di ciò è che Laio fu ucciso da più uomini all'incrocio di tre strade».
A questa testimonianza Edipo risponde con un'inquietudine che è già quasi una certezza: «Uccidere un uomo all'incrocio di tre strade è esattamente ciò che io ho fatto; ricordo che arrivando a Tebe ho ucciso qualcuno all'incrocio di tre strade». Così dal gioco di queste due metà che si completano, il ricordo di Giocasta e quello di Edipo, abbiamo questa verità quasi completa, la verità sull'assassinio di Laio. Verità quasi completa, perché manca ancora un piccolo frammento: la questione di sapere se fu ucciso da un solo o da vari individui, questione che del resto rimane irrisolta nell'opera.
Ma questa è solo la metà della storia di Edipo, poiché Edipo non è solo colui che ha ucciso il re Laio, è anche colui che ha ucciso suo padre, e che, dopo averlo ucciso, ha sposato la propria madre. Questa seconda metà della storia manca ancora dopo l'abbinamento delle testimonianze di Giocasta e di Edipo. Quello che manca è proprio ciò che dà loro un po' di speranza, dato che il dio ha predetto che Laio non sarebbe stato ucciso da una mano qualsiasi, ma dal suo stesso figlio. Ne consegue che, finché non sarà provato che Edipo è figlio di Laio, la predizione non sarà realizzata. Questa seconda metà è necessaria perché la predizione si definisca nella sua totalità, e ciò avviene nell'ultima parte dell'opera, attraverso l'abbinamento di due testimonianze diverse. Una sarà quella dello schiavo che viene da Corinto per annunciare a Edipo che Polibio è morto. Edipo, che non piange per la morte di suo padre, si rallegra dicendo: «Ah, almeno non sono stato io a ucciderlo, al contrario di ciò che dice la predizione». E lo schiavo replica: «Polibio non era tuo padre».
Abbiamo così un nuovo elemento: Edipo non è figlio di Polibio. E' allora che interviene l'ultimo schiavo, quello che era fuggito dopo il dramma e si era nascosto nelle profondità del Citerone, quello che aveva nascosto la verità nella sua capanna, il guardiano di pecore, che è chiamato per essere interrogato sull'accaduto, e dice: «In effetti un tempo diedi a questo messaggero un bambino che veniva dal palazzo di Giocasta e di cui mi hanno detto essere il figlio».
Vediamo che manca ancora l'ultima certezza, giacché Giocasta non è presente per attestare che fu lei a consegnare il bambino allo schiavo. Ma, eccetto che per questa piccola difficoltà, il ciclo è ora completo. Sappiamo che Edipo era figlio di Laio e Giocasta; che è stato consegnato a Polibio; che è stato lui, credendo di essere figlio di Polibio e ritornando, per sfuggire alla profezia, a Tebe - che non sapeva essere la sua patria - a uccidere all'incrocio delle tre strade il re Laio, suo vero padre. Il ciclo è completo. Si è chiuso grazie a una serie di incastri di metà che combaciano le une con le altre. E' come se tutta questa lunga e complessa storia del bambino, che è allo stesso tempo un esiliato che fugge dalla profezia, e un esiliato a causa della profezia, fosse stata spezzata in due parti e poi ogni frammento fosse nuovamente stato spezzato in due, e tutti questi frammenti fossero stati ripartiti in mani diverse. E' stato necessario mettere insieme il dio col suo profeta, Giocasta ed Edipo, lo schiavo di Corinto e quello del Citerone perché tutte queste metà e queste metà delle metà venissero a combinarsi le une con le altre, a combaciare, a incastrarsi e a ricostruire il profilo completo della storia.
Questa forma, realmente impressionante nell'"Edipo" di Sofocle, non è solo una forma retorica. Essa è al contempo religiosa e politica, consiste nella famosa tecnica del "symbolon", il simbolo greco. Uno strumento di potere, di esercizio del potere, che permette al detentore di un segreto o di un potere di rompere in due parti un oggetto qualsiasi, in ceramica, di conservare una delle parti e affidare l'altra a qualcuno che deve portare il messaggio o attestarne l'autenticità. E' facendo combaciare queste due metà che si potrà riconoscere l'autenticità del messaggio, vale a dire la continuità del potere che si esercita. Il potere si manifesta, completa il suo ciclo e mantiene la sua unità, grazie a questo gioco di piccoli frammenti - separati gli uni dagli altri -, di uno stesso insieme, di un unico oggetto, la cui configurazione generale è la forma manifesta del potere. La storia di Edipo è la frammentazione di questa "pièce" (13), il cui possesso integrale, riunificato, rende autentica la detenzione del potere e gli ordini da esso emanati. I messaggi, i messaggeri che invia e che devono ritornare, autenticheranno il loro legame con il potere con il fatto che ognuno di essi possiede un frammento della "pièce" e può adattarlo agli altri frammenti. E' questa la tecnica giuridica, politica e religiosa di quello che i greci chiamano "symbolon": il simbolo.
La storia di Edipo, così come è rappresentata nella tragedia di Sofocle, obbedisce a questo "symbolon": forma non retorica, ma piuttosto religiosa, politica, quasi magica dell'esercizio del potere.
Se noi ora osserviamo non la forma di questo meccanismo, il gioco delle metà che si frammentano e finiscono per combaciare, ma l'effetto prodotto da queste combinazioni reciproche, si vedranno una serie di cose. Prima di tutto, una sorta di spostamento, nella misura in cui le metà vengono a combaciare. Il primo gioco delle metà che combaciano è quello del re Apollo e dell'indovino Tiresia: il livello della profezia o degli dèi. Poi la seconda serie di metà che combaciano, che è costituito da Edipo e Giocasta. Le loro due testimonianze si trovano al centro dell'opera: è il livello dei re, dei sovrani. Infine l'ultima coppia di testimonianze che intervengono, l'ultima metà che viene a completare la storia, che non è costituita dagli dèi e neanche dai re, ma dai servitori e dagli schiavi. Lo schiavo più umile di Polibio e, soprattutto, il più dimenticato dei pastori del bosco del Citerone enunceranno la verità ultima e apporteranno l'ultima testimonianza.
Il risultato è curioso: ciò che era stato detto in termini di profezia all'inizio dell'opera sarà ripetuto sotto forma di testimonianza dai due pastori. E così come l'opera passa dagli dèi agli schiavi, egualmente cambiano i meccanismi di enunciazione della verità o la forma in cui la verità si enuncia. Quando parlano il dio e l'indovino, la verità è espressa in forma di prescrizione e profezia, nella forma di uno sguardo dell'eterno e onnipotente dio Sole, nella forma dello sguardo dell'indovino che, benché cieco, vede il passato, il presente e il futuro. E' questa specie di sguardo magico-religioso che, all'inizio dell'opera, fa brillare una verità a cui né Edipo né il Coro vogliono credere. Anche a livello più basso troviamo lo sguardo, dato che se i due schiavi possono testimoniare è perché hanno visto. Uno ha visto Giocasta consegnargli un bambino perché lo portasse nel bosco e lì lo abbandonasse. L'altro ha visto il bambino nel bosco, ha visto il suo compagno schiavo consegnargli il bambino e ricorda di averlo portato al palazzo di Polibio. Si tratta anche qui dello sguardo, ma non più del grande sguardo eterno, illuminante, abbagliante, folgorante del dio e del suo indovino, ora è lo sguardo di persone che vedono e ricordano di aver visto con i loro occhi umani. E' lo sguardo del testimone. E' a questo sguardo che Omero non fa riferimento nel parlare del conflitto e della lite tra Antiloco e Menelao.
Possiamo dire, quindi, che tutto l'"Edipo" è un modo di spostare l'enunciazione della verità da un discorso profetico e prescrittivo a un altro discorso di ordine retrospettivo, che non appartiene più all'ordine della profezia, ma a quello della testimonianza. E' anche un modo di spostare il lampo o la luce della verità dal balenio profetico e divino, allo sguardo in qualche modo empirico e quotidiano dei pastori. Tra i pastori e gli dèi c'è una corrispondenza: dicono la stessa cosa, vedono la stessa cosa, ma non con lo stesso linguaggio e neppure con gli stessi occhi. In tutta la tragedia vediamo questa stessa verità che si presenta e si formula in due maniere diverse, con altre parole in un altro discorso, con un altro sguardo. Ma questi sguardi si corrispondono. I pastori corrispondono esattamente agli dèi; potremmo persino dire che li simboleggiano. In fondo quello che i pastori dicono è, in un altro modo, ciò che gli dèi hanno già detto.
Abbiamo qui uno dei tratti fondamentali della tragedia di Edipo: la comunicazione tra i pastori e gli dèi, tra il ricordo degli uomini e le profezie divine. Questa corrispondenza definisce la tragedia e stabilisce un mondo simbolico nel quale il ricordo e il discorso degli uomini sono come un margine empirico della grande profezia degli dèi.
Ecco uno dei punti su cui dobbiamo insistere per comprendere il meccanismo della progressione della verità in "Edipo". Da un lato stanno gli dèi, dall'altro i pastori, ma tra i due c'è il livello dei re, o meglio, il livello di Edipo. Qual è il suo livello di sapere e che significa il suo sguardo?
A questo proposito è necessario rettificare alcune cose. Si dice abitualmente, quando si analizza l'opera, che Edipo è colui che non sapeva nulla, che era cieco, che aveva gli occhi velati e la memoria bloccata, dato che non aveva mai menzionato, e anzi sembrava aver dimenticato le sue stesse gesta, aver ucciso il re all'incrocio delle tre strade. Edipo, l'uomo dell'oblio, l'uomo del non-sapere, l'uomo dell'inconscio secondo Freud. Sono noti tutti i giochi di parole che sono stati fatti con il nome di Edipo. Ma non dimentichiamo che questi giochi sono molteplici e che gli stessi greci avevano già notato che in "Oidipoys" abbiamo la parola "oida" che significa allo stesso tempo «aver visto» e «sapere». Mi piacerebbe mostrare che Edipo, in questo meccanismo di "symbolon", di metà che comunicano, di gioco di risposte tra i pastori e gli dèi, non è colui che non sapeva, ma anzi, al contrario, colui che sapeva troppo. Egli riuniva il suo sapere e il suo potere in modo condannabile, ed è proprio questo che la vicenda narrata nell'"Edipo" doveva espellere definitivamente dalla storia.
Il titolo stesso della tragedia di Sofocle è interessante: "Edipo" è "Edipo re", "Oidipoys tyrannos". La parola "tyrannos" è di difficile traduzione. Infatti la traduzione non rende il significato esatto del termine. Edipo è l'uomo del potere, l'uomo che esercita un certo potere. Ed è caratteristico che il titolo dell'opera di Sofocle non sia "Edipo, l'incestuoso", né "Edipo, l'assassino di suo padre", ma "Edipo re". Che cosa significa la regalità di Edipo?
Possiamo rilevare l'importanza della tematica del potere in tutta l'opera: durante tutta la tragedia ciò che è in questione è essenzialmente il potere di Edipo ed è proprio questo a far sì che egli si senta minacciato.
Nel corso dell'intera tragedia, Edipo non dice mai di essere innocente; può darsi che abbia fatto qualcosa, ma è stato contro la sua volontà e quando ha ucciso quell'uomo non sapeva che si trattasse di Laio. Una difesa a livello dell'innocenza e dell'inconsapevolezza non è mai intrapresa dal personaggio sofocleo in "Edipo Re".
Solo nell'"Edipo a Colono" (14) si vedrà un Edipo cieco e miserabile gemere per tutta l'opera dicendo: «Io non potevo fare niente. Gli dèi mi presero in una trappola che non conoscevo».
Nell'"Edipo re", Edipo non si difende affatto sul piano della sua innocenza, il suo problema è solo il potere. Potrà conservarlo? E' il potere in gioco dall'inizio alla fine dell'opera.
Nella prima scena, è nella sua condizione di sovrano che gli abitanti di Tebe hanno fatto ricorso a Edipo contro la peste: «Tu hai il potere, devi guarirci dalla peste». Ed egli risponde dicendo: «Ho grande interesse a liberarvi dalla peste, poiché questa stessa peste che vi colpisce colpisce anche me nella mia sovranità e regalità». Edipo vuole cercare la soluzione del problema in quanto interessato al mantenimento della propria regalità. Quando comincia a sentirsi minacciato dalle risposte che emergono intorno a lui, quando l'oracolo lo designa, e l'indovino dice ancor più chiaramente che egli è il colpevole, Edipo, senza rispondere in termini di innocenza, dice a Tiresia: «Tu vuoi il mio potere; hai ordito un complotto contro di me per privarmi del mio potere» (15).
Edipo non si sgomenta all'idea che potrebbe aver ucciso o suo padre o il re, quello che lo sgomenta è perdere il proprio potere.
Durante la grande disputa con Creonte, gli dice: «Hai portato un oracolo da Delfi ma quest'oracolo lo hai falsato perché tu, figlio di Laio, rivendichi un potere che a me è stato dato» (16). Anche qui Edipo si sente minacciato da Creonte a livello del potere e non a livello della sua innocenza o della sua colpevolezza. Quello che è in questione in tutti questi scontri, dall'inizio dell'opera, è il potere.
E quando alla fine dell'opera la verità è sul punto di essere scoperta, quando lo schiavo di Corinto dice a Edipo: «Non ti inquietare, ma tu non sei il figlio di Polibio» (17), Edipo non si preoccuperà che il non essere figlio di Polibio possa significare essere figlio di qualcun altro, e forse di Laio. Egli dice: «Dici questo per farmi vergognare, per far credere al popolo che sono figlio di uno schiavo; ma anche se sono figlio di uno schiavo, questo non mi impedirà di esercitare il potere; sono un re come gli altri» (18). Ancora una volta è del potere che si tratta. Ed è in quanto capo della giustizia, in quanto sovrano, che Edipo convocherà a questo punto l'ultimo testimone: lo schiavo del Citerone. E' in quanto sovrano che, minacciandolo di tortura, gli strapperà la verità. E quando, una volta strappata questa verità, si conosce chi è Edipo e quello che ha fatto - assassinio del padre, incesto con la madre - che dice il popolo di Tebe? «Noi ti chiamavamo nostro re.» Questo significa che il popolo di Tebe, nello stesso momento in cui riconosce in Edipo colui che è stato il suo re, con l'uso dell'imperfetto - «chiamavamo» - lo dichiara destituito della regalità.
Ciò che è in questione è la caduta del potere di Edipo. La prova di ciò sta nel fatto che quando Edipo perde il potere in favore di Creonte, le ultime battute dell'opera ruotano ancora intorno al potere. L'ultima parola indirizzata a Edipo prima che venga condotto all'interno del palazzo è pronunciata dal nuovo re, Creonte: «Non cercare più di essere il signore» (19). La parola impiegata è "krapein"; il che vuol dire che Edipo non deve più comandare. E Creonte aggiunge ancora "àkrápesas", parola che vuol dire «dopo essere giunto in cima», ma che è anche un gioco di parole nel quale la «a» ha un senso privativo: «non possedendo più il potere»: "àkrápesas" significa al contempo: «Tu che sei salito fino al vertice e che ora non hai più il potere».
Dopo di ciò interviene il popolo e saluta Edipo per l'ultima volta dicendo: «Tu che eri "krátisitos", cioè, «tu che eri al vertice del potere». Il primo saluto del popolo tebano a Edipo era «o kratipoy Oìdipoys» cioè, «Edipo onnipotente!». Tra questi due saluti del popolo si svolge tutta la tragedia. La tragedia del potere e del possesso del potere politico. Ma che cosa e questo potere di Edipo? Come si caratterizza? Le sue caratteristiche sono presenti nel pensiero, nella storia, e nella filosofia greca dell'epoca. Edipo è chiamato "basileus anax", il primo degli uomini, colui che ha la "krateia", colui che detiene il potere, ed è anche chiamato "tyrannos". «Tiranno» non va inteso qui in senso stretto, tanto è vero che Polibio, Laio e tutti gli altri sono stati chiamati anche "tyrannos".
Diverse caratteristiche di questo potere appaiono nella tragedia di Edipo. Edipo ha il potere. Ma lo ha ottenuto attraverso una serie di vicende e di avventure che hanno fatto di lui, all'inizio, l'uomo più miserabile - bambino scacciato, perduto, viaggiatore errante - e in seguito l'uomo più potente. Egli ha conosciuto un destino ineguale. Ha conosciuto la miseria e la gloria. E' stato nel punto più alto quando lo si credeva figlio di Polibio e in quello più basso quando è diventato un personaggio errante di città in città. Più tardi è nuovamente tornato al vertice. «Gli anni che crebbero con me - dice - delle volte mi spinsero in basso e delle altre mi esaltarono.»
Questa alternanza del destino è un tratto caratteristico di due tipi di personaggi. Il personaggio leggendario dell'eroe epico che ha perduto la sua cittadinanza e la sua patria e che dopo un certo numero di prove ritrova la gloria; e il personaggio storico del tiranno greco della fine del secolo sesto e dell'inizio del quinto. Il tiranno era colui che, dopo aver vissuto molte avventure, e dopo essere arrivato al vertice del potere, era sempre minacciato di perderlo. L'irregolarità del destino è caratteristica del personaggio del tiranno, così come è descritto nei testi greci di quest'epoca.
Edipo è colui che, dopo aver conosciuto la miseria, ha conosciuto la gloria; colui che è diventato re, dopo essere stato eroe. Ma se è diventato re è stato perché ha guarito la città di Tebe, uccidendo la divina Cantatrice, la Sfinge che divorava tutti quelli che non riuscivano a decifrare i suoi enigmi. Aveva guarito la città, le aveva permesso di rimettersi in piedi, come egli dice, di respirare nel momento in cui aveva perduto il fiato. Per designare questa guarigione della città, Edipo impiega l'espressione "orthosan" «raddrizzare», "orthosan polis" «raddrizzare la città». Ora, questa è l'espressione che troviamo nel testo di Solone. Solone, che non è esattamente un tiranno, ma il legislatore, si vantava di aver riformato la città di Atene alla fine del secolo sesto. Questa è anche la caratteristica di tutti i tiranni che sono sorti in Grecia durante i secoli settimo e sesto: non solo hanno conosciuto alti e bassi, ma hanno inoltre avuto il ruolo di riformare le città attraverso una distribuzione economica giusta, come Cipselo a Corinto, o attraverso leggi giuste, come Solone ad Atene. Ecco quindi due caratteristiche fondamentali del tiranno greco, come ce lo mostrano i testi dell'epoca di Sofocle o anche precedenti.
Nell'"Edipo" si trovano anche diverse caratteristiche non più positive, ma negative della tirannia. Parecchie cose sono rimproverate a Edipo nelle sue discussioni con Creonte e Tiresia, così come con il popolo. Creonte, per esempio, gli dice: «Tu sei in errore. Ti identifichi con questa città, in cui non sei nato, immagini di essere questa città e che essa ti appartenga. Ma anch'io faccio parte di questa città, non è solo tua» (20). Se consideriamo le storie che per esempio raccontava Erodoto sui vecchi tiranni greci, in particolare su Cipselo di Corinto, vediamo che si tratta di uno che si considerava padrone della città. Cipselo diceva che Zeus gli aveva dato la città e che lui l'aveva riconsegnata ai cittadini. Si trova esattamente lo stesso nella tragedia di Sofocle.
Allo stesso modo, Edipo è colui che non dà importanza alle leggi e le sostituisce con le sue volontà e con i suoi ordini. Lo dice chiaramente. Quando Creonte gli rimprovera di voler esiliarlo, dicendo che la sua decisione non è giusta, Edipo risponde: «Poco mi importa che sia giusto oppure no; bisogna obbedire lo stesso» (21). La sua volontà sarà la legge della città. E' per questo che, nel momento in cui comincia la sua caduta, il Coro del popolo gli rimprovererà di aver disprezzato la "dike", la giustizia. Pertanto bisogna riconoscere in Edipo un personaggio ben definito, segnalato, catalogato, caratterizzato dal pensiero greco del quinto secolo: il tiranno.
Questo personaggio del tiranno non è caratterizzato solo dal potere, ma anche da un certo tipo di sapere. Il tiranno greco non era semplicemente colui che prendeva il potere. Era colui che lo prendeva perché deteneva o faceva valere il fatto di detenere un sapere di efficacia superiore a quello degli altri. Questo è precisamente il caso di Edipo. Edipo è colui che è riuscito a risolvere per mezzo del suo pensiero, del suo sapere, il famoso enigma della Sfinge. Così come Solone ha potuto effettivamente dare leggi giuste ad Atene, ha potuto riformare la città perché era un saggio, "sophos", così anche Edipo ha potuto risolvere l'enigma della Sfinge perché anche lui era un "sophos".
Che cosa è questo sapere di Edipo? Come si caratterizza? Il sapere di Edipo è caratterizzato per tutta l'opera. Edipo dice continuamente che egli ha vinto gli altri, che ha risolto l'enigma della Sfinge, che ha guarito la città per mezzo di ciò che lui chiama "ghnome", la sua conoscenza o la sua "téchne". Altre volte, per designare il suo modo di sapere, egli si dice colui che ha trovato, "eureka". E' questa la parola che con maggior frequenza Edipo utilizza per descrivere ciò che ha fatto un tempo e ciò che sta cercando di fare ora. Se Edipo ha risolto l'enigma della Sfinge è perché «ha trovato». Se vuole salvare di nuovo Tebe deve di nuovo trovare, "eyriakein". Che significa "eyriakein"? questa attività di «trovare» è caratterizzata inizialmente nell'opera come una cosa che si fa da soli. Edipo insiste più volte su ciò. «Quando ho risolto l'enigma della Sfinge non mi sono rivolto a nessuno» dice al popolo e all'indovino. Dice al popolo: «Non avreste potuto fare niente per aiutarmi a risolvere l'enigma della Sfinge, niente potevate fare contro la divina Cantatrice». E a Tiresia dice: «Ma che razza di indovino sei tu, che non sei stato capace di liberare Tebe dalla Sfinge? Quando tutti erano sprofondati nel terrore io solo ho liberato Tebe; non ho saputo niente da nessuno, non mi sono servito di nessun messaggero, sono venuto di persona». Trovare è qualcosa che si fa da soli. E' anche quello che si fa quando si aprono gli occhi. E Edipo è l'uomo che sottolinea continuamente: «Io ho indagato e siccome nessuno è stato capace di darmi informazioni, ho aperto occhi e orecchie; e ho visto». Edipo utilizza frequentemente il verbo "oida", che significa allo stesso tempo sapere e vedere. "Oidipoys" è colui che è capace di quest'attività di vedere e sapere. Edipo è l'uomo del vedere, l'uomo dello sguardo, e lo sarà fino alla fine.
Se Edipo cade in una trappola è proprio perché, nella sua volontà di trovare, ha insistito nella testimonianza, nel ricordo, nella ricerca delle persone che hanno visto, fino al momento in cui, in fondo al Citerone, è stato snidato lo schiavo che aveva assistito a tutto e sapeva la verità. Il sapere di Edipo è questa specie di sapere di esperienza. Ed è allo stesso tempo questo sapere solitario, di conoscenza, dell'uomo che vuole vedere con i suoi propri occhi, da solo, senza basarsi su ciò che si dice, senza ascoltare nessuno. Sapere autocratico del tiranno che da solo è capace di governare la città. La metafora di chi governa, di chi comanda, è utilizzata frequentemente da Edipo per descrivere ciò che fa. Edipo è il capitano, colui che sulla prua della nave apre gli occhi per vedere. Ed è proprio perché apre gli occhi su ciò che sta per succedere che incontra l'incidente, l'inatteso, il destino, la "tyche". Edipo è caduto nella trappola perché è l'uomo dallo sguardo autocratico, aperto sulle cose.
Quello che vorrei mostrare è che in fondo Edipo rappresenta nell'opera di Sofocle un certo tipo di quello che chiamerei sapere-e-potere, potere-e-sapere. E' perché esercita un potere tirannico e solitario, altrettanto distante dall'oracolo degli dèi - che non vuole ascoltare - che da quello che dice e vuole il popolo, che egli nella sua sete di governare scoprendo da solo, trova, in ultima istanza le testimonianze di coloro che hanno visto.
Vediamo così come il gioco delle metà ha potuto funzionare, e come, alla fine dell'opera, Edipo sia un personaggio superfluo. Questo, nella misura in cui questo sapere tirannico, questo sapere di chi vuol vedere con i suoi propri occhi, senza ascoltare né gli dèi né gli uomini, permette di far esattamente combaciare ciò che avevano detto gli dèi e ciò che sapeva il popolo. Edipo, senza volerlo, riesce a stabilire l'unione tra la profezia degli dèi e la memoria degli uomini. Il sapere edipico, l'eccesso di potere, l'eccesso di sapere, sono stati tali che egli è diventato inutile; il cerchio si è chiuso su di lui, o meglio, i due frammenti della tessera combaciano e Edipo, nel suo potere solitario, è diventato inutile. Nei due frammenti ricomposti la sua immagine è divenuta mostruosa. Edipo poteva troppo per il suo potere tirannico, sapeva troppo nel suo sapere solitario. In questo eccesso egli era anche lo sposo di sua madre e il fratello dei suoi figli. Edipo è l'uomo dell'eccesso, colui che ha troppo di tutto, che eccede nel suo potere, nel suo sapere, nella sua famiglia, nella sua sessualità. Edipo, uomo doppio, che era di troppo in rapporto alla trasparenza simbolica di ciò che sapevano i pastori e di ciò che avevano detto gli dèi.
Dunque, la tragedia di Edipo è abbastanza vicina a ciò che sarà, alcuni anni più tardi, la filosofia platonica. In Platone, a dire il vero, il sapere degli schiavi, memoria empirica di ciò che è stato visto, sarà svalutato a vantaggio di una memoria più profonda, essenziale, che è la memoria di ciò che si è visto nel cielo intelligibile. Ma l'importante è quello che sarà radicalmente svalutato, squalificato, tanto nella tragedia di Sofocle quanto nella "Repubblica" di Platone: è il tema, o meglio il personaggio, la forma di un sapere politico al contempo privilegiato ed esclusivo. Quello che è preso di mira dalla tragedia di Sofocle o dalla filosofia di Platone, se situate in una dimensione storica, quello che è preso di mira dietro Edipo "sophos", Edipo il saggio, il tiranno che sa, l'uomo della "techne", della "ghnome", è il famoso sofista, il professionista del potere politico e del sapere, che realmente esisteva nella società ateniese dell'epoca di Sofocle. Ma dietro di lui quella che Platone e Sofocle vogliono prendere di mira è un'altra categoria di personaggi, di cui il sofista è solo un piccolo rappresentante, la continuazione e la conclusione storica: il personaggio del tiranno. Nei secoli sesto e settimo il tiranno era l'uomo del potere e del sapere, colui che dominava tanto per il potere che per il sapere che possedeva. Infine, anche se non è presente nel testo di Platone né in quello di Sofocle, colui che è preso di mira è il grande personaggio storico che effettivamente è esistito, anche se visto in un contesto leggendario: il famoso re assiro.
Nelle società indoeuropee dell'Oriente mediterraneo, alla fine del secondo millennio e agli inizi del primo, il potere politico era sempre detentore di un certo tipo di sapere. Per il fatto di detenere il potere, il re e coloro che lo circondavano erano in possesso di un sapere che non poteva e non doveva essere comunicato agli altri gruppi sociali. Sapere e potere erano esattamente corrispondenti, correlativi, sovrapposti. Non poteva esserci sapere senza potere, e non poteva esserci potere politico senza il possesso di uno speciale sapere.
E' questa forma di potere-sapere che Dumézil ha isolato nei suoi studi sulle tre funzioni, mostrando che la prima funzione, quella del potere politico, era quella di un potere politico magico e religioso (22). Il sapere degli dèi, il sapere dell'azione che si può esercitare sugli dèi o su di noi, tutto questo sapere magico-religioso è presente nella funzione politica.
Quello che è successo all'origine della società greca, all'origine dell'epoca greca del secolo quinto, all'origine della nostra civiltà, è lo smantellamento di questa grande unità di un potere politico che sarebbe al contempo un sapere. E' lo smantellamento di questa grande unità di un potere magico-religioso che esisteva nei grandi imperi assiri, che i tiranni greci, impregnati di cultura orientale, hanno cercato di riabilitare a loro vantaggio e che i sofisti del quinto e sesto secolo hanno ancora utilizzato come potevano, nella forma di lezioni pagate in denaro. Durante i cinque o sei secoli della Grecia arcaica assistiamo a questa lunga decomposizione. E quando comincia l'epoca classica - Sofocle ne rappresenta il momento iniziale, il suo primo manifestarsi -, ciò che deve sparire perché questa società possa esistere è l'unione del potere e del sapere. A partire da questo momento, l'uomo del potere sarà l'uomo dell'ignoranza. Alla fine quello che è accaduto a Edipo è che per volere troppo sapere, non sapeva niente. Edipo funzionerà come l'uomo del potere, cieco, che non sapeva, e non sapeva perché troppo poteva.
Così, mentre il potere è tacciato di ignoranza, di incoscienza, di oblio, di oscurità, ci saranno da una parte l'indovino e il filosofo in comunicazione con la verità, con le verità eterne degli dèi o dello spirito, e dall'altra ci sarà il popolo che, pur senza nulla detenere del potere, possiede in sé il ricordo e può dare ancora testimonianza della verità. Così al di là di un potere che è diventato monumentalmente cieco, come Edipo, ci sono i pastori che ricordano e gli indovini che dicono la verità.
L'Occidente sarà dominato dal grande mito secondo cui la verità non appartiene mai al potere politico, il potere politico è cieco, il vero sapere è quello che si possiede quando si è in contatto con gli dèi o quando ci si ricorda delle cose, quando si guarda il grande sole eterno o si aprono gli occhi su ciò che è accaduto. Con Platone comincia un grande mito occidentale: che vi sia antinomia tra il potere e il sapere. Se c'è del sapere è necessario che rinunci al potere. Lì dove sapere e scienza si trovano nella loro pura verità non può più esserci potere politico.
Questo grande mito va liquidato. E' questo mito che Nietzsche ha cominciato a demolire, mostrando nei numerosi testi già citati, che dietro ogni sapere, dietro ogni conoscenza, ciò che è in gioco è una lotta di potere. Il potere politico non è assente dal sapere, è ordito con esso.