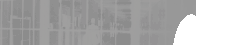Per gli ufficiali italiani si trattava di un problema nuovo, di fronte al quale occorreva prendere posizione. E la posizione generale e ufficiale fu agevole, dopo la vittoria del precedente inverno: si dice no con chiarezza e con decisione. Agli inviti seguirono allora le pressioni, le intimidazioni, le minacce nei confronti del singolo.
Nello stesso tempo, per rendere persuasivo e allettante il lavoro nelle campagne o nelle fabbriche e probabilmente per le crescenti difficoltà, i tedeschi riducono progressivamente le già misere razioni alimentari degli internati. Il tormento e l'incubo della fame, l'esaurirsi delle forze fisiche, il miraggio di qualche patata o di un pezzo di pane rese grave e impegnativa per tutti la resistenza contro il lavoro obbligatorio.
Ma il grado di maturità raggiunto dalla resistenza si può misurare dal gesto che gli internati italiani proprio nel momento dell'offensiva per il lavoro seppero compiere nell'autunno del '44, a Sandbostel. Erano giunti nel lager, dopo la sanguinosa rivolta di Varsavia, donne e bambini polacchi, in notevole numero, sconvolti ed estenuati dalla lotta e dalle sofferenze. Gli italiani decisero allora - e ottennero - di rinunciare per qualche tempo a una parte dei loro viveri per offrirli in aiuto e in segno di solidarietà ai deportati di Varsavia.
Abbiamo letto numerose testimonianze sui tragicomici modi di divisione delle razioni in prigionia: la fame ci aveva condotto a esasperate e cerebrali espressioni di diffidenza e di egoismo. Una forma di pane, di quel pesante e umido pane tedesco che la guerra ha fatto conoscere in tutta l'Europa, veniva divisa geometricamente in parti uguali; quindi le parti si eguagliavano fino al grammo con bilance sensibili come quelle dei farmacisti, e quando l'eguaglianza nel peso e nella forma era quasi assoluta si tirava ancora a sorte. Il grido di rito: «a chi questa!» credo sia stato per molto tempo l'incubo notturno degli ex internati. Tutto ciò è vero: veri gli specialisti delle ripartizioni, veri i bilancini, vera la diffidenza, come vera, autentica era la fame. Ma è anche vero che quei fabbricatori di bilance, quei lucidi pazzi delle suddivisioni di pochi grammi di margarina seppero rinunciare per i combattenti di Varsavia a quel misero cibo e seppero con eguale dignità e tenacia dire di no fino all'estremo ai reclutatori tedeschi di mano d'opera.
Nessun dubbio esisteva nemmeno nei singoli che il dovere fosse di rifiutare qualsiasi compromesso, qualsiasi forma di collaborazione con i tedeschi. Perché altrimenti si sarebbe rimasti per lunghi mesi nei lager? che logica vi sarebbe stata nel dire "sì" ai nazisti, dopo avere ostinatamente detto "no" ai fascisti?
La ripulsa vi fu anche quando si vide con chiarezza che il rifiuto del lavoro avrebbe significato il campo di punizione, lo "Straflager", il passaggio cioè dalla categoria degli internati a quella dei prigionieri politici. Non pochi tra gli ufficiali italiani affrontarono quel rischio: e in ciò si può cogliere il segno di una maturità raggiunta, non essendo in definitiva la punizione che il riconoscimento di una dignità, il conferimento di un titolo da parte dei tedeschi che forse non si rendevano nemmeno conto di dare così una sanzione ufficiale al significato politico della resistenza degli internati.
La lotta contro il lavoro obbligatorio divenne in tal modo l'episodio di maggiore impegno e di più alta responsabilità per chi la alimentò e la diresse. Essa poteva infatti comportare un esito diverso da quello che la non adesione aveva avuto nell'inverno precedente. Non riconoscere il governo di Mussolini voleva dire prigionia; ribellarsi all'imposizione dei tedeschi poteva significare morte. E non solo perché a molti giunti al limite della resistenza fisica l'uscire dal lager avrebbe forse offerto l'occasione della salvezza ma pure perché il rifiuto esponeva a una rappresaglia e a una vendetta che nell'accentuarsi della ferocia e della brutalità della belva ormai ferita a morte ben si immaginava quale significato avrebbe avuto.
Era facile comprendere che quel tentativo estremo dei tedeschi suonava come premonizione della fine, come una delle ultime disperate misure per tamponare le falle sempre più grandi, e che coloro che avessero accettato l'arruolamento non avrebbero forse avuto né il tempo né le forze né certo la volontà di dare al grande Reich un qualsiasi contributo. Non mancò invero chi sostenne che il tempo per morire con un rifiuto ci sarebbe stato, mentre la rovinosa situazione della Germania non sarebbe certo mutata per l'apporto di qualche migliaia di italiani sfiniti.
Tuttavia le ragioni della resistenza erano divenute tanto forti, i principi della lotta così importanti e inderogabili da costringere a dire di no, da far considerare come traditori quanti, alla vigilia della libertà, finivano per piegare nel compromesso con i nazisti. La intransigenza e il rigore costarono momenti di angoscia e di tempesta anche alle coscienze più illuminate, che avvertirono allora in modo acuto il peso delle responsabilità sia di quelle ufficiali conferite dalla collettività, sia di quelle morali che ognuno con la sua opera e la sua parola aveva assunte.
Ma non poteva essere altrimenti. Con il lassismo, con le distinzioni troppo sottili, le tolleranze, gli accomodamenti, le scappatoie, la resistenza non ci sarebbe stata nei lager, così come non ci sarebbe stato in Italia il movimento e la lotta partigiana. Tutte le battaglie comportano dei rischi e per affrontarli occorre la saldezza dei principi, il rigore della fede, il rispetto assoluto del dovere.
Anche in questa circostanza, che fu senza dubbio la più grave, i gruppi più decisi e preparati politicamente non mollarono. La loro azione e la loro propaganda furono improntate a quel secco e lineare rigorismo che già in altre occasioni ed episodi era venuto alla luce, come espressione tipica fondamentale dello spirito antinazista nei lager.
Bisognava essere duri, armati, implacabili verso ogni forma di cedimento, di debolezza, di fiacchezza. E ciò spiega la diffidenza nei confronti di chi non trascurava le occasioni di contatto e di cordialità con i tedeschi; il disprezzo per l'intrallazzismo, il fastidio verso gli atteggiamenti «sentimentali», le espressioni lacrimose del sacrificio e l'ostentazione delle piaghe.
Nei lager, per esempio, vi fu una interessante polemica preventiva contro l'immaginabile diluvio letterario delle confessioni, delle memorie, delle rime, contro le raccolte dei disegni e delle pitture e delle musiche composte sotto il regime alimentare delle rape! Dava noia l'oleografia e la rettorica del lager, il «realismo» banale di chi voleva far sentire e vedere le magre minestre e le acque fetide e gli insetti e i reticolati e le sentinelle all'agguato dalle torrette; si reagiva alle suggestioni e alle tentazioni dei numeri unici, tipo collegio ecclesiastico o scuola militare già in gestazione; si era diffidenti verso impegni di future pubblicazioni pseudoartistiche a scopo umanitario. E manco a farlo apposta, nei campi stessi sorsero dopo la liberazione dei giornalucoli come il «Picco e pala» di Wietzendorf che pure col solo nome avvaloravano quei sospetti e quelle polemiche.
La resistenza era una cosa seria, e serietà si chiedeva che avessero i documenti, artistici o storici, che da essa dovevano scaturire, così come a serietà si voleva fosse improntata anche nel futuro qualsiasi associazione o società che unisse gli ex internati. La lotta antifascista aveva voluto essere anche polemica, battaglia e superamento di antichi e recenti vizi della società italiana, spesso attribuiti anche in Germania alla natura stessa del nostro popolo. Alcuni temi dominanti, luoghi comuni dell'indole italiana, come la furbizia, la capacità di arrangiarsi, il tirare a campare, il genio della bonarietà e delle mezze misure, la lacrimuccia pietosa del vogliamoci bene, la rettorica dei sentimenti, l'inclinazione artistica, il così detto individualismo e infine il doppiogiochismo che anche nei campi di concentramento avevano fatto la loro prova, non potevano non cadere sotto la censura e i colpi di quanti sognavano e affermavano l'esigenza di un rinnovamento radicale e completo della società nazionale. Il contatto con uomini di altri popoli ci aveva d'altra parte persuasi che noi non avevamo tanto una diversa natura quanto una differente storia e una diversa condizione sociale. Con il razzismo tedesco si condannavano anche le concezioni del più astratto idealismo e sociologismo sull'anima dei popoli, sulle differenti nature e destini delle nazioni e le conseguenti formazioni tipologiche del tedesco guerriero o filosofo, del francese eroico o smidollato, dell'italiano furbo, individualista e pezzente che suona alla chitarra il suo eterno «umanesimo». Le condizioni di debilitazione fisica avevano tarpato le ali al «gallismo», ma fu sufficiente uscire dai campi, alla liberazione, e mangiare qualche cosa per dovere fare i conti anche con la leggenda del "viel temperament" degli italiani.
La resistenza aveva dimostrato che noi potevamo con il medesimo coraggio e la medesima dignità di tutti gli altri popoli affrontare e superare la prova comune all'Europa. Bisognava perciò spogliarsi dello scoglio del vecchio uomo, delle malattie remote e recenti che avevano prodotto il cancro politico e morale del fascismo. Procedere per princìpi era difficile, è sempre difficile. E non si può negare che l'intransigenza politica e morale sia scivolata talvolta nel settarismo e nell'incomprensione. Così ebbe senza dubbio un valore e un senso nei lager l'opporsi ai tentativi associazionisti in base al concetto che la prigionia era un dovere, compiuto il quale venivano a cadere i motivi di una qualsiasi società di ex internati, ma è chiaro che sarebbe stato un errore persistere dopo la liberazione in una tale posizione.
Allo stesso modo l'invito alla cautela e alla serietà, l'impegno quasi del silenzio nel campo letterario e artistico che rispondeva nei lager alla necessità dell'approfondimento politico e morale delle ragioni della resistenza e a una concezione schiva e antieroica del dovere costituì forse più tardi un limite alla conoscenza e alla popolarizzazione di quella battaglia. Nell'ansia della purezza e della ritrosia molti commisero l'errore, altrettanto e forse più grave di quello costituito dal rischio della rettorica dei sentimenti, di tacere, di non mettere in chiaro attraverso le nostre vicende le cause e le responsabilità della guerra, dell'armistizio, del crollo dell'esercito, di non insistere sul significato e sul valore antifascista, nazionale, democratico della prigionia dei soldati italiani in Germania.
Ci accorgiamo oggi, avvertendo pure le nostre responsabilità, che se in tanti avessimo parlato, e parlato a voce alta, forse nel nostro Paese non ci sarebbero stati la vergogna e il ridicolo che contraddistinsero molti aspetti del dopoguerra, come la persecuzione giudiziaria sotto il pretesto della continuità e della intangibilità dell'esercito, contro chi tentò di denunciare gli errori, le debolezze, le indegnità dei singoli. A ripensarci, lo scandalo non fu solo nel fatto che nel dopoguerra fosse rischioso indicare le amenità e i crimini dei dirigenti di una guerra radicalmente sbagliata. Accanto al silenzio che si volle imporre sulle figure dei traditori e degli imbelli, si ebbe il più grave silenzio, che tutti abbiamo tollerato, intorno a coloro che si erano battuti, che avevano resistito di fronte al nemico, che avevano pagato di persona. Nei lager tedeschi morirono 17 generali italiani: silenzio! Morirono alcune decine di migliaia di soldati e di ufficiali italiani: silenzio!
Se noi avessimo parlato e parlato a voce alta non avremmo probabilmente nel Parlamento italiano gli ambasciatori repubblichini, strumenti e complici dei nazisti nell'invenzione della «libertà del 31 agosto», né costoro potrebbero farsi vanto di avere difeso dalla follia hitleriana gli internati e i lavoratori civili in Germania, proprio essi che a quella follia sanguinaria prestarono mano fino al limite estremo.
Lo scrupolo intransigente è stato, dunque, una remora alla conoscenza della nostra lotta e allo sviluppo di quell'unitaria coscienza antifascista e democratica che aveva pur costituito l'obiettivo fondamentale della resistenza nei lager e la letteratura, la ricerca storica, la pubblicazione di memorie e di testimonianze espresse dalla prigionia degli internati militari sono rimaste entro limiti angusti e a una fase embrionale ben più di quanto non sia avvenuto per il movimento partigiano.