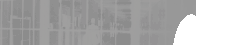Il ricordo è nitido e preciso nella memoria. E oggi mi è chiaro che noi abbiamo vissuto per mesi nell'attesa quotidiana che scoppiasse la pace, ma senza la convinzione che essa avrebbe messo fine per sempre ai conflitti.
La volontà di pace fu un esercizio continuo della resistenza antinazista, l'altra faccia, inseparabile, dell'orrore della guerra. Ma nei lager non avevano corso le illusioni pacifiste, i miti della pace perpetua e universale, la facile speranza di un mondo composto nell'accordo definitivo, perché quella guerra, ancora nel suo svolgimento, aveva già rivelato una somma tale di sacrifici, di rovine, di barbarie da scoraggiare necessariamente chiunque in futuro dal fare appello alle armi. L'aspirazione profonda alla pace si univa a una disincantata capacità di giudizio sulle ragioni e sulle origini dei conflitti. La lezione delle cose accadute dall'una all'altra guerra mondiale, l'esperienza stessa che come italiani avevamo vissuta formavano il convincimento diffuso che la pace non sarebbe stata un frutto spontaneo e sicuro della stanchezza, della nausea, della condanna del conflitto sanguinoso. C'era in noi, con ogni probabilità, una meno viva speranza che non nei combattenti della guerra '15-18, ma nello stesso tempo eravamo meno scoperti, meno indifesi di fronte al rischio dell'inganno, del disarmo delle coscienze, della rinunzia alla vigilanza e alla lotta per la pace.
Intanto il nostro augurio ardente di giungere alla fine del conflitto non significò mai desiderio di una pace qualsiasi. Non poteva esserci pace che nella sconfitta dei fautori e dei teorizzatori della aggressione, nella condanna della volontà di dominio, nel riconoscimento della libertà dei popoli, nell'affermazione dei princìpi di indipendenza, di giustizia, di progresso. La vittoria del nazismo o il compromesso con il nazismo non sarebbe stata la pace. D'altra parte l'incontro con i popoli oppressi di tutta l'Europa aveva permesso una preziosa constatazione: i popoli amano e vogliono la pace, le ragioni della pace sono nei popoli sempre più forti di quelle della guerra.
Noi italiani avevamo fatto la guerra ai greci. Una delle tante avventure sciagurate del regime che avevano diviso con un solco di sangue e di sventura due popoli.
Nell'occupazione della Grecia avevamo condiviso con i tedeschi le responsabilità di una dominazione brutale e rapace. Ma dopo l'8 settembre, quando a noi toccò la sorte di passare come prigionieri dei tedeschi in terra greca, non ci mancò la solidarietà umana, l'aiuto, col rischio mortale che esso comportava, da parte dei greci. Come dimenticare la giovane donna che attese per ore davanti ai reticolati del campo Maginot di Atene a spiare il momento opportuno per offrire ai prigionieri italiani qualche tozzo di pane? Come dimenticare la vecchia jugoslava che sfidò i guardiani della tradotta per darci qualche prugna?
Avevamo fatto la guerra ai francesi. Pure, quando con essi ci si trovò assieme nei lager tedeschi, quel nostro tentativo di riscatto dignitoso dissolse rapidamente i motivi della diffidenza e del rancore.
Avevamo fatto la guerra all'Unione Sovietica, ma i russi, che numerosi incontrammo in Germania, non ebbero mai un gesto di inimicizia, di odio verso di noi che pur avevamo profondamente affondato la spada nella loro carne.
E' vero, non mancarono nei campi di concentramento - soprattutto in quelli politici e del lavoro forzato - gli aguzzini, le canaglie, i vigliacchi che si posero a servizio dei tedeschi e furono i più feroci persecutori dei loro compagni nel tentativo di evitare la fame e la morte. Ogni nazionalità ebbe i suoi giuda, non esclusi gli ebrei, e di essi i nazisti, le S.S. in particolar modo, si servirono con raffinata crudeltà opponendo gli uni agli altri, eccitando gli odi e le divisioni, riversando sulle spalle dei prigionieri le misure più odiose del sistema persecutorio. Era una legge essenziale del lager quella di creare un'aristocrazia di prigionieri sulla quale tuttavia pendeva a ogni momento il rischio mortale di rientrare nella massa comune e che per evitare il pericolo si mutava nel più disumano strumento poliziesco che mai si era potuto concepire.
L'odio contro il "lagerältester", il "Kapo" della baracca, della squadra di lavoro, della cucina o dell'infermeria superò molto spesso l'esecrazione di cui erano oggetto le S.S. e i guardiani tedeschi e all'indomani della liberazione si svolsero in molti campi dei processi e delle esecuzioni di aguzzini che possono collocarsi tra gli episodi più ammonitori e impressionanti di giustizia popolare. E' altrettanto vero che nei lager della morte si svolsero pure delle accanite battaglie fra i diversi gruppi nazionali per la conquista delle posizioni burocratiche che potevano consentire di sopravvivere e che in determinati momenti il predominio toccò ai francesi, in altri ai polacchi, in altri ancora ai russi o ai politici tedeschi. Tutto ciò è vero, ed è stato documentato, così come si è messo in luce nel piano nazista rivolto a frantumare e a distruggere completamente la personalità umana dei prigionieri, il tentativo di uccidere ogni spirito di fraternità nazionale e di solidarietà internazionale.