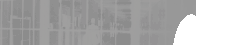Ma altre questioni ancora la resistenza doveva affrontare.
Prima di tutto vi è l'odio nei confronti dei tedeschi. Il capitolo delle atrocità naziste è così lungo che non vale la pena di accrescerlo. Sarebbe sufficiente leggere, rileggere, e non dimenticare.
In esso poi le pagine di Auschwitz e di Buchenwald fanno impallidire le nostre, di Fullen e di Wietzendorf. Per primi giunsero nei campi i comunisti e gruppi di socialdemocratici tedeschi e gli ebrei. Il lager faceva le sue prove. Con la guerra si mutò in una parte del mondo. Fu popolato via via da polacchi, francesi, olandesi, russi, greci, jugoslavi. Ogni popolo mandò la sua rappresentanza. Noi abbiamo avuto la ventura di giungervi quando la persuasione della vittoria non era più assoluta: il tarlo di dover rendere un giorno i conti minava il gusto nazista del massacro. L'atomica della distruzione di massa era già esplosa, prima che a Hiroshima, a Dachau, ad Auschwitz, a Mauthausen, a Sachsenhausen, a Belsen. Noi fummo vittime di riflesso dello scoppio immane.
Altri avevano impresso a fuoco sulla carne un numero: per noi bastava la cartella segnaletica del delinquente. Chissà in quali archivi del Reich avranno conservato le nostre impronte digitali. Non ci hanno rasato i peli, li hanno solo cosparsi di creosolo. Gli insulti erano i medesimi, il vocabolario conosceva poche parole: "scheisse!" Ma non provammo il linguaggio della frusta, della forca, dei forni.
La fame fu comune e atroce, ma abbiamo ancora vergogna della nostra fame pensando al crematorio di Birkenau.
A Belsen le donne servirono da cavie alla foia dei macellai della scienza tedesca: con noi si limitarono agli esperimenti delle tabelle dietetiche. Con quante calorie di rapa un uomo può campare?
Il lavoro e lo sport non furono per noi mutati in strumenti di tortura e di morte.
Rifiutammo di lavorare e non ci uccisero. Ci promossero solo da internati a prigionieri politici. I nostri compagni non caddero sotto il bastone dell'aguzzino. Morirono semplicemente di tubercolosi o di dissenteria.
Il tifo ci risparmiò: avemmo amici i pidocchi, non i tedeschi.
Non fummo colpiti alla nuca durante qualche trasferimento. Quando i nazisti decisero di usare contro di noi la rappresaglia feroce era ormai troppo tardi. L'ordine fu scritto e firmato da Goebbels. La scadenza: 30 marzo 1945. Ma non venne eseguito.
A W÷belin i prigionieri dovettero montare la guardia ai morti con grossi bastoni per impedire che la loro carne miserabile venisse mangiata. A noi fu risparmiato l'antropofagismo.
I nostri morti non andarono nudi nella fossa comune o al forno: li seppellimmo in qualche desolato cimitero.
Non li contammo a milioni, solo a decine di migliaia. Morirono ancora come «uomini». Per altri la morte significò cancellare un numero da un registro: un atto burocratico.
Dopo la liberazione abbiamo avuto modo di misurare la nostra condizione sul metro di Mauthausen e di Belsen. Sappiamo dunque quale fu il nostro posto nel sistema del lager. Ma nel corso della vicenda, poiché i campi erano mondi senza finestre, dalla persuasione di essere giunti all'estremo del sacrificio scaturì per ognuno un odio estremo. Se l'intensità della persecuzione non fu uguale, eguale fu il sentimento di esecrazione e di condanna dei nazisti.
La sentinella che ha colpito a morte il nostro compagno responsabile di avere incautamente posto ad asciugare sul filo spinato due fazzoletti, sarà inviata in licenza premio (questi erano i tedeschi).
I vecchi soldati territoriali che scrollano il capo facendo il nome di Hitler, ti strapperanno crudelmente la coperta al momento del trasferimento in pieno inverno da un campo all'altro (questi erano i tedeschi). Il giovane biondo ufficiale farà fermare a Belgrado i vagoni piombati in piena stazione e a ludibrio nostro e degli jugoslavi costringerà gli italiani a calarsi i pantaloni e a fare i propri bisogni sui binari: così il nazismo pervertì i tedeschi!
Non possiamo distinguere. Non vediamo un volto che sia diverso dagli altri. Quando sapremo di un attentato contro Hitler il primo moto sarà di incredulità e di ironia.
A Bergen, dopo la liberazione, interrogheremo con ansia la gente, accusando una responsabilità collettiva. Ai tedeschi, alle donne che diranno di non aver saputo, di avere ignorato che a qualche chilometro dal loro paese gli ufficiali italiani e francesi morivano di fame nel campo di Wietzendorf, e più vicino ancora, a Belsen, si consumava nella ferocia e nella barbarie il sacrificio di centinaia di migliaia di ebrei e di prigionieri politici, noi non crederemo.
Non sapevamo e non potevamo dunque distinguere nel momento della resistenza. S.S., nazisti, soldati, uomini e donne ci apparivano la medesima espressione di guerra che doveva essere distrutta. Si comprende così come nei lager vi sia stata una larga ripresa di tutti i motivi della tradizione antitedesca: non mancava del resto chi aveva avuto il tempo e la sventura di sperimentare due volte la cattività nei campi di concentramento della Germania, nella prima e nella seconda guerra mondiale. Era difficile porre il problema dei rapporti con i tedeschi se non in termini di inimicizia, di risentimento, di odio. Il disprezzo dunque e l'insulto a nostra volta contro il "boche", il "crucco", il "tugnin", contro il popolo intero che aveva nel sangue il tremendo virus della guerra e della violenza, sì da giungere pure a espressioni di condanna assurde, nella loro superficiale violenza, come quelle di chi si proibiva di pronunciare una sola parola di tedesco, pur conoscendo bene quella lingua.
Pure la resistenza dovette accorgersi che non era possibile annegare in una generica e banale condanna di un popolo intero la lotta politica contro una ideologia e un regime. A noi, che avevamo del resto alle spalle una storia per molti aspetti simile, poteva e doveva toccare il compito di saper distinguere e di metter in luce, nelle responsabilità generali, le particolari e più pesanti responsabilità delle classi dirigenti, dei signori della guerra, delle caste militari, del prussianesimo e dell'hitlerismo nella storia della nazione tedesca.
Al di là del problema contingente dell'odio e della lotta esisteva pur quello di un popolo, di una nazione, che aveva compiuto sì nel giro di alcuni decenni orribili crimini contro l'umanità e scatenato guerre di conquista e di dominio e insanguinato l'intera Europa, ma un popolo e una nazione che aveva pur dato un contributo alla civiltà e al pensiero moderno.
Leggevo - il 13 aprile del 1945 - poco prima che giungesse a Wietzendorf con una autoblinda inglese il primo annuncio della libertà, il volumetto di Thomas Mann su Richard Wagner. A un amico indicai, mentre giacevamo prostrati per la fame, il brano in cui Mann dice: «Wagner non ha condiviso l'errore volontario della borghesia tedesca che ha creduto possibile vivere nel mondo dello spirito e non esistere in quello politico, questo errore che è responsabile della miseria tedesca» e quello, secco secco: «Ma sei scemo. Un tedesco che parla di un altro tedesco! e tu sprechi le tue forze con simile genia!» Ma questo stato d'animo diffuso di estrema e totale condanna si rivelava infine sterile e inconcludente quando si poneva il problema del futuro. C'era si chi non esitava ad affermare che al popolo tedesco occorreva applicare il metodo che esso aveva usato nei confronti di tutti gli altri popoli d'Europa e fare della Germania un enorme terribile campo di concentramento in cui dominasse come legge il bastone, il lavoro forzato, l'eliminazione violenta. C'era sì chi sognava la liberazione come una grande orgia di sangue a cui, si diceva, noi dovevamo partecipare come parte attiva. Ma si trattava di sfoghi verbali dettati dalla sofferenza e dal rancore. In termini di ragionamento politico si finiva per capire che un popolo, situato nel cuore dell'Europa, non poteva essere né distrutto né ridotto in servitù. Né, come qualcuno affermava, ricondotto indietro nelle condizioni precedenti all'unità, alla anacronistica esistenza di una miriade di stati e staterelli.
Il problema della Germania era quello della ripresa democratica della società tedesca, dello sradicamento completo delle forze sociali e politiche che per due volte nel corso di trent'anni avevano fatto di essa una potenza militarista e aggressiva, della punizione esemplare di tutti coloro che della guerra avevano fatto uno strumento scientifico e crudele di oppressione e il mezzo per scatenare e far diventare costume di un popolo i suoi più bassi istinti belluini.
Alla parte più illuminata della resistenza la resa senza condizioni, la sconfitta militare del nazismo, l'occupazione della Germania, appariva pertanto come l'occasione non per dividere o distruggere il popolo tedesco ma per liberarlo dalle piaghe profonde che avevano condotto la nazione di Goethe e di Schiller nel baratro degli Hitler o dei Rosenberg. Per tutti, comunque, nell'odio o nella comprensione, era chiaro che la Germania era stata la "guerra" e che ai tedeschi bisognava nel futuro in ogni modo impedire di essere ancora la "guerra".
Quando uscimmo dai lager e vi fu modo di parlare, soprattutto con le donne tedesche, ci accorgemmo di quanto profondamente avesse operato il nazismo. Il crollo della Germania si concludeva in quell'aprile del 1945 in modo ben diverso da quello che aveva caratterizzato la caduta dello stato fascista nel nostro Paese e nessuno venga a dirci oggi che i tedeschi hanno avuto fino all'estremo la forza di combattere per la Patria, mantenendo intatto l'onore e alta la loro bandiera! Noi abbiamo visto la crisi spaventosa della sconfitta, il vuoto morale, il disfacimento di tutti i valori dopo l'ubriacatura dell'irrazionale, del mostruoso, della violenza. La Germania è caduta in verità senza la luce di un ideale, senza la fede in una qualche idea che potesse vivere al di là della sorte delle armi. Ancora più che in Italia il nazismo aveva travolto nella compromissione ogni organismo dello stato, ogni gruppo sociale, ogni forma economica. Il processo di identificazione del Reich con il regime aveva toccato un punto tale da rendere impossibile qualsiasi linea di ripiegamento o di riserva. Il fallimento stesso dell'attentato del 20 luglio rivelava l'estrema difficoltà di una dissociazione dell'esercito dal nazismo. Dopo Hitler era il diluvio!
E così nemmeno nel momento estremo si levò una voce, si compì un gesto qualsiasi. Al più la rassegnazione o il baccanale confuso di uomini e donne ciechi e svuotati di ogni sostanza, una sorta di convulso tripudio destinato a esaurirsi dopo quello scoppio disordinato di gioia nell'amarezza e forse nella ricerca della vendetta e della rivincita. La Germania dei lager era stata odiosa e terribile, quella che incontrammo dopo la liberazione ancor più odiosa e spregevole nell'ipocrisia con cui respingeva le responsabilità del nazismo fingendo di ignorarle.
La resistenza antihitleriana delle carceri, dei campi di concentramento, degli attentanti sfuggiva in quel momento alla nostra considerazione. Non sapevamo che quei lager, che erano stati il tormento e la tomba di milioni e milioni di europei, erano sorti proprio per combattere e distruggere i comunisti, i democratici, gli antifascisti, e che quel sistema di persecuzione scientifica era stato costruito sulla carne viva dei tedeschi. Non sapevamo che nel periodo della guerra i tedeschi condannati a morte dai tribunali nazisti assommavano a parecchie decine di migliaia e che numerosi altri erano stati soppressi nel silenzio, senza lasciare una qualsiasi traccia.
Le parole di fierezza e di dignità che i tedeschi avevano detto di fronte alla morte erano simili a quelle di tutti i resistenti d'Europa: vi era in esse la medesima ribellione e la medesima speranza di libertà e di pace. Ma per noi esse erano cadute in quel silenzio atroce che gravava sulle prime settimane della nostra libertà in Germania.
Ciò spiega perché ci sembrasse allora difficile ma non impossibile che i tedeschi ricuperassero la libertà, l'indipendenza, l'unità. Giudicavamo impossibile e intollerabile che essi potessero riavere le armi, i mitra e i cannoni. E per non permettere la rinascita di un esercito tedesco altra via non vedevamo che colpire a morte, all'origine e in modo spietato, il militarismo tedesco e le forze sociali e politiche che lo avevano alimentato e sorretto.
Nei lager la resistenza significò anche condanna del militarismo. Ma non nelle forme astratte che molto spesso la polemica antimilitarista aveva avuto nel passato. Noi eravamo dei soldati che, nonostante tutte le umiliazioni e i sacrifici che l'essere stati soldati durante il fascismo aveva comportato, non rinnegavano affatto l'esigenza della difesa della nazione, dell'esercito nazionale, del servizio militare. Ciò che si respingeva, ciò che in particolare costituiva oggetto di condanna e di preoccupazione per il futuro della Germania, era il militarismo inteso come concezione di vita, come espressione di gruppi sociali imperialistici, come strumento di conservazione all'interno e di aggressione nei confronti di altri popoli.
Il grido della nostra coscienza voleva essere accusa non contro il dovere della milizia in difesa della patria, ma contro la guerra, contro l'avventura della conquista e dell'assoggettamento e della spoliazione di un popolo da parte di un altro popolo.
La prigionia servì a chiarire le idee e a fugare in proposito ogni incertezza. Si giunse a poco a poco ad accusare il fascismo e il suo regime non di avere scelto male il campo, di non avere schierato il nostro Paese dalla parte dei più forti, di avere sbagliato all'ultimo momento rinunciando alla neutralità, ma di avere fatto della guerra un dato fondamentale della propria azione politica e dell'educazione dei giovani. Tutte le forme propagandistiche di esaltazione della violenza e della guerra, i miti della conquista, dello spazio vitale, del posto al sole, del popolo giovane, dei destini imperiali caddero ingloriosamente nella lurida, avvilente, fetida vita dei lager. Là si esaurì e tramontò la stortura di ritenere un folle e un criminale il Mussolini del 1940 mentre sarebbe stato savio quello del 1935 e del 1936. La catastrofe dell'8 settembre non poteva essere giudicata il frutto di un particolare errore di calcolo, di una campagna sbagliata, di un qualche sabotaggio, dell'ostinazione di un uomo ammalato, ma la conseguenza fatale di un'intera politica, lo sbocco inevitabile di una concezione falsa di dominio e di oppressione.