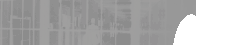Il viaggio dalle isole al continente non era certo una facile avventura. La sorveglianza degli alleati era costante e precisa, le incursioni sui campi di aviazione e sul porto di Rodi quotidiane, e d'altra parte i mezzi di cui disponevano i tedeschi non erano numerosi. Apparivano dei privilegiati coloro, nella maggioranza ufficiali superiori, che affrontavano il rischio del convoglio aereo. A un certo punto sembrò che i tedeschi non avrebbero mai avuto la possibilità di sgombrare interamente le isole: in realtà essi riuscirono non solo nell'intento di portare in Germania i militari italiani, ma deportarono anche gli ebrei di Rodi, che trovarono quasi tutti la morte nei campi di sterminio.
I tedeschi avevano escogitato un sistema di viaggio spezzato, appoggiandosi alla base di Lero ormai nelle loro mani, per mezzo di piccole imbarcazioni, caicchi o gazolini. Ma il pericolo non era diminuito, poiché se i caicchi riuscivano a evitare l'insidia dei sottomarini, non sfuggivano certo alle motosiluranti e agli aerei inglesi. Furono tentati pure trasporti con navi da carico di piccolo tonnellaggio, scortate da caccia: una di queste, quella partita da Rodi alla metà del febbraio 1944, naufragò presso il Pireo e nel naufragio perirono alcune migliaia di prigionieri. Il solco di sangue dell'8 settembre aumentò spaventosamente e le perdite furono tali quali non sarebbe costata la più accanita resistenza ai tedeschi.
Alla fine del gennaio 1944 al campo di Asguro, a Rodi, si trovavano internati circa 5000 soldati e una trentina di ufficiali rimasti con i loro reparti. Dopo alcune false partenze (si scendeva al porto, si restava una notte o un giorno ad attendere una nave che non giungeva e si ritornava infine al campo) la sera del 7 febbraio giunse l'ordine di partenza per la quasi totalità dei militari internati. Il movimento iniziò nelle prime ore del giorno 8. Al porto convennero altri gruppi provenienti da alcuni distaccamenti del campo di Asguro (Regio Vivaio, Candilli) e dal campo n. 1, che si trovava nella città. Le operazioni di imbarco sulla nave da carico "Oria" si svolsero con grande rapidità. Si scendeva nelle stive per mezzo di scalette di corda. Fu allora il primo contatto con la brutalità e l'odio dei tedeschi. Le S.S. e la Feldgendarmerie portavano via gli zaini migliori, soprattutto quelli degli ufficiali, nella speranza di far bottino (anche le gavette e le coperte erano oggetto di preda) e chi tentava di difendersi o di resistere alle offese veniva legato, minacciato con le pistole, schernito. Nelle stive alcuni energumeni, armati di bastoni, stipavano fino all'inverosimile gli italiani via via che giungevano. Il carico era enorme: si stava in piedi uno accanto all'altro, stretti e pigiati, senza possibilità neppure di muoversi, e già dai primi momenti l'aria era divenuta irrespirabile. Finalmente, quando la nave fu partita, dopo mezzogiorno, per tolleranza della scorta e buon volere dell'equipaggio (i marinai erano quasi tutti greci e pure alcuni italiani), la stiva venne scoperta, gli ufficiali e un certo numero di soldati poterono via via risalire sul ponte permettendo così al maggior numero di sedersi e respirare. Il viaggio fu tranquillo, senza allarmi, sempre in prossimità delle varie isole dell'arcipelago. A notte si giunse in una baia, quella di Lero. Sbarcati sotto la pioggia e il vento, si dovette compiere una lunga marcia per arrivare a Porto Lago, dove avremmo dovuto sostare.
I tedeschi avevano ricavato un campo cintando con un reticolato un tratto assai ristretto e angusto delle rovine della piccola città: il teatro, uno o due palazzi, una villetta dovevano essere le abitazioni degli internati italiani. C'era un corridoio di due o tre metri sul mare, due tratti di vie e una piccola piazza completamente sottosopra per l'effetto dei bombardamenti: buche enormi, alberi spezzati. Una lugubre atmosfera di distruzione, di abbandono, di silenzio. Sulle case era passata non solo la guerra: i tetti mancavano, le pareti cadevano a pezzi, di porte e finestre più nulla, le macerie erano ovunque.
Non solo era passata la guerra: su Porto Lago erano passati anche il saccheggio e la devastazione vandalica. Fu una vita dura. Peggiore anche delle esperienze più tristi nei campi di Germania. Mancava tutto: l'acqua, le cucine, i gabinetti; le cose più necessarie ed elementari: la legna, le marmitte, le gavette. Il giorno del viaggio non si mangiò. Neppure quello seguente: le ore passarono in appelli e controlli interminabili poiché il numero dei prigionieri risultava superiore a quello segnalato da Rodi. Ho visto i soldati, e specialmente un gruppo di marinai provenienti da Scarpanto, dove erano stati tenuti prigionieri per mesi in una grotta col solo nutrimento di cavoli lessi e già allora ridotti a scheletri, gettarsi avidamente sull'erba grama e sulle bacche amarissime di certi alberi rinsecchiti. Si dovette rimediare a tutto, con animo forte, come al principio del mondo. Si costruirono cucine, marmitte con i fusti di benzina, latrine; i soldati vennero riorganizzati in compagnie di 300. Restavano insormontabili la mancanza d'acqua e di legna. Non era possibile lavarsi e i tedeschi (sembrava facessero ogni sforzo per rendere più penosa la nostra situazione) ci fornivano appena l'acqua necessaria per confezionare il rancio che finiva per essere distribuito necessariamente, e così pure il pane, quando era già notte fonda in una confusione e in un disordine indescrivibili.
Ogni giorno era una battaglia contro le difficoltà e contro noi stessi: gli scoramenti, le privazioni, la fame e la stanchezza ci logoravano. I soldati erano inoltre costretti a lavorare nell'isola: partivano al mattino e ritornavano a sera abbrutiti dalle marce e dalla fame. Sono comprensibili la loro insofferenza e indisciplina; sono umanamente giustificabili, per quanto dolorosi, i furti che privavano alcuni del misero pezzo di pane: erano tutti giunti al punto del più elementare e feroce egoismo. Anche il tempo ci fu avverso. Pioggia e vento quasi in continuazione. Ad accendere qualche pezzo di legno fradicio c'era il pericolo di essere colti dalla fucilata improvvisa delle sentinelle. Una sera, un soldato fu colpito alla tempia e freddato. Eppure questi uomini dolenti, affamati, esacerbati l'uno contro l'altro, ebbero la forza di resistere ancora alle lusinghe e agli inviti; vi furono richieste di lavoratori; un ufficiale della milizia insistette per strappare ad alcuni un'adesione. Coloro che si piegarono, per fame, furono una minoranza del tutto trascurabile.
Nell'isola si trovavano altri campi nelle medesime condizioni del nostro e le difficoltà dei trasporti restavano pur sempre assai forti. Solo il 25 febbraio una prima parte riuscì a partire per il Pireo. L'imbarco avvenne sotto un bombardamento inglese. Considerammo perduti gli amici e i soldati che stavano per salpare. La sorte invece fu benigna e giunsero incolumi. Altri giorni ancora. Sembrava di vivere ormai in un incubo. Finalmente giunse anche per noi l'ora di lasciare Lero. Pomeriggio del 4 marzo: lunga marcia e imbarco su una nave da carico. Due stive, ognuna divisa in due piani. Si saliva sulla coperta oltre che per le scalette, anche per mezzo di corde: l'impaccio del pastrano, delle coperte, dello zaino, rendeva pericolosa ed estenuante la salita, ma ancor peggio era la discesa nelle stive per le spinte, i calci, le imprecazioni dei tedeschi. Si giungeva in fondo - una vera tomba fra le pareti di acciaio - con le mani sanguinanti. Una lampada all'estrema prua illuminava fiocamente la bolgia, sul fondo stavano casse contenenti parti di aereo. Quando si iniziava la discesa, i tedeschi strappavano dalle spalle gli zaini e li cacciavano giù dove nel buio e nella confusione avvenivano scene selvagge fra i soldati che tentavano di riprendere la propria roba e si disputavano con accanimento la proprietà di qualche misero straccio.
Due soldati, non reggendo allo sforzo della discesa, caddero e si spezzarono le gambe: restarono giù. Avevamo solo potuto compiere delle fasciature sommarie dato che un infermiere fortunatamente possedeva ancora qualche pacchetto di medicazioni. Restarono giù nello spasimo continuo, e sopraggiunse poi il delirio, dalla sera del 4 fino al mezzogiorno del 6: furono gli ultimi a lasciare la stiva perché fu necessario tirarli fuori con la gru.
La stiva venne stipata come al solito. Continuavano a scendere soldati e soldati e già l'aria era divenuta irrespirabile, il caldo soffocante. Cominciarono ad arrampicarsi alle strutture laterali nel tentativo di salire un poco e di allontanarsi dall'atmosfera stagnante del fondo. Poi giunse un silenzio disperato: la discesa e le urla erano cessate. Sul volto dei più vicini si leggeva l'ansia per il pericolo incombente e silenzioso; ma più che il timore di poter morire in quella bara dava angoscia il pensiero di dover trascorrere ore e ore senza aria, senza luce, gli uni ammassati sugli altri, senza poterci muovere, nel lezzo che diveniva di momento in momento più orribile. Una fatalità si aggiunse. Quella medesima nave che ci portava verso il Pireo, era giunta alcuni giorni prima a Lero carica di viveri (farina, patate, piselli secchi, carrube, ecc.). Gli internati italiani l'avevano scaricata e, affamati, non avevano esitato a mangiare crudo (la possibilità di cucinare mancava del tutto) ciò che riuscivano a sottrarre. Anche nella stiva, appena discesi, nonostante gli ufficiali si opponessero con tutte le loro forze, alcuni soldati racimolarono della farina che per la polvere e la sporcizia era divenuta completamente nera, la impastarono con un po' d'acqua lurida ed ebbero la forza di mangiarla. Ne derivò che la quasi totalità dei soldati fu presa da coliche e diarree violentissime, né c'era alcun modo, naturalmente, di giungere ai gabinetti: l'accesso al ponte, oltre che vietato, era impossibile, le corde erano state tolte e una scaletta di ferro che portava a un boccaporto era divenuta già dai primi momenti un grappolo umano senza che alcuno potesse tuttavia eludere la sorveglianza della sentinella tedesca. E così le stive si mutarono in una specie di fetida cloaca. Anche al piano superiore regnava la medesima atmosfera di muta rassegnazione e di sofferenza, benché giungesse un po' più di aria e di luce. Erano ammucchiati là, oltre i soldati, un buon gruppo di civili italiani, quasi tutti operai specializzati della Marina, a cui i tedeschi avevano promesso il rientro in Italia (ma penso che il loro destino sia stato la deportazione in Germania), e gli ammalati dell'ospedale di Lero tra cui molti vecchi e invalidi. Nessuna diversità di trattamento, nessun riguardo: probabilmente eravamo tutti accomunati nell'odio dei tedeschi per i «badogliani di Lero», che avevano resistito e combattuto. Finalmente, verso le 22 del 4 marzo, la nave lentamente si mosse. Fu un sollievo sentire che si andava e che ogni minuto ci avrebbe avvicinato alla terraferma e alla fine di quella spaventosa avventura. La massa inerte non aveva neppure la forza di pensare al pericolo dei sommergibili inglesi: si attendeva solamente. Né il 4 né il 5 marzo si mangiò. Durante il giorno tuttavia fu una lotta continua e ostinata fra gli italiani, specialmente quelli del piano superiore, che tentavano con ogni mezzo e astuzia di evadere dalla stiva e i tedeschi che non si stancavano ogni volta di ricacciarli giù. I più feroci erano gli ufficiali di marina. La nave era armata e scortata da tre cacciatorpediniere: vi fu un allarme nel pomeriggio del 5, ma fortunatamente non fu avvertito da alcuno nelle stive. Si giunse al Pireo alla sera, ma lo sbarco venne rinviato al mattino seguente. Fu la notte peggiore: la resistenza era giunta all'estremo, l'aria divenuta irrespirabile, la fame pungente e acuta. Bisogna pensare a qualcosa di più tragico e pauroso di quelle scene di maniera che certi film hanno divulgato sulla tratta degli schiavi o sui sottomarini immobilizzati sul fondo del mare. Uscimmo, il mattino inoltrato del 6, con l'animo di chi sa di aver superato un'ardua prova. Un chiaro sole splendeva. Vi fu ancora una marcia, che alle nostre forze stremate parve eterna, attraverso il Pireo e Atene. I tedeschi ci facevano percorrere le vie principali perché la nostra vergogna e umiliazione fosse a tutti palese. Giungemmo a un campo, detto Maginot, di fronte all'Acropoli. Là gli ufficiali furono divisi dai soldati. I tedeschi pensavano che i soldati tenessero duro e rifiutassero di collaborare solo per la suggestione e l'autorità su di essi esercitata dai loro ufficiali. Si ingannavano, naturalmente. Ma oltre ciò, al campo di Atene era già in atto quell'organizzazione, quella macchina nei cui ingranaggi venivano presi e compressi i prigionieri di guerra. Le sbobbe immangiabili, il pezzo di pane nero con la cucchiaiata di margarina o di marmellata di rape, il sequestro e il furto degli oggetti migliori, gli appelli quotidiani. Mancavano solo le disinfestazioni e le baracche di legno. E tuttavia il campo di Atene ci apparve come una fortunata sosta, un buon riposo dopo l'inferno di Lero e l'avventura della nave. C'era il sole tiepido e dolce della primavera, e lo godevamo come potrebbero goderlo, penso, i resuscitati.
C'era la speranza, la volontà, dopo la terribile prova superata, di resistere fino in fondo: i tedeschi avevano perduto la nostra anima!