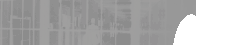1. Tra l'armistizio, la lotta, lo sbandamento e l'arrivo nei lager della Germania vi fu in generale un periodo più o meno lungo di transizione che coincise con un appassionato dibattito, con un vasto agitarsi delle coscienze, con una ricerca ansiosa della strada da seguire. In particolare per gli italiani lontani dalla Patria, per i quali il tentativo della fuga e la speranza del ritorno a casa non poté essere che breve, il tempo dell'attesa e del trasferimento in Germania fu consumato in una minuta analisi degli avvenimenti, in un vero e proprio processo al passato.
Soldati e ufficiali - solo in Germania i tedeschi divisero definitivamente gli uni dagli altri - affrontarono, in buona parte e senza più il diaframma della gerarchia, la discussione sui temi naturali della disfatta e della dissoluzione dell'esercito, mettendone sotto accusa il comando supremo e la condotta, e attraverso la valutazione dell'esperienza compiuta sotto le armi giunsero al giudizio di condanna della guerra e del fascismo. Così si formò una prima e generica piattaforma della resistenza: annodando e generalizzando la serie infinita di fatti e vicende di cui ognuno era stato testimone e partecipe e risalendo dal singolo episodio di incapacità, di tradimento, di servilismo, di impreparazione nell'esercito, a una visione generale della guerra ingiusta scatenata da un regime oppressivo e reazionario. Come nei confronti dei tedeschi il sentimento generale di fastidio e di odio aveva radici nella condanna degli aspetti esterni e appariscenti della brutalità militaresca, della durezza e rapacità verso le popolazioni soggette, del goffo e grossolano spirito di superiorità razzistica più che di una valutazione politica del fenomeno nazista, così del fascismo vennero primamente discussi e colpiti gli aspetti plateali e ridicoli, il tragicomico degli «otto milioni di baionette» o dello «spezzeremo le reni alla Grecia», il bluff del «nudi alla meta», del «tireremo diritto», del «chi si ferma è perduto», del «bagnasciuga», più che la sostanza politica del regime di conservazione sociale e di aggressività bellicista.
Ma una volta creata da parte dei più preparati e convinti l'atmosfera della resistenza antitedesca, era naturale che in essa venissero a confluire e a pesare le motivazioni più diverse e talvolta contrastanti. Sarebbe un errore ritenere che nell'iniziale e generico "no" di quella massa sterminata e incerta di uomini esistesse un'uniformità di giudizi e un'unanime salda volontà. Nemmeno al termine dell'esperienza unitaria dei lager si può dire che l'accordo sulla valutazione del passato e sull'impegno per il futuro fosse completo, tanto che non mancò chi - a torto - avversò già nei campi di concentramento alcuni tentativi di porre le basi di una futura Associazione Internati.
Un fenomeno così vasto come il rifiuto opposto da centinaia di migliaia di uomini ai tedeschi e ai fascisti e per le condizioni e per il modo con cui si manifestava non poteva necessariamente fondarsi solo su ragioni e motivi ideali. Non so quanti abbiano riflettuto sul fatto che la prigionia rispondeva pienamente alla condizione di pigrizia mentale, di mancanza di giudizio critico, di difetto di iniziativa autonoma che la dittatura fascista aveva creato in grandi masse di italiani. Decidere, scegliere, era un problema faticoso, uno sforzo che bisognava ormai compiere con i propri mezzi: la prigionia consentiva e determinava uno stato di sospensione, di interruzione della propria volontà che era pur sempre un rifugio, una pausa almeno per riprendere fiato. Non vogliamo parlare di quanti accettarono il fatto con lo spirito della più fatalistica rassegnazione, ma di coloro che rifiutarono un consenso ai tedeschi e ai fascisti perché si sentirono immaturi per una decisione cosciente e si chiusero nel "no" come in una botte di ferro. Acquistarono poi, molti, nell'esperienza dolorosa e nel contatto con altri più consapevoli, capacità e forza; si fecero coscienze libere e liberi uomini. Ma quanti non continuarono in quella «igiene» del non far lavorare né il cervello né il cuore, in quella sorta di vacanza della volontà rinviando a dopo la guerra ogni problema, ogni decisione? Passare nei lager come un pacco chiuso non era cosa facile, pure, qualcuno vi riuscì.
Su un altro piano debbono essere poste le ragioni dell'onor militare e della dignità umana: la collaborazione con i tedeschi apparve abnorme, soprattutto a molti ufficiali, con il giuramento prestato al re e con la dichiarazione di guerra alla Germania del 13 ottobre. Le formule di adesione - che subirono via via alcune modifiche - univano pur sempre al riconoscimento del fascismo la subordinazione al Reich tedesco o a Hitler, e rivelavano in tal modo la loro sostanziale natura di servile infeudamento. La fedeltà al governo legittimo poté essere per molti la spinta iniziale e servì pure più tardi come difesa e schermo nei confronti dei tedeschi, come giustificazione ufficiale per respingere e ritenere nulli gli atti della Repubblica di Salò e gli accordi realizzati tra Mussolini e Hitler. Il motivo ritorna ancora, ad esempio, nella presa di posizione, del 21 febbraio '45, degli ufficiali del campo di Fallingbostel che rifiutavano di diventare «liberi lavoratori»: «Gli ufficiali del campo non hanno aderito alla R.S.I. perché legati a un giuramento di fedeltà al quale il loro onore di soldati impone di prestar fede e dal quale nessuno può esimerli». Il governo di Salò non può nulla nei loro confronti proprio perché essi «non hanno, non possono e non vogliono riconoscere il governo di Mussolini». In questa affermazione decisa si unisce alla constatazione dei fatti («non hanno»), l'impedimento del giuramento prestato («non possono»), ma nello stesso tempo si va al di là della obiezione formale con una netta e volontaria condanna del governo di Mussolini. In essa si avverte l'eco della formula nitida e perentoria dei soldati di Cefalonia: «La Divisione Acqui, per concorde volontà degli ufficiali e dei soldati, non cederà le armi».
Il tema del giuramento fu oggetto di polemica in due diverse fasi. Nel periodo iniziale della prigionia, servì come strumento di lotta contro i repubblichini e i filotedeschi: su di esso si fece leva il più largamente possibile come su un motivo che poteva essere valido per tutti. In un secondo momento, quando il movimento di resistenza aveva acquistato maturità e consistenza, intorno al «giuramento» si polemizzò con l'intento di approfondire il processo critico della storia recente del nostro Paese, di mettere in piena luce le responsabilità del fascismo e dei suoi alleati e di dare alla lotta antitedesca un fondamento nazionale, anziché dinastico o istituzionale. Ricordo, ad esempio, la polemica scatenata nell'autunno del 1944 nel campo di Sandbostel dall'articolo che io lessi, nel domenicale giornale parlato, dal titolo: «La monarchia è morta?» Il comando italiano del campo si sentì in dovere di emanare un comunicato in cui precisava che lo scritto era espressione personale dell'autore e non coinvolgeva la posizione del comando, il che era del tutto naturale, e si preoccupò di far contrapporre attraverso successivi articoli del medesimo radiogiornale le tesi difensive dei Savoia e dell'istituto monarchico; il che contribuiva ad aprire il dibattito sul problema. Ma l'episodio testimonia pure del valore non esclusivamente formale che per molti ebbe il giuramento di fedeltà al re e al governo legittimo.