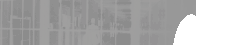Né si può dire che la via del campo di concentramento fosse una necessità ineluttabile. Non lo fu comunque per tutti e non mancò all'inizio e nei primi mesi di prigionia l'offerta della libertà attraverso il giuramento di fedeltà a Hitler prima e a Mussolini poi; non mancarono le pressioni e le lusinghe del collaborazionismo. Come accadde, dunque, il miracolo che centinaia di migliaia di soldati e di ufficiali di un esercito disfatto, e, nel crollo generale del proprio Paese, non solo scegliessero una prigionia che si presentava chiaramente con i caratteri della persecuzione e del rischio mortale, ma avessero la forza e il coraggio di respingere e di rifiutare un gesto che, se non la libertà, poteva offrire almeno più umane condizioni di trattamento?
E' vero che per molti il problema non si pose perché vennero gettati di colpo e senza remissioni nei lager, e quando comparvero gli emissari di Salò era ormai tardi sotto ogni punto di vista. E' pure vero che da parte di molti altri non si credette alla schiettezza delle offerte che vennero dai fascisti e dai tedeschi e che gli stessi nazisti, in particolare le S.S., non esitarono in qualche caso ad affermare crudamente che il Reich tedesco non aveva bisogno e non sapeva che farsene dei soldati italiani. E anche coloro che fecero il calcolo opportunistico di accondiscendere a qualsiasi giuramento pur di essere ricondotti in Patria si avvidero immediatamente che non era possibile prestar fede a quella lusinga. Ma tutto ciò non è sufficiente a spiegare l'immediatezza e la vastità dell'atteggiamento di resistenza assunto dai soldati italiani.
La verità è che tra l'armistizio dell'8 settembre e l'inizio dell'opera di adescamento dei tedeschi e dei fascisti vi furono episodi di aperta resistenza e che il solco di sangue di Cefalonia, di Lero, di Coo, della Balcania fece emergere le posizioni antitedesche in seno all'esercito, e che esse furono sufficienti a determinare la prima presa di coscienza del fatto che da una parte ormai stava l'Italia, i suoi interessi, il suo avvenire, e dall'altra i tedeschi, i loro servi, la loro guerra.
Anche chi non aveva dato il proprio contributo a quella breve battaglia disperata si sentì solidale con essa, e comprese che tutti gli italiani sarebbero stati d'ora innanzi identificati dai tedeschi con quelli che avevano sparato e resistito a Cefalonia, a Lero, in Grecia, in Albania. Questa prima confusa intuizione permise di non credere e di non cedere alle lusinghe. La sorte generale apparve legata a quella dei più animosi che nel momento del crollo avevano scelto risolutamente la via del combattimento, e a poco a poco si affermò la consapevolezza che quella resistenza era giusta e necessaria, e dovesse essere affrontata, non come una fatalità, alla quale i pochi avevano costretto i molti, ma come un dovere che valeva per tutti, quasi una riparazione per chi aveva ceduto le armi senza nulla tentare. Quelli che cedettero, quelli che si fecero amici dei tedeschi e, appena ricomparve lo spettro fascista, si proclamarono fedeli a Mussolini e alla sua repubblica, vennero considerati come traditori nei confronti soprattutto della lotta che con minore o maggiore vigore e fortuna si era ovunque svolta dopo l'8 settembre.
A questo primo notevole risultato la resistenza giunse rapidamente, in quanto gli animi respiravano ancora nel clima arroventato della ribellione antitedesca e della guerra e il peso della prigionia non s'era ancora fatto sentire in tutta la sua terribile gravità. Non fu difficile infatti combattere contro l'illusione opportunistica del ritorno a casa che poteva essere, soprattutto nei territori d'Oltremare e nei primi giorni di prigionia, il rischio o l'impedimento più grave per la resistenza. Si trattava non tanto di dimostrare a quanti erano in preda allo smarrimento e cadevano vittime di assurde speranze, l'impossibilità di un rientro in Italia; quanto bisognava convincere che non si doveva dare una qualsiasi adesione o riconoscimento ai fascisti, nemmeno nella speranza di rivedere le proprie case, nemmeno con l'impegno di affrontare più tardi in Italia la lotta. I fautori della resistenza immediata e intransigente si assunsero una grave responsabilità e ne sentirono, soprattutto in seguito, il peso, ma non può esservi dubbio che il dovere in quel momento imponeva di dire di no, che ai fini della lotta generale importava molto di più un rifiuto immediato e reciso nei confronti del nazifascismo che non magari un successivo contributo diretto alla lotta. L'adesione non avrebbe significato altro che un rafforzamento del fascismo e dei tedeschi senza mutare i termini sostanziali della situazione: accettare la prigionia era l'unico modo possibile e onesto di riconoscere la necessità di lottare contro il fascismo e contro la Germania.
I «volontari del lager» - che erano poi, nella massa dei prigionieri, la parte politicamente più matura - agirono nella consapevolezza di compiere il gesto più utile non per la sorte del singolo ma per la collettività nazionale, e chi ricorda attraverso quale tempesta di dubbi e quali difficoltà la scelta fu compiuta non può non riconoscere l'importanza estrema di una presa di posizione che determinò lo sviluppo successivo dell'odissea nei lager.
Può essere che qualcuno intendesse in quei primi tempi la prigionia come un sorta di «imboscamento», ma se illusioni o speranze di tal genere vi furono, trovarono poi una realtà ben diversa; la maggioranza degli ufficiali e dei soldati tuttavia comprese che quella scelta non rappresentava affatto la via più facile e più comoda, che la prigionia non sarebbe stata un quieto vivere, un'attesa tranquilla della fine del conflitto, bensì un rischio mortale.
Quando le lente tradotte dei prigionieri si mossero dai più diversi punti d'Europa verso la Germania, la massa degli italiani intuiva ormai la propria sorte. Alcuni immaginavano alla conclusione di quel viaggio l'eliminazione, la morte; altri, vittime delle speranze diffuse ad arte dai tedeschi, attesero fino all'ultimo che i treni piegassero dall'Austria verso il Sud, verso l'Italia. Ma anche costoro che avevano detto di no, nutrendo tuttavia nel cuore la fiducia che i tedeschi rispettassero impegni e promesse, continuarono, una volta dissolte le tenaci illusioni, a rifiutare ogni adesione al Reich tedesco e alla repubblica fascista.
I collaborazionisti non riuscirono a far presa con le vecchie parole dell'onore, della fedeltà, della Patria, anche perché, in modo scoperto e prematuro unirono agli «ideali» il ricatto del cibo. E il disprezzo e l'odio contro i fascisti si accrebbero, del resto, per il loro comportamento sciocco e impudente.
Ricordo che a Rodi, nei primi mesi di prigionia, i tedeschi affidarono il governo e la sorveglianza dei «campi di raccolta» a ufficiali e sottufficiali italiani che avevano aderito alla Wehrmacht. Questi continuavano a vestire la divisa italiana, portando per distinzione un bracciale giallo che li aveva fatti chiamare «canarini»: in realtà si trovavano in una meschina condizione di inferiorità rispetto ai tedeschi che, specialmente tra i soldati, non nascondevano il loro disprezzo nei confronti di quei mercenari.
Dove tutti peccano nessuno pecca: era questa in sostanza la molla segreta del loro agire. Costoro non indietreggiavano davanti alle più meschine e indegne disonestà: dal saluto fascista che un certo colonnello Manna tentava di imporre con ogni mezzo, alle denunce alla Gestapo degli italiani che erano riusciti a nascondersi presso la popolazione civile, al tentativo di captare gli incerti e gli ingenui strappando loro l'impegno a militare nel costituendo esercito di Mussolini che era pur sempre, dicevano, un esercito nazionale o a collaborare lavorando sotto la direzione dei tedeschi. Ma la propaganda grottesca di un certo maggiore Migliavacca non ci faceva solo sorridere. Costui aveva iniziato una campagna con spirito e metodo neosquadristi. Giungeva nei campi di raccolta su un autocarro traballante, accompagnato da alcuni militi in camicia nera, le maniche rimboccate, due stracci di bandiere italiane e tedesche, sparando in aria colpi di moschetto e bombe a mano ai lati della strada. Di fronte agli internati adunati i neofascisti consumavano anzitutto una colazione abbondante - scatolette di carne, pane, vino - che avrebbero dovuto essere, nella loro intenzione, un modo per adescarci, e che si risolveva invece in offesa e in disgusto. Poi il maggiore, le mani sui fianchi, improvvisava discorsi in cui le lusinghe sfacciate si alternavano alle minacce violente, tentando poi di carpire almeno un grido di assenso alla massa muta e sospettosa invitando a gridare «Viva l'Italia» e subito dopo precipitosamente «Viva Mussolini», «Viva la Germania». Solo qualche voce di timidi e spauriti accoglieva il primo invito, poi il silenzio tornava assoluto mentre il volto del maggiore si illividiva nell'ira. Quattro voci stonate attaccavano a cantare "Giovinezza" o "Lily Marlen" e l'autocarro ripartiva tra colpi di moschetto e bombe a mano.
Il carattere macabro di tale propaganda alimentava, attraverso la condanna del fascismo, la volontà di resistere, e i «collaborazionisti» diedero con la loro grossolana mancanza di intelligenza un indiretto ma notevole contributo al superamento dell'inganno del ritorno a casa e della propaganda sui temi dell'«onore» e della «fedeltà» all'alleato.
La guerra dei fascisti, d'altra parte, la guerra a fianco dei tedeschi, era finita irrevocabilmente l'8 settembre. E ben prima era finito il mito di Mussolini e della «sua» guerra, non solo per sfiducia nella vittoria, quanto per condanna della linea scelta, della condotta, della direzione della guerra.
L'esercito era da tempo in dissoluzione e preda in generale di stanchezza, di umiliazione, di corruzione. Per me, come per migliaia e migliaia di soldati dell'Egeo, un nome credo possa riassumere il processo di disgregazione del nostro esercito: Kucchignà, un distaccamento della tappa del Pireo per i soldati in transito verso le isole dell'Egeo.
Quando vi arrivai nel novembre 1942 era - sulla collina a chilometri e chilometri di distanza dal porto - un deserto di scatolette vuote. Al centro un edificio che non riuscivi a capire se diroccato o in costruzione; niente acqua, niente cucine, niente di niente. E questo doveva essere un campo contumaciale, dove centinaia e centinaia di soldati e ufficiali erano costretti ad attendere giorni e settimane il momento dell'imbarco. A breve distanza enormi edifici illuminati: là stavano, naturalmente, i tedeschi.
Quando, nella generale atmosfera di stanchezza e di sfiducia, giunse la notizia del colpo di Stato del 25 luglio, la sensazione che si diffuse nella maggioranza dei soldati fu che la guerra era finita o stava per finire.
La guerra era Mussolini e la sua caduta non poteva non coincidere, per il buon senso dell'uomo semplice, che con la fine dell'avventura dolorosa. L'unanime sentimento di sollievo e di gioia che si determinò anche nei soldati lontani dalla madrepatria non ebbe in generale e inizialmente una motivazione politica: non importava tanto che fosse crollata la dittatura, quanto piuttosto che potesse aver termine la guerra. Né ci si chiedeva in che modo e per quali vie si potesse approdare alla pace. A intuire la fatale necessità dell'urto con i tedeschi non furono molti e per lo più coloro che possedevano una capacità di discernimento politico. I comandi, per pigrizia o per inveterata abitudine alle direttive dall'alto, credettero per lo più ai comunicati ufficiali del governo Badoglio, senza avvedersi o non volendo accorgersi di quanto si stava sotterraneamente preparando e dello stato d'animo d'attesa della pace diffuso nella massa dei soldati.
La guerra continua! Ricordo un colonnello, un rudere centenario, vestito di panno nell'afosa estate di Rodi, che in un rapporto agli ufficiali di un raggruppamento di artiglieria, dopo avere ingiuriato Mussolini al quale fino allora aveva osannato, affermò che nella ristabilita fedeltà al re, tutto doveva procedere come prima: guerra e obiettivi di guerra, amicizie e alleanze.
Un secondo colonnello - comandava l'artiglieria contraerea e pareva giovane e risoluto - in un rapporto ad alcuni ufficiali, disse che era necessario stroncare nelle truppe ogni pensiero, ogni speranza socialista. Gli si obiettò che socialisti e comunisti stavano collaborando col governo Badoglio, che la situazione in Italia era mutata e che infine i soldati in quel momento non si preoccupavano tanto del socialismo, quanto della pace. Riaffermò che il nemico per l'Italia restava il comunismo, che la guerra per noi doveva continuare nella direzione indicata.
Un terzo colonnello, vecchio e stanco, comandante di un gruppo contraereo e che pure odiava gli amici tedeschi, a un ufficiale che lo informava, dopo il colpo di stato, che i tedeschi di una batteria da 88 stavano da alcuni giorni ricavando i dati di tiro relativi alle batterie italiane della zona per essere pronti al fuoco in caso di necessità, rispose che ciò non poteva essere vero dato che l'alleanza con i tedeschi era pur sempre solidissima. Al consiglio di comunicare almeno a sua volta la posizione topografica della batteria tedesca a quelle italiane, rispose di non poter egli assumersi una tale responsabilità e di non credere necessario creare allarmi, timori o speranze.
Mentre i tedeschi dal 25 luglio in poi ebbero la matematica sicurezza del «tradimento» italiano e della fatale lotta cui si andavano preparando con cura meticolosa, non vi fu in generale da parte dei comandi italiani, almeno alla periferia dello scacchiere bellico, un gesto, una disposizione, un qualsiasi avvertimento che potesse disporre gli animi e le forze a un rovesciamento di posizioni. I quarantacinque giorni trascorsero così per i soldati in un'attesa snervante e confusa e per i comandi nell'incapacità organica o voluta di prevedere lo sviluppo logico e inesorabile delle cose.
All'8 settembre la crisi dell'esercito era al colmo e in tanta irresolutezza, incapacità e insipienza, l'unico dato positivo consisteva nel generale spirito antitedesco dei nostri soldati. Se all'annuncio dell'armistizio vi fu una ribellione e una lotta contro i vecchi alleati, se nel crollo generale la resa dell'esercito ebbe l'onore delle armi, ciò fu possibile per la profonda carica di odio e di risentimento nei confronti dei tedeschi.
La storia dei rapporti tra i due eserciti dell'«asse» è ricca ormai di una serie di testimonianze che provano, senza possibilità di dubbi, la mancanza di simpatia, di cordialità, di stima tra soldati italiani e tedeschi. Più che di un'alleanza si trattò, dal primo momento, della subordinazione di un esercito all'altro, accentuatasi via via nel corso della guerra e divenuta intollerabile come una vera e propria servitù. Le ripercussioni di tale stato di sudditanza si acuivano dall'alto al basso, giungendo tra i soldati al bruciore di una umiliazione quotidiana, evidente nella disparità di trattamento e di condizioni. Il contatto con i tedeschi rendeva vivo nei nostri il senso nazionale e il disprezzo per chi ci aveva condotti a tale stato di cose e lo tollerava: creava un desiderio represso di riuscire a nostra volta in qualche modo a umiliare, magari con la beffa o lo scherno, quegli amici-nemici, di arrivare a batterli, a colpirli.
Penso a una batteria contraerea italiana nell'isola di Rodi, in postazione dal 1939. I soldati si sono costruiti faticosamente i loro alloggi; le brande con i cerchi dei fusti di benzina; non hanno mai visto zanzariere (e quella è la zona più malarica dell'isola); se vogliono verdura debbono coltivare un orto arido; sono costretti a lavorare assiduamente a postazioni e trincee, ma appena terminato un lavoro si muta piano e tutto è da rifare. Svaghi e distrazioni: nessuno. Licenze: neppure.
Giunge vicino a loro una batteria tedesca: operai greci lavorano ininterrottamente a costruire le postazioni, le camerate e tutto perché i tedeschi devono solo fare istruzione. Hanno letti con pagliericci e zanzariere, radio, due camion - italiani - per i loro servizi e per recarsi a Rodi in permesso. Mangiano meglio e lavorano meno. Una o due volte la settimana un cinematografo ambulante viene per loro: generosamente invitano anche i soldati italiani, che però non comprendono il film in tedesco, ma capiscono benissimo l'ingiustizia di una sorte diversa. Dall'aeroporto vicino partono secondo il turno regolare, in aereo, verso le loro case, in licenza. E i nostri comandi aumentano ancora per quanto possibile, con sfacciato servilismo, il triste disagio. Parve a un certo momento che i militari italiani dovessero recarsi alla batteria tedesca a pulire i proiettili, perché i soldati di Hitler dovevano solo prepararsi a combattere. Era la giusta conclusione: servi, e dunque lavori da servi. Si accorsero all'ultimo momento che era forse troppo, ma i nostri soldati vedevano e sapevano.
La conclusione non poteva essere altro che l'annientamento, da una parte, del cosiddetto «morale», e per i temperamenti più forti e illuminati un accrescersi d'odio e quasi un'ansia di giungere allo scontro. Forse sfuggì agli stessi ufficiali - certo i comandi superiori non ne ebbero esatta percezione - l'intensità dello spirito antitedesco in cui venivano a riassumersi, più o meno razionalmente, la stanchezza del fascismo e della guerra, le delusioni e le sofferenze di anni, il disgusto della «naia» pezzente.
La mancanza assoluta di una preparazione dell'armistizio, lo stato di disgregazione dell'esercito, il tradimento di alcuni comandanti che già avevano scelto la causa e la bandiera tedeschi, l'incapacità di decidere di altri paralizzati tra la paura di fronte al mito dell'invincibilità e della spietatezza tedesche e il timore di cadere in mano al «bolscevismo» dell'Unione Sovietica, la speranza assurda che la nostra capitolazione precedesse di poco la resa della Germania o potesse realizzarsi con il tacito consenso dei nazisti, tutto ciò non riuscì ad annullare l'esplosione antitedesca, ma solo a frantumarla in una serie di episodi disperati ed eroici di ribellione, di sfogo, di rissa confusa più che di ordinata battaglia.