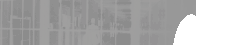UN GIORNO DELLA MIA VITA.
Era ancora buio e nevicava leggermente quando mi svegliai. Non credo di aver dormito più di un'ora quella notte, così lunga e tormentata. Il freddo intenso mordeva il mio corpo nudo. Per almeno mille volte mi ero girato e rigirato su un fianco, stringendomi addosso le coperte. Mi sentivo stanco e intontito, per il sonno che il freddo pungente mi aveva negato. Ero esausto. Tutte le ossa del mio corpo sembravano protestare per il tormento di un'altra notte passata per terra, su di un umido materasso di gommapiuma.
Neanche a dirlo: un'altra notte insonne. Avvilito e di cattivo umore me ne stavo tutto rannicchiato come una palla, per cercare di scaldarmi. Se avessi potuto prendere a calci qualcosa l'avrei fatto, ecco cosa provavo. Mi ero messo in ogni posizione possibile per sentire un po' di calore, ma il freddo mi penetrava ancora. Le mie tre coperte, troppo sottili, non potevano nulla contro il gelo terribile che entrava attraverso le sbarre di cemento della finestra senza vetri, situata sopra la mia testa.
«Dio mio, un altro giorno ancora,» pensai, ed era tutt'altro che un pensiero piacevole. Mi alzai e, nudo com'ero, attraversai nell'oscurità la cella per andare a orinare in un angolo. Faceva un freddo terribile. Il puzzo della mia urina mi rammentò lo stato in cui mi trovavo e il pavimento si bagnò qua e là.
Cumuli di rifiuti erano sparsi dappertutto. Nella luce fioca figure scure e misteriose sembravano gridarmi addosso dai muri sporchi e sfregiati che mi circondavano. Il fetore degli escrementi (1) e dell'urina era forte e persistente. Sollevai il piccolo recipiente dell'acqua dai rifiuti e mi sforzai di berne un sorso, nel vano tentativo di togliermi il cattivo sapore dalla bocca. Dio mio, faceva proprio freddo.
Man mano che l'alba si avvicinava il cielo si faceva grigio e i corvi si posavano sul filo spinato della recinzione coperto di neve, formando lunghe linee nere. «Un giorno mi sveglierò da quest'incubo,» pensai, mentre di nuovo mi stringevo addosso le coperte. C'era un silenzio sinistro, interrotto solo dal gracchiare dei corvi. Sicuramente molti ragazzi erano già svegli e probabilmente se ne stavano raggomitolati nelle loro coperte, cercando di scaldarsi. Mi deprimeva l'idea di un "porridge" freddo e insipido, due fette di pane e mezzo bicchiere di tè per colazione. Era demoralizzante anche solo a pensarci.
Poi l'alba arrivò. A poco a poco dalle ombre della notte il mio incubo giornaliero cominciò a prender forma. La sporcizia, i muri sfregiati, gli angoli più nascosti della mia tomba maleodorante mi diedero di nuovo il buongiorno. Restai disteso ad ascoltare il mio respiro leggero e il gracchiare dei corvi.
Fuori nel cortile la neve era alta. Lo sapevo fin troppo bene. Avevo passato metà della notte raggomitolato in un angolo, mentre la neve, entrando tra una sbarra e l'altra della finestra, si posava sopra il mio materasso.
La noia cominciò a prendermi con le prime luci del mattino. Di lì a poco la giornata che avevo davanti mi sarebbe sembrata interminabile e presto la depressione sarebbe divenuta di nuovo la mia compagna. Me ne stavo là, inquieto e congelato per il freddo. Provavo un po' di pena per me stesso, e il pensiero di un nuovo giorno continuava ad agitarsi nella mia mente.
Una chiave tintinnò contro l'acciaio della serratura. Passi pesanti lungo il corridoio ruppero brutalmente il silenzio. Fuori i corvi si alzarono in volo e il loro gracchiare assordante fu come un'esplosione. Cercai di immaginare il motivo di quei rumori. Mi prese il panico quando spalancarono con forza la mia porta d'acciaio. Un'ondata di uniformi nere irruppe nella mia cella, oscurando lo spazio della porta. Una voce rude e minacciosa mi urlò: «Alzati!».
Ero già in piedi prima che quella bocca arrogante avesse finito di parlare. Tremando mi avvolsi attorno alla vita il mio vecchio e consunto asciugamano blu.
«Orsi (2) in arrivo!» si sentì riecheggiare per tutto il braccio quando i ragazzi già svegli, messi in allarme da quell'invasione, si misero a gridare per avvertire gli altri della presenza dei secondini.
«Cambio di braccio!» sentii che dicevano, e non ebbi più dubbi riguardo a quello che stava per accadere. «Fuori! In fondo al corridoio. Muoviti!» abbaiò ancora quello.
Uscii dalla cella. Era pieno di uniformi nere, con i manganelli che penzolavano sui fianchi.
«Più svelto!» ringhiò un secondino.
Quattro forti mani mi afferrarono per le spalle, torcendomi le braccia dietro la schiena e sollevandomi da terra. Una massa nera si strinse attorno a me e con una mossa rapida e improvvisa mi trascinò via. Quando mi posarono a terra avevo addosso un paio di scarpe di cuoio tutte lucide, del tipo in uso nella prigione. Una delle guardie di quella squadraccia esagitata mi mollò un calcio in una coscia. Il mio stomaco si contrasse e provai un forte senso di vomito. Mi venne da gridare che mi arrendevo, ma rimasi muto. Di fronte a me si profilò un tavolo, attorno al quale si andò radunando una mezza dozzina di secondini che mi osservavano attentamente. Ero la loro prima preda.
Fui lasciato in piedi in mezzo a quell'orda nera, che attendeva dal capo il segnale d'inizio.
«Bene,» urlò colui che si era autoinvestito della carica di tiranno. «Togliti l'asciugamano e girati. Piegati in avanti e toccati le punte dei piedi.»
Feci cadere l'asciugamano e mi girai su me stesso. Poi rimasi immobile, imbarazzato e nudo, mentre i loro occhi ispezionavano il mio corpo.
«Hai dimenticato di fare una cosa,» grugnì il capo.
«Non mi piego,» balbettai, ostentando una sicurezza che certo non avevo.
«Piegati in avanti, straccione,» mi disse tra i denti, e dal tono della sua voce capii che la sua pazienza era al limite. «Ci siamo,» pensai.
«No, non mi piego,» dissi.
Scoppiarono tutti in un riso forzato e presero a insultarmi e a deridermi.
«Non vuole piegarsi!» sghignazzò quel bastardo, sicuro di sé.
«Non si piega! Ah! Ah! Non si piega, ragazzi!» continuò, rivolgendosi al mucchio impaziente.
«Dio mio, eccoci,» pensai. Quello si mise davanti a me e mi colpì mentre stava ancora ridendo. In pochi secondi, in mezzo a lampi bianchi, caddi a terra sotto una pioggia di colpi provenienti da ogni parte. Mi rimisero in piedi e mi gettarono come un sacco sopra il tavolo, a pancia in giù. Delle mani mi afferrarono per le braccia e per le gambe, allargandomi come fossi un pezzo di cuoio. Uno di loro, prendendomi per i capelli, mi tirò la testa all'indietro, e un pervertito cominciò a perquisirmi l'ano.
Tutti si divertivano come matti e ridevano a più non posso. Tutti, tranne me. Una pioggia di pugni cominciò a cadere sul mio corpo nudo. Mi contorcevo per il dolore.
A ogni colpo quelli stringevano sempre più la presa. Mi tenevano la faccia schiacciata contro il tavolo e il mio sangue ne sporcò la superficie sotto il mio viso. Ero stordito e stravolto dal male che provavo.
Alla fine mi sollevarono e mi lasciarono cadere a terra. La mia prima reazione fu di avvolgermi attorno alla vita, tutta coperta di segni rossi, l'asciugamano che avevo vicino. Poi di nuovo, da dietro, mi presero per le braccia e mi trascinarono verso l'altro braccio del Blocco. Per un attimo riuscii a vedere uno dei miei compagni che veniva picchiato e sbattuto sul tavolo. Sentii che, più lontano, stavano tirando fuori a calci qualcun altro da una cella. Aprirono una porta, mi sbatterono dentro e la richiusero con forza.
Rimasi sul pavimento di cemento, con il cuore che batteva all'impazzata e i nervi a pezzi. «Poteva andar peggio,» cercai di dire a me stesso per consolarmi, ma ciò non convinse né me, né il mio corpo in preda al dolore.
Il freddo mi fece allontanare dal pavimento. Ogni parte del mio corpo protestò mentre mi alzavo. Un rivolo di sangue mi uscì di colpo dalla bocca, gocciolò sulla mia lunga barba incolta e finì per terra. I lividi e le escoriazioni sembravano formare sulla mia pelle un fine disegno. Tremavo. Non avevo avuto molto tempo per spaventarmi: tutto era successo troppo in fretta. Grazie a Dio non stavo ancora dormendo quand'erano arrivati.
«Gliela faremo pagare a quei bastardi, prima o poi. Vedremo allora quanto forti sono,» pensai, sputando in un angolo un grumo di sangue. « Vedremo quanto bravi sono...»
Cominciai a camminare per la cella. Il freddo continuava a entrare attraverso la finestra senza vetri e io, con solo un asciugamano addosso, ne avvertivo tutta l'intensità. Dio mio, stavo proprio male.
Sentii trascinare altri corpi lungo il corridoio. Quei bastardi gridavano come forsennati, divertendosi con il sangue e il dolore, nostri naturalmente. Chissà quando ci avrebbero dato una coperta. Una cella vuota e gelida, un corpo congelato, dolorante e coperto di segni neri e blu; fuori dalla porta un mucchio di psicopatici che picchiavano giovani uomini fino a ridurli in poltiglia, e non era ancora l'ora di colazione...
«Cristo, può andare peggio di così?» mi chiesi, ma subito mi risposi: «Lo sai fin troppo bene». E questo mi preoccupava molto.
Continuai a camminare per la cella incurante del dolore che ciò mi provocava, cercando di riscaldarmi. I miei piedi erano diventati blu per il freddo, così pensai che il mio corpo stesse per essere sopraffatto dal gelo. Lo shock stava passando, ma il dolore e il freddo continuavano implacabili.
La neve aveva cominciato a cadere di nuovo e non c'erano più corvi sul filo spinato. Alcuni miei compagni, dalle finestre delle loro celle più avanti nel braccio, parlavano di quello che avevano subìto e delle loro ferite.
Sentii il rumore del carrello che si avvicinava: la colazione stava arrivando, ma ancora niente coperte e materassi. «Non dimenticarti di vedere chi sono i secondini in servizio oggi, quando aprono la porta,» ricordai a me stesso. «Potremmo averne di tranquilli, ora, dopo quello che è successo stamattina,» pensai mentre la mia porta veniva aperta. Due inservienti, con un ghigno sulla faccia da poco lavata, mi ficcarono nelle mani la colazione: un bicchiere di tè in una e una scodella di porridge con due fette di pane nell'altra.
Un tipo piccolo, dalla faccia di topo e con un berretto nero in testa, si sporse oltre la porta contro cui si era appoggiato. Con un sorriso affettato disse: «Buon giorno! Preferisci infilarti l'uniforme della prigione, andare a lavorare, pulire la cella, lavarti, o lucidare i miei stivali...?» ;.
«No?... Bene, vedremo dopo!»
Se ne andarono sbattendo la porta.
«Bastardi!» dissi, mettendomi in un angolo a esaminare la seconda disgrazia del giorno, la colazione. Pescai le due fette di pane dal porridge denso, ne salvai la parte asciutta e lanciai il resto, porridge e tutto, contro il muro. Disgustato, dovetti letteralmente forzare la mia bocca per ficcarvi dentro quei miseri pezzi di pane e il tè freddo. C'era un gelo terribile, a tal punto che tra un sorso e l'altro di tè dovetti continuare a camminare. Pensai ai tre secondini che erano rimasti fuori dalla porta quando mi avevano portato la colazione. Erano «A», «B» ; e «C.» Proprio quello che ci voleva: tre torturatori veri e propri, che sarebbero stati qui tutto il giorno. «Meraviglioso,» mi dissi.
Il secondino che mi aveva appena parlato era «A», spietato, scaltro e intelligente quando si trattava di torturare uomini nudi. Niente tortura fisica con lui, solo un lavoro puramente psicologico e giochi astuti. Era un tipo da campo di concentramento di Belsen: come la maggioranza dei secondini traeva grande soddisfazione nel calpestare la dignità dei prigionieri di guerra. Voleva sentirsi sempre il più importante. Ma non erano forse tutti così, una volta indossate le loro uniformi nere dai bottoni lucidi e ricevuto il manganello e la pistola?
La seconda guardia che avevo visto era «B», un fanatico bigotto, di corporatura media, capelli neri, bell'aspetto e pieno di energie. Alcolizzato, era abile nell'uso del manganello, specialmente con i ragazzi giovani: questa era divenuta per lui una pratica abituale. L'ultimo secondino, forse il peggiore, era «C». Ci odiava più di «B», il fanatico, e si faceva in quattro per dimostrarlo. Non sorrideva, né parlava mai, se non per fare commenti offensivi o lanciare insulti. Ce l'aveva con tutto e tutti, e a noi toccava subirlo.
«Tre perfetti bastardi,» pensai, e maledii il freddo, il mio corpo dolente e gli spasmi della fame che non mi avevano mai lasciato.
Ripresi il mio viaggio senza meta, camminando in cerchio per la cella come un porcellino d'India. Mi fermavo qua e là; per un secondo o due, a decifrare i nomi incisi sulla porta e sui muri, semplice testimonianza e ricordo di altri che erano stati e ancora si trovavano nelle mie stesse condizioni. Da quei nomi sembrava trasparire tutta la fierezza di chi li aveva scritti e aveva conosciuto la tortura. «Hanno tutto il diritto di essere fieri,» pensai, mentre via via mi spostavo per leggere le frasi e le parole scritte a tratti irregolari nella nostra lingua, notando i progressi che i ragazzi degli altri bracci stavano facendo nelle lezioni di gaelico (3).
«Lezioni di gaelico,» dissi di nuovo. Suonava piuttosto strano, e lo era veramente. Significava infatti stare contro la porta della cella ad ascoltare un tuo compagno, l'insegnante, che dal fondo del corridoio gridava la lezione del giorno con quanta voce aveva in gola, una volta che i secondini se n'erano andati via per il pranzo o per la cena.
Continuai a camminare. Il freddo pungente non accennava a diminuire. Se non fossi riuscito ad avere un paio di coperte sarei stato presto nei guai. Ma noi non dovevamo chiederle: l'avevo imparato da molto tempo. Mostravi un segno di debolezza e ti eri già scavato la fossa. Per di più c'erano nel braccio altri quarantatré miei compagni che si trovavano nelle mie stesse condizioni. «Smettila di lamentarti e cerca di scaldarti un po',» rimproverai me stesso per aver giocato pericolosamente con pensieri di autocommiserazione e per essermi soffermato troppo a lungo sulle mie privazioni. Continuare a farlo mi avrebbe portato alla depressione, e la depressione era peggio del freddo e del mio corpo dolente messi assieme.
Rivolsi allora i miei pensieri al cibo. Venerdì: pesce per pranzo, patate fredde e piselli duri. Ma c'era sempre la vaga speranza che li portassero caldi e con un po' di sale.
Non so perché, dal momento che non era mai successo. Forse era solo qualcosa da poter aspettare con trepidazione, come di vincere alle corse o all'"Irish Sweepstakes" (4).
«Più facile vincere alle corse,» dovetti ammettere. Eppure cos'altro era la nostra esistenza, se non riuscire a sopravvivere tra uno schifoso pasto freddo e l'altro, creandoci false speranze e aggrappandoci a ogni minimo rumore che sentivamo? «"Scéal, scéal, scéal!"» Adoperavamo talmente tanto la parola che in irlandese significa «notizie» che questa veniva usata persino dai secondini.
«Hai qualche "scéal"?»
«Hai sentito altre "scéal"?»
«Le "scéal" sono tristi, brutte, bellissime.»
Era comprensibile. Dovevamo pur avere qualcosa per cui sperare, su cui riflettere, da attendere o a cui aggrapparci. Era incredibile come una piccola e buona "scéal" potesse rianimare tutto il braccio. Come quella volta della marcia da Coalisland a Dungannon (5), quando uno dei ragazzi ci portò la notizia di quante persone vi avevano partecipato, insieme a una fotografia fatta entrare di nascosto in carcere. Mi era venuto da piangere e sono sicuro che non pochi ragazzi lo avevano fatto. Non lo dimenticherò mai. Stavo vivendo in un incubo, senza poter vedere neppure un volto amico. Quando venne il mio turno guardai la foto e mi sembrò di non essere mai stato così felice in vita mia. Continuavo a guardarla e riguardarla, e non avrei mai voluto staccarmene. «E' proprio gente in gamba,» mi ero detto, sentendomi fiero di lottare per loro. Al solo pensiero mi viene ancora un nodo alla gola. «Dio mio, se non fosse così freddo e non stessi così male potrei cantare una canzone per far passare il tempo. Ma non sono nello stato d'animo, né nelle condizioni fisiche per farlo...»
Nessuno parlava alle finestre. Eravamo troppo intenti a camminare per la cella e a leccarci le ferite.
«Orsi in arrivo!» gridò qualcuno, avvertendoci che un secondino si trovava nel braccio. Quella era l'espressione che veniva usata quando riuscivamo a percepire il tintinnio di una chiave, lo scricchiolio di uno stivale o intravedevamo un'ombra passare: tutti segni che tradivano la presenza di una guardia. Mi incollai alla porta e premetti l'occhio contro la fessura tra questa e il muro. L'avevo già notata in precedenza e, come speravo, mi offrì una ristretta ma preziosa vista su alcuni metri di corridoio. Intravidi prima un'ombra, poi la figura di «A» che ben conoscevo. Aveva in mano alcune lettere e dei pacchetti di fazzoletti di carta.
«Secondino con alcune lettere!» gridai in gaelico con quanto fiato avevo in gola, per distendere i miei nervi, tesi e provati. «A» sobbalzò. La mia voce, rompendo il silenzio, lo aveva sorpreso, ma continuò ciò che stava facendo. Era normale mettersi a gridare quando si capiva cosa stava succedendo: permetteva di farlo sapere agli altri. Non c'era nulla di più stressante e terribile dello star seduti, nudi, dietro una porta, senza sapere cosa stava per accadere quando il pericolo era vicino. E nelle condizioni in cui ci trovavamo il pericolo era costantemente in agguato.
Ai secondini non andava che nel braccio si urlasse in gaelico o che usassimo la nostra lingua per parlare tra di noi. Ciò li faceva sentire degli estranei e li metteva persino in imbarazzo. Non riuscivano a capire cosa dicevamo. Temevano che ogni parola fosse riferita a loro, e non si sbagliavano poi di tanto.
Ripresi il mio viaggio senza meta. Nel momento in cui passai vicino alla finestra una chiave colpì il metallo della serratura. Un brivido mi percorse tutto mentre questa vibrava e la mia porta veniva aperta. «A» ; se ne stava sulla soglia, stringendo in mano un paio di pacchetti di fazzoletti di carta e alcune lettere.
«Ho un pacco per te,» biascicò con il suo odioso accento non staccandomi gli occhi di dosso, con quel suo sguardo arrogante che significava: «Io sono superiore a te».
«Un pacco,» mi dissi. «Due pacchetti di Kleenex...»
«Sei fortunato. Sei l'unico che oggi ha ricevuto un pacco.»
Dio mio! Mi dava il vomito. Questo era «A», lo psicologo al lavoro. Leggendomi come fossi un libro aperto mi disse:
«Perché non indossi l'uniforme della prigione? Potresti avere dei vantaggi...».
Mi venne da dirgli cosa poteva farsene dei suoi maledetti privilegi e dei Kleenex, ma i fazzoletti mi servivano per poter resistere sul pavimento gelido. «Non perdere la testa, Bobby,» mi dissi mentre mi allungava una Parker per firmare il registro. Gli piaceva moltissimo tutto questo. Era come se gli stessi firmando un contratto da un milione di sterline per tre miseri pacchetti di Kleenex. Aveva anche una lettera per me: me n'ero accorto subito. Stava aspettando che gliela chiedessi, ma feci finta di niente. Rimise la sua bella penna nel taschino, sogghignò e fece alcuni commenti sul puzzo del mio corpo non lavato, nonché sul terribile fetore della mia cella. Fece poi per chiudere la pesante porta d'acciaio.
«Toh, c'è anche una lettera per te,» disse, e me la porse.
La presi e la tenni in mano come fosse un bimbo appena nato. La porta fu richiusa con forza. Premetti l'occhio contro la fessura, per vedere se si stesse dirigendo verso il suo ufficio, in cima al corridoio. Proprio così ;. Gridai in gaelico «Orso in partenza!» per farlo sapere ai ragazzi, poi mi ritirai in un angolo.
Mi sentivo un'altra persona con i miei tesori: una lettera e tre pacchetti di fazzoletti. Sistemai questi ultimi per terra e mi ci misi sopra. In confronto al pavimento nudo sembrava di stare sopra un tappeto lussuoso. Estrassi dalla busta già aperta la mia preziosissima lettera, già letta diverse volte e censurata. In alcuni punti era sfregiata da linee nere. «Ma non è così malridotta come quella del mese scorso,» pensai. Riconobbi immediatamente la scrittura familiare di mia madre. «Cara la mia vecchia, non mi delude mai!» Cominciai a leggere:
"Caro figlio mio,
spero che tu sia riuscito ad avere la mia ultima lettera. Sono stata molto in pensiero per te e per i tuoi compagni. Fa freddo lì? So che hai solo tre coperte. Ho letto nell'«Irish News» che molti di voi hanno una brutta influenza. Copriti meglio che puoi. Dirò una preghiera per tutti voi. Qualche giorno fa tua sorella Marcella ha organizzato una festicciola per il primo compleanno di Kevin (6). E' un bambino meraviglioso. Tu non l'hai ancora visto! Tuo padre e tuo fratello ti salutano, e così pure Bernadette e i signori Rooney. Domenica sono stata alla marcia. C'era" .............................................
(Censurata! Bastardi! Li maledii.)
"Qui va tutto bene. Forse non manca ancora molto.
La settimana scorsa i soldati inglesi sono venuti a perquisire la casa per ben due volte e hanno fatto a pezzi l'arpa celtica che i ragazzi delle cages (7) mi avevano mandato per Natale. Non credo che i soldati inglesi siano molto contenti in questo momento. Con tutti i ......................................................... devono aver perso la testa, figlio mio.
Tuo fratello Seán è stato a Killarney. Per le strade e sui muri cerano delle scritte a sostegno dei" ...................... (I Blocchi H! Bastardi! mi dissi.)
"Ora termino qui. E' cominciato a nevicare. Spero tanto che tu stia bene. Ti siamo tutti vicini. Domenica ho avuto con me il bambino (1). Dice che quando sarà grande diventerà un volontario e ti tirerà fuori da quel posto orribile. Che Dio lo aiuti. Verrò con tuo padre e Marcella alla prossima visita, che sarà il 12. Dio vi benedica tutti. Ci vediamo presto. Ci manchi.
Tua madre"
«Che Dio la protegga!» dissi.
Visite oggi!
Yahoo!
«Tutto bene, Bobby?»
«Sì, Seán. Mi sono ricordato che oggi è il mio giorno di visita. Me ne sono completamente scordato, dopo che ci hanno così massacrato stamattina,» dissi al mio vicino di cella.
«Cosa ti hanno fatto, Seán?» gli gridai.
«Mi devono aver rotto il naso, Bobby. E tu?»
«Non sto poi tanto male. Molti lividi e qualche taglio, come al solito. Sta' a sentire. Ho ricevuto una lettera. Devono esserci state diverse bombe e una grande partecipazione alla manifestazione. Me l'hanno censurata come sempre, ma saprò tutto durante la visita. Adesso riprendo a camminare, perché devo scaldarmi. Fa proprio freddo, amico mio. Mi faccio sentire più tardi.»
Yahoo! Visite oggi! Dove sono quelle maledette coperte? Sto morendo di freddo.
Oggi potrei rivedere mio figlio. Sono passati nove mesi dall'ultima volta. E' pericoloso per la mia salute. «Corro un rischio ogni volta che lo vedo,» pensai, «ma ora devo proprio vederlo di nuovo...»
Il solo pensiero delle dure perquisizioni che avrei dovuto subire per quella visita di solo mezz'ora, l'unica in un mese, mi demoralizzava.
«Orsi in arrivo! Orsi in arrivo!»
Mi precipitai come un fulmine alla porta e appoggiai l'occhio contro la piccola fessura. Nulla! Non riuscivo a vedere nulla! Li sentivo, ma non ero in grado di vederli.
«Perquisizione! Perquisizione!»
Dio mio, di nuovo! Non c'era nulla da perquisire in quelle celle maledette! Avevamo avuto già una gran bella perquisizione al mattino.
Sentii scattare la serratura di una porta. Intravidi «B» e « C» entrare nella cella di fronte alla mia: era quella di Pee Wee. « C» si mise a gridare, ma non capii cosa stesse dicendo. Le sue parole si udivano appena. Riuscii tuttavia a sentire «B» che urlava:
«Piegati in avanti, essere schifoso!».
Dio mio, stavano perquisendo Pee Wee. Non aveva ancora diciotto anni e quelli lo stavano costringendo con la forza a piegarsi in avanti per ispezionargli l'ano. Udii il rumore sordo e fin troppo familiare dei colpi che piovevano sul suo corpo nudo.
«B» e «C» uscirono dalla cella, soddisfatti del loro lavoro: e sorridenti, come due gangster.
«Sporchi bastardi!» gridò loro Seán.
«'A', chiama un furgoncino per il Blocco delle punizioni. Pee Wee O'Donnell ha appena assalito 'C',» disse «B» ridacchiando.
Male, maledettamente male se portavano Pee Wee in cella di punizione. Faceva parte del loro sporco gioco. Accusavi i secondini di averti aggredito e ti ritrovavi incriminato per aver dichiarato il falso, o addirittura per averli assaliti... «Criminali! Non sono altro che un mucchio di luridi criminali di guerra, dal primo all'ultimo!» mi dissi.
Trascinarono Pee Wee fuori dalla cella. Intravidi la sua figura, piccola e indifesa. Aveva il volto sporco di sangue, l'occhio destro gonfio e il naso che sanguinava. In cella di punizione, con la forza, lo avrebbero lavato e gli avrebbero tagliato i capelli. In altre parole, quel giorno Pee Wee sarebbe stato picchiato a sangue per ben tre volte.
Sul braccio incombeva un silenzio mortale. Quell'atmosfera terribile non ci lasciava e la tensione, fortissima, non accennava a diminuire.
«Te la faremo pagare, 'C',» mi dissi. «Te la faremo pagare.» ; Mai in vita mia ero stato così convinto di quello che dicevo come in quel momento.
Tremavo dal freddo, ma decisi di non abbandonare il mio spioncino di fortuna, nel caso in cui quelli decidessero di tornare e fare la stessa cosa con qualcun altro. Li udii, nel loro ufficio, ridere e vantarsi di come avevano conciato Pee Wee.
Il resoconto di quello che era successo fu fatto arrivare di cella in cella fino all'O/C (9) del nostro braccio.
Di lì a poco sentii che «B» stava trascinando rumorosamente un secchio lungo il corridoio. Gridò a «C» qualcosa riguardo allo svuotamento dei buglioli, facendo in modo che tutti noi sentissimo. Sarebbero entrati con il secchio nelle celle e, con un calcio, avrebbero rovesciato sul pavimento il contenuto dei nostri fetidi recipienti. Noi potevamo svuotarli fuori dalle finestre o sotto le porte solo alla sera. Sapevo che «B» stava mettendo alla prova i nostri nervi già logori. «A»avrebbe dovuto fare il lavoro, ma forse non si sarebbe arrischiato. I ragazzi erano al massimo della collera per quello che era accaduto a Pee Wee. Avremmo avuto sicuramente altri guai. Per di più non ci avevano ancora portato le coperte.
Mentre pensavo a questo e al freddo che mi torturava gli inservienti vennero avanti lungo il corridoio, spingendo un carrello carico di materassi e coperte.
«Coperte in arrivo!» gridai in gaelico per farlo sapere ai ragazzi. Dalle celle si alzarono grida ed esclamazioni. Cominciarono ad aprire le porte. Dopo un'attesa che mi sembrò un'eternità, a causa del freddo pungente che si faceva sempre più intenso, finalmente spalancarono la mia. Gli inservienti gettarono sul pavimento tre coperte trasparenti e un materasso di gommapiuma, sporco e malridotto. «C» mi diede un'occhiata, dalla quale trasparì tutto l'odio che provava per me. Poi se ne andò sbattendo la porta.
«Anch'io ti odio,» pensai, e mi precipitai verso le coperte. Me ne avvolsi una attorno alla vita, ne sistemai un'altra sulle spalle a mo' di scialle e infine mi misi l'asciugamano attorno alla testa e al collo, come fosse una sciarpa. Spinsi quindi il materasso puzzolente contro il muro e mi ci sedetti sopra, avvolgendomi la terza e ultima coperta attorno ai piedi.
Sembravo un prigioniero di "Stalag 18" o di Dachau e, a dir la verità, mi sentivo proprio così. La pelle del mio viso cominciò a irritarsi a contatto con l'asciugamano e le dure coperte di crine presero a tormentare il mio corpo dolorante. Faceva freddo. Dalla sua finestra un ragazzo gridò che aveva ripreso a nevicare. Mi sarebbe nevicato addosso, com'era avvenuto la notte precedente e quella prima. Non mi muovevo. «Povero Pee Wee. Probabilmente ora è in cella di punizione, più morto che vivo. Dio mio, è stata una mattina terribile,» pensai, sentendomi esausto. Improvvisamente tutta la stanchezza di due notti insonni mi cadde addosso. I miei piedi cominciavano a scaldarsi un po' e io mi ritrovai a pensare alla visita del pomeriggio. Il silenzio era sceso nel braccio. Si sentivano solamente, di tanto in tanto, le risa sguaiate di «B» e «C». «B» sarebbe ritornato dopo cena, ubriaco e pericoloso. Chiusi gli occhi, sperando che il sonno mi permettesse di evadere fino all'ora di pranzo. Era dura, molto dura.
*
Mi alzai pian piano, arrischiando lentamente ogni movimento. Una volta in piedi sistemai il materasso contro il muro. Distesi una coperta per terra e, con un'altra attorno alla vita e l'asciugamano che mi copriva le spalle, ricominciai come un nomade il mio viaggio senza meta. Faceva ancora freddo, ma non era più così pungente come di primo mattino. Fuori la neve alta ricopriva ancora il cortile. C'era poca luce, sebbene fosse già mezzogiorno.
«Il pranzo sarà qui a momenti,» pensai.
Solo poche ore mi separavano dalla visita. Mi confortava il pensiero di vedere la mia famiglia. Quello era il momento più importante di ogni mese, così lungo e tormentato. Solo dodici visite in un anno! Mezz'ora di relativa felicità per ogni visita, ovvero sei ore di relativa felicità all'anno. Feci un rapido calcolo: sei ore su 8760. Sei misere ore, quando loro perseguitavano te e la tua famiglia ogni minuto, ogni singolo minuto dell'anno!
Continuai a camminare, mentre la rabbia cominciava a crescermi dentro. « Bastardi!» dissi, e mi fermai a guardar fuori, tra una sbarra e l'altra di cemento della mia finestra senza vetri.
«Non avrai neppure questo per molto tempo ancora,» ricordai a me stesso, pensando che avevano cominciato a sbarrare le finestre degli altri bracci con tavole e lamiere ondulate, così da non lasciare entrare la luce e impedire di guardar fuori. Non c'era comunque molto da vedere, a parte gli uccelli, il cielo notturno e le nuvole. Il resto era proprio deprimente, sebbene la neve di quei giorni fosse un fatto inusuale. Stava sospesa su tutti quei chilometri di orrido filo spinato e si attaccava alle lamiere, di solito così anonime e squallide. Ogni cosa era di un grigio mortale o di un candore intenso e splendente. Finché la neve non si fosse sciolta il buio avrebbe portato un po' di vita, con le mille luci multicolori e tutti quei punti luminosi che illuminavano il tappeto bianco.
Che sollievo e piacere sarebbe stato poter camminare su un prato verde e lussureggiante, toccare i fili d'erba scintillanti, accarezzare la fresca superficie della foglia di un albero... Oppure star seduti in cima a una collina e abbracciare con lo sguardo la valle sottostante, ascoltarne i rumori di primavera, respirare il profumo dell'aria fresca e pura, con attorno nient'altro che uno spazio infinito... Questa era la libertà: libertà di ritornare a vivere. Mi allontanai dalla finestra per riprendere il mio cammino senza meta, un po' rattristato da quei pensieri. Guardai i muri della mia cella, sporchi di escrementi e maleodoranti, poi i mucchi di spazzatura e i rifiuti di cibo in decomposizione, ammassati negli angoli del pavimento bagnato. Guardai il mio materasso sudicio, tutto strappato a causa delle mille perquisizioni, il soffitto macchiato di tè per attenuare il bagliore della luce accecante che vi si rifletteva sopra, la porta sfregiata di segni, il bugliolo lurido e puzzolente che si trovava vicino a essa. Diventava sempre più difficile riuscire a evocare l'immagine di quel bellissimo prato lussureggiante. Ogni minuto l'ambiente da incubo in cui mi trovavo mi gridava addosso. Non c'era alcun modo di sfuggire a quell'incubo, se non con la resa. Alcuni, solo pochi, avevano già ceduto, indossando l'uniforme della prigione e conformandosi al regolamento. Non che avessero voluto farlo. Solamente non ce l'avevano più fatta a sopportare il peso schiacciante della tortura, la noia continua, la tensione, la paura, la privazione delle necessità più elementari quali l'esercizio fisico e l'aria aperta, l'impossibilità di comunicare con altri esseri umani se non da dietro una pesante porta d'acciaio.
«La depressione, le percosse, il freddo: che altro c'è?» pensai. «Guardi fuori dalla finestra e il campo di concentramento ti grida addosso; ti guardi attorno nella tomba in cui stai sopravvivendo e ti ritrovi inghiottito all'inferno, circondato da piccoli diavoli neri dalle sembianze di 'A', B' e 'C', pronti a piombarti addosso ogni singolo istante di ogni terribile giorno da incubo...»
Rimisi il materasso nella stessa posizione di prima e mi ci sedetti sopra. La depressione cominciò a prendermi, così per rincuorarmi cercai di pensare alla mia visita ormai vicina. Poi mi ritornò in mente Pee Wee. Stavo già fantasticando di ammazzare «B» e « C» quando esclamazioni e grida annunciarono il pranzo, così a lungo atteso. Era arrivato il "Happy Wagon", così come veniva chiamato il carrello che portava il cibo dalle cucine ai Blocchi H. «Grazie a Dio,» pensai, dimenticando la depressione che si stava insinuando in me.
Man mano che le tombe attorno alla mia cominciarono a dare segni di vita un brusio si diffuse nel braccio. Alcuni ragazzi andarono alle finestre e si misero a parlare tra loro. L'arrivo del pranzo per noi non significava solo cibo, ma anche il fatto che, di lì a poco, i secondini sarebbero andati a mangiare e avrebbero fatto ritorno non prima di due ore. Voleva dire una relativa tranquillità durante quell'arco di tempo e, infine, che ci rimaneva solo mezza giornata contro cui lottare.
Fuori cadeva una pioggia sottile. Mi augurai che non cominciasse a piovere più forte. Se la neve si fosse sciolta sarebbero usciti con gli idranti per lavare l'esterno delle celle e i cortili, così noi saremmo stati investiti dai potenti getti. Con il freddo che faceva saremmo gelati a morte se i materassi e le coperte si fossero inzuppati. Era inutile cercare di rifugiarsi in un angolo per sfuggire al getto dell'acqua: con le finestre senza vetri non c'era nulla che potesse ripararci.
Sentii una serratura scattare e una porta che si apriva.
«Il pranzo!» gridò uno dei ragazzi in gaelico.
Di colpo mi scordai degli idranti e corsi a guardare fuori, attraverso la fessura. Il carrello si stava muovendo lentamente verso il fondo del corridoio. Avrei ricevuto il pranzo per ultimo. I piatti di plastica erano allineati gli uni sugli altri e gli inservienti li stavano distribuendo di cella in cella. Vidi «B» prendere dei pezzi di pesce dai nostri piatti e mangiarseli. Ero fuori di me.
«Carne di feniani (10) per pranzo!» gridava, ridendo lui stesso della sua pietosa battuta.
«Speriamo che vada loro di traverso!» disse «C» lanciando la sua solita frecciata.
La processione avanzava e «A» chiudeva la fila. Raggiunsero il fondo del corridoio e cominciarono a tornare indietro. Man mano che si avvicinavano li sentivo aprire e chiudere le porte delle celle che si trovavano sul mio lato. «B» gridò:
«Ehi, 'A', sembra che ci sia una porzione di pesce in meno!».
Provai una sensazione di rabbia e di impotenza così forte che mi sentii quasi mancare. Ero l'ultimo. Quel bastardo fetente di 'B' me l'aveva mangiata. Mi venne da urlare, ma loro non stavano aspettando altro.
«No, mi sono sbagliato! Non c'è affatto una porzione di pesce in meno!» disse «B».
Mi rincuorai.
«Ce ne sono due in meno!»
Pensai che Seán fosse sul punto di sfondare la porta. Picchiai sul muro per ricordargli che non era solo. Sentii che li malediva in tutti i modi.
Io stavo male quanto quei pesci quand'erano stati presi all'amo. Non avrei avuto l'unica parte decente del pranzo. Era una vera disgrazia e Seán lo sapeva quanto me.
Aprirono e chiusero la porta di Seán, poi fu la volta della mia. Feci finta che non fosse successo nulla. Presi dalle mani dell'inserviente il piatto mezzo vuoto, mentre «A» biascicava:
«Non c'è pesce per tutti. Chiederò in cucina di mandarlo al più presto,» che in realtà voleva dire: «Non l'avrai nemmeno per sogno!».
Intravidi «B» che si leccava le dita con fare cerimonioso, sfoggiando per l'occasione quel suo odioso sorriso. Voltai loro le spalle, senza aver pronunciato una sola parola o aver dato loro il minimo segno del mio disgusto e avvilimento. La porta sbattuta dietro di me risuonò come un colpo di cannone. Secondini e inservienti si mossero quindi in direzione del loro ufficio, ridendo rumorosamente.
Mi sedetti a esaminare il mio magro pasto, costituito da una patata fredda ancora da pelare e da una trentina di piselli duri, altrettanto freddi.
Gli inservienti dettero inizio al loro concerto quotidiano, scandendo il ritmo e fischiettando "The Sash My Father Wore". «B» se li sarebbe ingraziati con qualche sigaretta e avrebbe raccontato loro un paio di barzellette razziste, incoraggiandoli a non interrompere il loro baccano. Gli inservienti, dal canto loro, gli leccavano il culo, strisciando ai suoi piedi come solo informatori e gentaglia sanno fare. Avrebbero venduto la propria madre per una sigaretta. Ciò che facevano a noi per lo stesso prezzo e con estrema facilità avrebbe nauseato persino le loro povere madri.
Cercai di salvare qualcosa del mio pasto freddo, sforzandomi di mangiare quello che potevo, poi gettai gli avanzi nell'angolo, dove c'era il resto della spazzatura.
"The Sash My Father Wore" cessò e di lì a poco ricominciarono ad aprire le porte, al grido di «Raccolta dei piatti!» che echeggiò per tutto il braccio. Ripresi a camminare, senza preoccuparmi di guardare fuori nel corridoio attraverso la mia fessura.
Continuarono il loro lavoro, raccogliendo i piatti e muovendosi da una cella all'altra. Sentii Seán dire al suo vicino di far sapere all'O/C che lui stava per chiedere della carta igienica. Il pensiero della visita che avrei avuto nel pomeriggio calmò la mia rabbia. L'eccitazione che mi prendeva al solo pensiero stava avendo la meglio sul mio ventre costipato da cinque giorni, che cominciava a farsi sentire.
Gli inservienti avevano raggiunto la porta di Seán.
«Posso avere della carta igienica, signore?»
«Puliscitelo con la mano,» abbaiò «C» e sbatté ; la porta.
A quella rispostaccia secondini e inservienti scoppiarono in una risata isterica. Stavano ancora ridendo quando entrarono nella mia cella e portarono via il piatto. Nessun accenno al pesce che non avevo avuto, solo «B» che diceva con la sua voce stridula: «Buona questa, 'C'!» mentre tutti continuavano a ridere in modo convulso. «Proprio buona! Ah! Ah! Ah! Ah!»
Se ne andarono sbattendo la porta. «C» provava un gran piacere a umiliarci. «B» aveva una scusante: era un idiota. Anche «A» si divertiva parecchio in tutto questo, mentre i quattro inservienti facevano a gara per ingraziarsi i loro sporchi favori.
Picchiai sul muro.
«Seán,» chiamai. «Adesso preparo una cordicella con i fili dell'asciugamano e fra un po' ti passo dei fazzoletti, "mo chara" ; (11),» e aggiunsi: «Aspetta fino a quando i secondini andranno a mangiare».
«"Maith thú" (12), Bobby.»
Mi sedetti e mi misi all'opera. Strappai lunghi fili dall'asciugamano e li intrecciai insieme. «C» sarebbe proprio contento se mi vedesse ora...,» pensai, continuando il mio lavoro.
«'B', sei di guardia stasera?» urlò un secondino dal fondo del corridoio.
«Sì,» gli gridò «B» dal suo ufficio.
«Oh, oh... Bene o male?» mi chiesi. «Sta per andarsene a casa, ma tornerà stasera alle otto e mezza per il turno di notte. Sarà di sicuro ubriaco,» e sapevo bene cosa questo volesse dire.
«Hai sentito, Bobby?» mi gridò Seán.
«Sì, amico,» gli risposi. Seán era giunto alle mie stesse conclusioni.
«Ci saranno guai stanotte!»
Mi alzai, presi dalla spazzatura una piccola patata mezza marcia e la legai all'estremità della sottile cordicella che avevo preparato, per appesantirla. Sentii sbattere la porta dell'ufficio e il tintinnio di quelle odiose chiavi. «Se ne stanno andando, finalmente...»
Mi avvicinai alla finestra e legai alcuni fazzoletti all'estremità della cordicella. Picchiai sul muro.
«Ci sei, Seán?»
«Eccomi, Bobby.»
«Metti fuori il braccio. Ti passo i fazzoletti,» gli dissi. Allungai il braccio fuori dalla finestra e cominciai a far oscillare il filo in quei metri di spazio che ci separavano. La cordicella toccò alcune volte la mano di Seán prima che lui riuscisse ad afferrarla.
«L'ho presa, Bobby,» disse alla fine.
«"Maith thú", Seán. Non mollarla, adesso.»
Seán tirò a sé la cordicella e recuperò i fazzoletti di cui aveva estremo bisogno, poi picchiò sul muro per farmi sapere che l'operazione era riuscita. Gli risposi nello stesso modo e ritornai ai miei pensieri.
Che altro potevo avere in mente se non la visita e il fatto che avrei rivisto i miei familiari? Avrei potuto anche fumare, cosa che desideravo moltissimo. Era tanto che non lo facevo e, con un po' di fortuna, quella sera avrei avuto delle sigarette per me e per i ragazzi. Riuscirci avrebbe risollevato il nostro morale.
Le mie budella cominciarono ad agitarsi di nuovo. «Ci siamo,» pensai, e in un certo senso ne fui contento, dopo cinque giorni di dolorosa costipazione.
«Devo andare al gabinetto...» Suonava alquanto ridicolo, mentre prendevo alcuni fazzoletti e mi mettevo nell'angolo che non poteva essere visto dallo spioncino della porta. Nonostante il sollievo di liberarmi dalla costipazione mi sentivo un animale, accovacciato com'ero in quell'angolo della cella, in mezzo alla spazzatura e allo sporco. Ma non potevo fare altro, né potevo evitarlo, per quanto umiliante e degradante fosse. Ed era ancor peggio per quei ragazzi che condividevano la medesima cella. Io almeno avevo un po' di privacy...
Chi, fra quelle che venivano definite persone «piene di umanità » e che avevano mantenuto il silenzio sui Blocchi H, chi tra di loro sarebbe stato in grado di dare un nome a questo tipo di umiliazioni, che avevano costretto centinaia di uomini, a causa delle terribili torture loro inflitte, a dare inizio alla "dirty protest" per denunciare gli atti disumani che in continuazione piovevano su di loro? «Quanto dovremo ancora patire?» mi chiesi. Un corpo non lavato, nudo e distrutto da dolori muscolari, accovacciato in un angolo di un antro malsano, costretto a defecare sul pavimento, dove gli escrementi non sarebbero stati rimossi e il cui odore si sarebbe mescolato al già insopportabile puzzo di urina e di cibo in decomposizione... «Che trovino un nome a questo tipo di tortura,» pensai, alzandomi e muovendomi in direzione della finestra, alla ricerca di un po' d'aria fresca. «Le percosse, l'acqua gelida degli idranti, la fame, le privazioni... Che provino a dare un nome a questo terribile incubo...»
La pioggia sottile era cessata e la neve non si era sciolta. Il freddo non era più così intenso, ma mi sentivo ancora tutto intirizzito. Alcuni passeri zampettavano faticosamente sulla neve in cerca di cibo, facendomi tornare alla mente il pesce che non mi avevano e che non mi avrebbero più ; dato per quel giorno. Raccolsi alcune briciole di pane dal pavimento e le gettai fuori dalla finestra a quei piccoli abitanti del cortile.
Stetti a guardarli mentre beccavano le briciole come disperati. Quante ore avevo passato alla finestra a guardare gli uccelli! I passeri e gli storni, i corvi e i gabbiani erano i miei amici fedeli. Insieme alle piccole cutrettole mi facevano compagnia, svolazzando per il cortile fino a che le ultime luci del giorno non se ne andavano. Nelle giornate lunghe e noiose rappresentavano il mio unico svago. Erano tornati ogni giorno da quando avevo cominciato a gettare loro le briciole di pane.
«A loro piacciono i vermi,» pensai.
Mi vennero così in mente i soffocanti mesi estivi, quando le celle si trasformavano in forni e il puzzo della spazzatura e del cibo ormai rancido diventava insopportabile. Era allora che migliaia di vermi bianchi uscivano fuori dai mucchi di rifiuti, strisciando e contorcendosi tutti. «Non potrò mai dimenticarlo,» dissi a me stesso, pensando a quella mattina in cui mi ero svegliato trovando le coperte e il materasso trasformati in una massa di vermi bianchi. Mi stavano strisciando sui capelli, sulla barba, su tutto il corpo. Erano ripugnanti e, a prima vista, facevano paura. Tuttavia, come per ogni cosa, dovetti abituarmi all'idea di dover condividere la cella con loro. Di notte sentivo che si muovevano sul pavimento tra i pezzetti di carta, e quando si dirigevano verso il mio materasso per infilarvisi dentro facevano una specie di fruscio. Con il calore si tempravano all'interno dei loro bozzoli a forma di uovo, dai quali sarebbero usciti sotto forma di mosche. I loro piccoli involucri producevano un rumore secco tutte le volte che nell'oscurità vi camminavo sopra a piedi nudi e li schiacciavo. Inutile dire che il risultato finale era un vero e proprio flagello: centinaia di mosche grasse, gonfie e fastidiosissime che si attaccavano al soffitto e ai muri. Tormentavano senza sosta il mio corpo nudo, volteggiandomi attorno al viso di notte mentre tentavo di dormire, o svegliandomi al mattino quando, non appena mi muovevo, quella massa nera si sollevava in preda al panico. Mi erano divenuti così familiari che li raccoglievo a mani nude dal pavimento e dai cumuli di spazzatura che c'erano negli angoli. Potevano essere migliaia: si contorcevano tutti, muovendosi qua e là. Una volta raccolti nel palmo della mano li gettavo fuori dalla finestra, sulla superficie asfaltata del cortile. Quelle piccole forme bianche in continuo movimento risaltavano bene sullo sfondo nero. Le cutrettole arrivavano allora svolazzando in preda alla frenesia e, saltellando veloci da un verme all'altro, banchettavano con quella che per loro doveva essere una squisitezza. Dopo due o tre minuti non c'era più un solo verme sulla superficie del cortile.
Penso che lo facessi per far passare il tempo. Chi potrebbe credervi se diceste che avete passato l'estate a raccogliere vermi per nutrire gli uccelli?
Presi alcune briciole dall'angolo e le gettai fuori dalla finestra, ricordandomi ancora una volta dei miei amici. L'inverno era una brutta stagione per gli uccelli, con la neve che ammantava il suolo e nascondeva la terra.
Ripresi a camminare. Un ragazzo gridò: «"Rang anois!" (13)», invitando tutti ad avvicinarsi alle porte per la lezione di gaelico. Poi l'insegnante, che si trovava in una cella in fondo al braccio, da dietro la sua pesante porta d'acciaio cominciò a gridare la lezione del giorno con quanta voce aveva in gola. Faceva domande, scandiva lentamente parole e frasi, mentre gli studenti volonterosi le incidevano sui muri sporchi e sfregiati. Era un modo d'insegnare semplice e alla buona, ma funzionava. Ognuno di noi si sforzava poi di adoperare le nuove forme che aveva imparato, fino a che parole e frasi divenivano così consuete da essere usate automaticamente.
La lezione di gaelico continuò in sottofondo e io tornai ai miei pensieri. Pensai ai miei familiari che a casa si stavano preparando per venire a farmi visita quel pomeriggio, se non erano già per strada. Probabilmente erano eccitati quanto me, e certo desideravano che il tempo che ci separava passasse veloce.
Sarebbe stata una giornata dura per loro. Avrebbero dovuto aspettare, fare la fila, stare ammassati come delle bestie tra un cancello e l'altro, tra una perquisizione degradante e l'altra. Prima di arrivare allo stanzone delle visite avrebbero dovuto subire gli insulti e le occhiate fredde e piene di disprezzo delle guardie, per poi dover sopportare tutto questo di nuovo prima di lasciare il carcere.
Un secondino dal fondo del corridoio si mise a gridare e a deriderci, con l'intenzione di disturbare la lezione di gaelico. I ragazzi tuttavia continuarono senza badarci. Succedeva ogni volta. Dopo un po', non riuscendo nel loro intento, quelli si stancavano e se ne andavano.
Mi sedetti di nuovo sul materasso. Avevo ancora male dappertutto e i lividi diventavano sempre più scuri man mano che le ore passavano. Ero annoiato a morte ed esausto. Mi stancavo molto facilmente, perché da troppo tempo non facevo esercizio fisico e non stavo all'aria aperta. L'idea della visita non lasciava altro spazio ai miei pensieri. «Però c'è sempre qualcuno che sta peggio di te,» ricordai a me stesso, pensando ai miei compagni caduti e alle loro famiglie. «Almeno io posso vederti una volta al mese,» diceva mia madre. «Meglio dove sei ora che non nel cimitero di Milltown» (14).
Ma c'erano momenti in cui avrei preferito essere a Milltown, quando tutto si faceva così insopportabile che non t'importava nulla di essere vivo o morto, pur di scappar via da quell'incubo infernale. «Non stiamo morendo lo stesso?» pensai. «I nostri corpi non stanno forse consumandosi a poco a poco? Ora sono un cadavere vivente. Cosa sarò fra sei mesi? Sarò vivo tra un anno?» Un tempo continuavo a pensare a tutto questo, arrovellandomi il cervello, ma adesso non più. Perché c'era solamente un'unica cosa che a loro mancava di farmi: uccidermi. L'avevo già capito da tempo e Dio sa che se fino a quel momento non c'erano riusciti con qualcuno di noi non era certo perché non ci avessero provato! Ero deciso a non mollare. Potevano fare di me quel che volevano, ma io non mi sarei mai piegato, né avrei mai permesso loro di criminalizzarmi. Mi sorprendeva pensare di essere pronto a morire, piuttosto che soccombere alle loro torture terribili. Sapevo di non essere solo e che molti miei compagni la pensavano come me.
E di nuovo ritornai con la mente ai miei compagni morti, quelli che mi erano stati accanto fino al giorno prima e che il giorno dopo non c'erano più. Ragazzi e ragazze proprio come me, nati e cresciuti nei ghetti nazionalisti di Belfast, per poi finire ammazzati da soldati stranieri e da razzisti assassini. Quanti erano stati uccisi per mano loro nelle Sei Contee? Troppi. Un solo ragazzo o ragazza erano già troppi. Quanti irlandesi ancora avrebbero dovuto morire? Quanta gente ancora avrebbe dovuto perdere la vita, prima che gli inglesi decidessero di averne ammazzati a sufficienza e fossero costretti ad andarsene dall'Irlanda per sempre? Dentro e fuori dalla prigione era la stessa cosa: lo stesso schiacciante senso di oppressione che incombeva su di te e ti circondava da ogni parte. All'angolo di ogni strada c'era un soldato inglese armato. Ogni strada aveva avuto la sua parte di sofferenza e di dolore per colpa loro.
Ero orgoglioso di riuscire a resistere, di non cedere. Non potendo sconfiggerci fuori ci stavano torturando senza pietà in questi gironi d'inferno, ma non erano ancora riusciti a piegarci. Avevo paura, ma sapevo che non mi sarei mai arreso. Avrei affrontato la potenza imperialistica del loro intero arsenale militare piuttosto che soccombere.
Tirai le coperte verso di me e me le avvolsi addosso, sperando di riuscire a dormire un po'. I secondini sarebbero tornati solo dopo le due. «B» sarebbe arrivato alle otto e mezzo di sera. Mi chiedevo chi l'avrebbe sostituito nel frattempo. «Lo saprò fin troppo presto,» pensai, chiudendo gli occhi e la mente per separarmi da ciò che mi circondava.
*
«Svuotamento dei buglioli! Svuotamento dei buglioli!»
Mi svegliai di soprassalto.
«Svuotamento dei buglioli!»
Sentii il rumore del secchio di metallo che veniva trascinato lungo il corridoio. Un brivido improvviso mi attraversò tutto, lasciandomi un senso di vuoto nello stomaco. Mi alzai di scatto e di malavoglia, con la paura che mi venisse un crampo. Non mi accadde nulla, ma per diversi secondi i miei occhi dovettero lottare per rischiarare il buio della mia testa che, in preda allo stordimento, minacciava un black out.
Mi ripresi e corsi a guardare dalla fessura. La porta accanto alla cella di Pee Wee fu aperta. «A», «C», il sostituto di «B» e «D» stavano sulla soglia in semicerchio, con a fianco quattro viscidi inservienti. Uno di essi impugnava uno spazzolone, di quelli usati per spingere l'acqua nelle griglie di scolo. John O'Brien si presentò davanti a loro con addosso la coperta che gli penzolava da ogni parte, svuotò nel corridoio il suo bugliolo pieno di urina e si ritrasse. L'inserviente che aveva lo spazzolone, senza attendere alcun segnale, fece un passo in avanti e spinse la pozzanghera di urina dentro la cella, tutt'intorno al materasso di O'Brien.
Molti ragazzi svuotavano il contenuto dei propri buglioli sotto le porte, servendosi poi dei loro recipienti vuoti per farlo passare pian piano nel corridoio. La fessura sotto la mia porta era troppo piccola. C'era spazio sufficiente in cima e a lato di essa, ma sarebbe stato troppo complicato servirsene per questo tipo di operazione. Così non mi rimaneva che fare nell'altro modo, cioè rovesciare tutto nel corridoio, come aveva fatto O'Brien quando la sua porta era stata aperta. Bisognava farlo, anche se poi, quando spingevano l'urina dentro la cella, questa ti finiva sopra i piedi, le coperte e il materasso.
Ci sono diversi modi per scuoiare un animale e, nel nostro caso, per tentare di spezzare la resistenza di un prigioniero di guerra. Tra questi ce n'era uno vecchio e ben collaudato. Consisteva nel farci cambiare continuamente di cella, spostandoci da un lato all'altro del braccio. Non importava quale porta avrebbero aperto: era solo un modo per perseguitarci, l'inizio di un'altra tortura.
Afferrai il bugliolo e mi tenni pronto. «Almeno avessi un compagno di cella,» pensai, desiderando un po' di conforto morale. Ma anche Seá n era solo e così pure il povero Pee Wee lo era stato quella mattina. Volevano portar via qualcun altro. Sentivo che quella era l'unica ragione per cui ci facevano svuotare i buglioli. Lo sapevamo tutti fin troppo bene.
La serratura della mia porta scattò, mettendomi all'erta. Stetti pronto con il bugliolo in mano, sperando per il meglio.
Aprirono la porta. Non li guardai neppure. Abbassai il bugliolo e ne rovesciai il contenuto nel corridoio, sperando che gli schizzi non sporcassero i loro maledetti stivali lucidi. Feci un passo indietro, alzai la testa e aspettai il colpo che non arrivò. Li guardai in faccia. «C» e «D» ; erano ubriachi fradici. «A», come sempre, sogghignava. L'inserviente con lo spazzolone si fece avanti e cominciò a spingere dentro la cella quel liquame nauseabondo, ritirandosi solo quando i lati e il fondo del mio materasso ne furono tutti impregnati.
Se ne andarono sbattendo la porta. Sollevai e strizzai il materasso per liberare la gommapiuma puzzolente dall'urina, poi mi misi a raschiare il pavimento, per spingere verso la fessura ai piedi della porta la pozzanghera che si era venuta formando. Era un lavoro lungo, perché lo spazio era minimo e l'urina passava al di fuori lentamente.
Lo svuotamento dei buglioli intanto continuava. Il secchio procedeva rumorosamente, preannunciando pericolo. Di tanto in tanto uno splash rivelava che un altro bugliolo era stato svuotato nel corridoio. La tensione era divenuta insopportabile.
Poi accadde. Improvvisamente ci fu un'esplosione di rumori, urla e grida piene di veleno. Il secchio finì per terra con un suono metallico e una gragnuola di colpi scosse il braccio. Un rumore che sembrò quello di una testa sbattuta contro le tubature risuonò per le celle. Lasciai cadere a terra il bugliolo e appoggiai l'occhio alla fessura, mentre una voce gridava: «Dagliene ancora!».
I tonfi continuarono, fino a che «A» non urlò: «Basta così!». Altri secondini arrivarono di corsa nel braccio dalla direzione opposta, sguazzando con i loro stivali in mezzo alle pozzanghere puzzolenti di urina.
«Un furgoncino per le celle di punizione!» gridò «D» con la sua voce odiosa.
Sentii altri tonfi, poi passi e risa sadiche, seguiti da un graduale crescendo di piedi che si muovevano sempre più in fretta, altri colpi e qualcosa che sembrava un getto d'acqua. Quattro uniformi nere sfrecciarono davanti al mio campo visivo, trascinando per i piedi un corpo nudo, con la schiena che grattava il pavimento e la testa che sbatteva per terra. Passarono così veloci che non riuscii a riconoscere chi stavano portando via. Chiunque fosse, aveva del sangue sul viso.
Per alcuni secondi non successe nulla. Cadde un silenzio sinistro, pieno di incertezza. Le pozzanghere si erano appena ricomposte quando gli stessi rumori ricominciarono. E allora, di nuovo, un accelerare di piedi, i tonfi, i colpi violenti, il getto d'acqua e una massa di figure nere che passarono quasi volando davanti a me, trascinando per i piedi un altro corpo coperto di sangue.
Il rumore dell'acqua cessò a poco a poco e lo strisciare di quel corpo nudo a contatto con la superficie asciutta del pavimento in fondo al braccio si fece sempre più lontano.
Ci fu di nuovo un silenzio terribile. La tensione che c'era nell'aria incombeva su di noi come una ghigliottina: nessuno osava respirare, per paura che ci cadesse addosso. Quel silenzio straziante sembrò non aver mai fine.
Improvvisamente, come un tuono, si alzò un grido che scosse tutto il braccio: «"Tiocfaidh ár lá!"». Rimbalzò ; di muro in muro con echi terribili, fracassando il silenzio come un mattone scagliato contro il vetro di una finestra e risollevando i nostri cuori. Amarezza e odio traboccarono da ogni sua sillaba. «Il nostro giorno verrà!» ecco cosa voleva dire quel grido. «Il nostro giorno verrà!» mi ripetei. «Che Dio vi aiuti tutti quanti, 'A', 'C, 'D' e anche tu, 'B', fino all'ultimo di voi, perché non siete altro che degli sporchi torturatori.»
«"Tiocfaidh ár lá!"» gridai io stesso, con quanta voce avevo in gola.
Un ragazzo cominciò a cantare. "A Nation Once Again" si alzò allora da ogni cella man mano che ognuno di noi si univa a quel canto, per porre fine a quel silenzio crudele e risollevare il nostro morale così provato.
Il fetore dell'urina che penetrava attraverso la porta mi fece lacrimare gli occhi e mi arrivò in gola. Gli inservienti cercarono di intonare " The Sash", ma furono completamente sommersi dal frastuono dei buglioli che, in segno di rabbia e di sfida, venivano battuti ripetutamente contro le porte scrostate.
«"Tiocfaidh ár lá!"» dissi. «E che arrivi il prima possibile!» Ritornai al mio lavoro e ricominciai a spingere sotto la porta l'urina che ancora rimaneva ai miei piedi.
Il baccano cominciò a diminuire quando le ultime gocce sparirono al di là della porta. Gettai il bugliolo nell'angolo sopra la spazzatura e mi sedetti sul materasso, cercando di tenere i piedi lontani dalla parte bagnata. La mia mente era in subbuglio e io, esausto e provato, desideravo quel sollievo e conforto che non mi venivano mai concessi.
Il rumore cessò completamente. Seán picchiò sul muro, preoccupato come sempre.
«Tutto bene, Bobby?»
«Sì, Seán. E tu?»
«Non sono venuti nella mia cella.»
«Chi è stato portato via?» gli domandai.
«Non lo so,» rispose. Aveva però già chiesto agli altri di farglielo sapere.
«Comunque,» continuò, «penso che siano stati 'C' e 'D' a riempirli di botte.»
«Probabilmente,» convenni con lui.
«Ehi, Seán,» gridò un ragazzo qualche cella più in là. «E' toccato a Liam Clarke e Seán Hughes. Sono stati 'C' e 'D'. L'inserviente con lo spazzolone li ha picchiati violentemente con il manico. Senza alcun motivo, Seán, come sempre. Sono piombati loro addosso quando si sono voltati per rientrare in cella.»
Lasciai Seán e i ragazzi a discutere alle finestre di quanto era successo e ripresi a camminare, sapendo che avrebbero potuto chiamarmi per la visita da un momento all'altro. Quello che era accaduto ai due ragazzi, e ancor prima a Pee Wee, aveva spento il mio entusiasmo. Non potevo fare a meno di pensare che in quel momento si trovavano in cella di punizione. Con tutta probabilità erano stati brutalmente picchiati di nuovo dai sadici secondini che facevano funzionare in modo perfetto quel centro di tortura, all'interno di quello più ampio che era la prigione.
Sapevo fin troppo bene cosa succedeva là dentro. Tutti lo temevano. Il Punishment Block (Blocco delle punizioni, [N.d.T.]) (15) significava tortura, brutalità, disumanità. Persino le guardie lo sapevano, ma non l'avrebbero mai ammesso.
Alcuni mesi prima ero stato tenuto là tre giorni, fra i più lunghi e insopportabili della mia vita. I secondini mi trascinarono via nudo dalla cella e mi ci trasportarono su un furgone blindato. Giunti a destinazione, non appena sceso mi afferrarono da ogni parte, picchiandomi e prendendomi a calci fino a farmi finire per terra. Non dissero una sola parola, neppure per minacciarmi. Ero un "blanket man", un repubblicano, e questo bastava. Feci appena in tempo a rendermi conto di quel che stava accadendo che mi presero per i capelli e mi trascinarono per terra lungo il cortile, fino all'entrata del Blocco. Uno di loro suonò il campanello, per far venire qualcuno ad aprire il portone. Giacevo ai loro piedi, stordito e ansimante. Avevo il cuore che batteva forte e il corpo in fiamme, lacerato com'era dal contatto con il cemento ruvido che aveva ricoperto di tagli la mia pelle. Il mio viso era infuocato e sporco di sangue, a causa di una ferita che avevo in testa.
Rimasi immobile, facendo finta di essere svenuto. Speravo che si accontentassero di avermi fatto perdere i sensi. Avevo una guancia appoggiata alla superficie dura e gelida del cortile, ma il resto del mio corpo sembrava essere insensibile al gran freddo che faceva. Mormorai in fretta un'"Ave Maria" e un Atto di Dolore, non appena udii un tintinnio di chiavi farsi sempre più distinto.
Diverse mani, coperte di guanti, mi afferrarono per le braccia e per le gambe, sollevandomi da terra e facendomi oscillare all'indietro. Il peso del mio corpo mi riportò in avanti, così andai a sbattere contro la lamiera di ferro del portone. Mi sembrò che il cielo mi cadesse addosso quando lasciarono la presa e mi mollarono per terra. A quel punto mille stelle bianche mi esplosero davanti agli occhi come fuochi d'artificio, inghiottite subito da una nube color nero inchiostro.
Quando ripresi conoscenza giacevo sul pavimento di una cella di punizione. Aprì gli occhi: tutto mi girava intorno. La forte luce del soffitto che roteava sopra di me mi accecò. Avevo fortissimi dolori alla testa ed ero paralizzato dal male che provavo in tutto il corpo. Rimasi immobile, senza avere il coraggio di muovermi, con il sapore del sangue sulle labbra gonfie. Mi sforzavo di capire dove mi trovassi e cosa fosse successo. Il pavimento di cemento era gelido. Sapevo di dovermi togliere di lì, se non volevo pagarne con il tempo le conseguenze, prendendomi una polmonite.
Mi alzai pian piano sulle ginocchia, ma sbattei contro il muro e caddi per terra. Dopo un'eternità cercai di sollevarmi ancora, sebbene gli spasmi di dolore mi rendessero pressoché impossibile ogni movimento. Con gran fatica mi misi di nuovo in ginocchio. La mia pelle bruciava, perché la carne viva dei tagli e delle escoriazioni era a diretto contatto con il pavimento gelido. Alla fine riuscii a alzarmi in piedi. Fui sul punto di cadere nuovamente, ma appoggiandomi al muro pian piano arrivai al blocco di cemento che fungeva da sgabello e mi ci lasciai cadere sopra. Mi sembrò di morire. Ero così sconvolto dal male e dallo shock da non saper cosa fare. Non riuscivo letteralmente a pensare: il minimo movimento mi faceva tremare tutto e mi mozzava il fiato. Stavo quasi per gridare dal dolore quando la porta si aprì e apparve la figura biancovestita di un inserviente, che entrò dentro.
Radioso nel suo camice bianco quello cominciò a esaminarmi, gingillandosi con il mio corpo e tastandomi qua e là. Imitando i gesti di un dottore cercava di impressionare il gruppo di secondini che stava all'entrata della cella. Terminata la sua ispezione, o quello che fu, mi informò con fare arrogante che, se avessi voluto farmi visitare dal medico ed essere curato, avrei dovuto prima fare un bagno. Lo guardai incredulo. Lui ripeté quello che aveva detto con voce ancor più minacciosa. Sapeva bene cosa stava facendo: stavo male, avevo bisogno di cure immediate e lui mi metteva sotto pressione ricattandomi. Niente bagno, niente cure. I dolori che provavo erano così forti che solo a fatica avrei potuto muovermi, perciò sarei stato assolutamente incapace di lavarmi. Inoltre non avevo alcuna intenzione di interrompere la mia protesta. Ferito o moribondo che fossi, non intendevo fare alcuna concessione, né a lui, né a nessun altro.
Sapevo cosa sarebbe accaduto. Il suo ultimatum si trasformò in comando.
«Vai a farti ammazzare!» gli dissi rabbiosamente.
A quel punto il gruppo di secondini che premeva attorno a lui, senza neppure chiedermi: «Dove ti fa male?» e senza complimenti, mi sollevò come si solleverebbe un mucchio di stracci e mi portò nel bagno, gettandomi come un pezzo di sapone nella vasca già colma d'acqua.
Lo shock che provai mentre l'acqua gelida inghiottiva il mio corpo martoriato mi tolse il respiro. Mi sentii bruciare dappertutto, a causa del disinfettante diluito nell'acqua che aveva aggredito le mie carni vive. Feci subito il tentativo di uscire dall'acqua, ma i secondini mi ricacciarono dentro. Uno di loro cominciò a sfregarmi la schiena con una spazzola dura. Mi contorcevo per il dolore. Cercavo di liberarmi, ma più mi agitavo più loro stringevano la presa. Gli occhi mi si riempirono di lacrime. Mi sarei messo a urlare, se avessi avuto il fiato per farlo. Continuarono a grattare ogni parte del mio corpo martoriato e a versarmi addosso secchi di acqua gelida e liquido schiumoso. Ricordo vagamente che, mentre mi stavano tirando fuori, un sadico secondino mi afferrò per i testicoli, cominciando a sfregare le mie parti intime. Fu l'ultima cosa che rammento. Poi svenni.
Fui trasportato all'ospedale della prigione, avvolto in una grande coperta color cammello. Venni visitato e tenuto là per due ore. Più tardi, fasciato come una mummia, con un occhio nero e sette punti in testa, fui ricondotto in cella di punizione.
Mi ritrovai là, con addosso solamente una coperta che puzzava di urina e di fumo. Avevo recuperato la calma, sebbene fossi ancora un po' disorientato. Cercai di ricordare le cose terribili che avevo subìto, ma dopo poco fui sopraffatto dal pensiero di quello che doveva ancora venire. Nessuno poteva fare nulla per me. Non potevo comunicare con nessuno, perché ero totalmente isolato. Ero solo, indifeso e completamente alla loro mercé, ben sapendo che quelli non conoscevano il significato della parola pietà . Forse la cosa peggiore era avere un freddo terribile e non riuscire a camminare, ne a muovermi per riscaldarmi. Provavo una gran pena per me stesso.
Più tardi i secondini mi trascinarono di nuovo fuori dalla cella. Mi portarono nudo davanti al direttore del carcere, per quella che era la consueta procedura da farsa. Umiliato e imbarazzato rimasi nudo davanti a loro, con la testa che mi scoppiava dal dolore per le percosse subite. Fui accusato di « ;aver disobbedito a un ordine,» che in realtà significava essermi rifiutato di collaborare con il secondino che voleva ispezionarmi l'ano. In altre parole non glielo avevo permesso, ma ciò di cui mi accusarono fu il fatto che erano occorse tre o quattro guardie per tenermi fermo mentre l'ispezione avveniva. Il secondino al quale avevo fatto resistenza era quello con il camice bianco. La mia sorte tuttavia non sarebbe stata diversa se egli fosse stato un vero dottore, perché il loro unico scopo era quello di degradarmi e umiliarmi. Quella non era altro che una delle tante torture che ci venivano inflitte nel tentativo di spezzare la nostra resistenza. Fui riconosciuto colpevole - non che mi aspettassi qualcosa di diverso - e condannato a tre giorni di cella di punizione, durante i quali sarei stato nutrito secondo quella che veniva chiamata eufemisticamente «Dieta n. 1,» cioè una dieta da fame. Persi inoltre un mese di condono, che equivaleva a due mesi di prigione. Infine, per dare credibilità al tutto, fui dichiarato colpevole di aver assalito i quattro secondini che per poco quella mattina non mi avevano ammazzato e di essermi causato volontariamente delle ferite. Mi fu inoltre fatto capire che, se avessi osato presentare formale denuncia, sarei stato accusato di falsa testimonianza ai danni del personale del carcere.
«Come ci si può difendere?» ricordo di aver pensato allora.
Un senso di vomito mi aveva preso mentre venivo trascinato di nuovo in cella di punizione, in attesa di comparire davanti al Board of Visitors (Bov). Vi sarei rimasto tre giorni, per poi ritornarvi alla fine del mese per altri quindici, sempre sotto il controllo del Bov.
La cella era freddissima, spoglia e solitaria. C'ero già stato una volta e sapevo quanto isolata e insopportabile fosse. Una tavola di legno fungeva da letto. Una lastra, pure di cemento, serviva da tavolo e un altro blocco di cemento da sgabello. Una Bibbia, un bugliolo e un contenitore per l'acqua erano gli unici altri arredi.
Rimasi là per tre giorni. Mi picchiarono altre due volte, ma non così duramente come la prima. Quando fu l'ora di svuotare il bugliolo tentarono di ricattarmi: «Se vuoi farlo devi indossare l'uniforme,» mi dissero. Così il contenuto del bugliolo traboccò sul pavimento e là rimase. Vi camminavo sopra incurante, muovendomi con gran fatica, perché dovevo scaldarmi e il mio corpo era sempre tutto intirizzito.
Durante i primi due giorni non riuscii quasi a camminare. Diventavo sempre più debole man mano che la «Dieta n. 1» faceva il suo effetto. La mia porzione giornaliera consisteva in due fette di pane raffermo e una tazza di tè freddo per colazione; per pranzo ricevevo una piccola scodella di brodaglia e per cena pane e tè, come a colazione. Il terzo giorno svenni un'altra volta. Riacquistai i sensi solo qualche tempo dopo, senza che nessuno fosse venuto ad assistermi.
Quando ritornai nei Blocchi H persino i secondini mi guardarono come se fossi un fantasma. Ero fisicamente distrutto e mentalmente esausto. Il ricordo del digiuno, delle percosse, del bagno forzato, della noia e del freddo non se ne andava dalla mia mente, riempiendomi di odio profondo, amarezza e pensieri di vendetta.
Due settimane dopo venni rinchiuso là per altri quindici giorni. Fu lo stesso incubo moltiplicato per cinque. Vivevo come un animale impazzito e mangiavo con le mani. Ogni tre giorni venivo tenuto a digiuno. Ancora una volta fui costretto a trascinarmi in mezzo allo sporco e ai rifiuti, a continuare a muovermi per scaldarmi. Venivo picchiato, pregavo sottovoce e piangevo nel sonno, combattendo sempre contro l'impulso di cedere a loro, di arrendermi.
Ma riuscii a sopravvivere. Quei luoghi di tortura e i sadici che li popolavano avevano distrutto il mio corpo, ma non erano riusciti a uccidere il mio spirito. Mi occorsero tre settimane per riprendermi fisicamente da quell'esperienza di tortura, ma la mia mente non riuscirà mai a dimenticare.
Chissà quanti altri erano stati costretti a subire quell'incubo. Il povero Pee Wee e gli altri due ragazzi lo stavano vivendo in quel momento. «E quanti ancora? Per quanto tempo tutto questo continuerà, prima che qualcuno venga picchiato a morte? Dove vogliono arrivare?» mi domandai, sedendomi di nuovo sul materasso.
Era pomeriggio avanzato e cominciavo a preoccuparmi. E la mia visita? Stetti ad ascoltare, sperando che il telefono che si trovava all'inizio del braccio suonasse per avvertire «A»che i miei familiari erano arrivati. Per passare il tempo cominciai a strappare dei lunghi fili da una delle mie sottilissime coperte e a intrecciarli assieme, per formare una cordicella che, speravo, mi sarebbe servita più tardi.
Un fiocco di neve entrò dalla finestra senza vetri. Si preannunciava un'altra abbondante nevicata. La luce del pomeriggio cominciava a sbiadire, diventando sempre più fioca ogni minuto che passava. Portato dal leggero vento della sera mi raggiunse il gracchiare dei corvi che ritornavano dai campi vicini. Mi alzai e andai alla finestra per vederli scomparire in lontananza, mentre mille luci rischiaravano lo spazio circostante man mano che venivano accese. In breve il tetro paesaggio davanti a me fu pieno di luci, che facevano brillare il filo spinato coperto di neve.
A poco a poco il giorno, con la sua luce invernale, morì e si fece buio. «Si sta facendo tardi,» pensai, nascondendo la cordicella in un buco del materasso.
Con il passare del tempo la mia preoccupazione aumentava. Cercavo di immaginare la causa di quel ritardo. «Devono essere almeno le quattro e mezzo. Cosa può essere successo?»
Il telefono squillò. Tesi l'orecchio, sperando di sentire le parole tanto attese. «A» stava ricevendo istruzioni dal secondino che si trovava all'inizio del braccio. «Ci siamo,» pensai tutto eccitato.
Impaziente, rimasi seduto ad aspettare. I minuti passavano e ancora nulla dava conferma che la mia visita era prossima.
Cinque, dieci minuti... Poi udii un rumore di chiavi e di passi che si avvicinavano. La serratura scattò e la mia porta fu aperta.
Mi trovai di fronte «C» e «D».
«Visite, barbone,» mi disse il primo con la sua voce stridula. L'odio che provava per me traboccava da ogni sua sillaba. Se avesse potuto mi avrebbe messo contro il primo muro e fucilato all'istante. Mi alzai dal materasso, togliendomi le coperte e facendole cadere a terra, poi mi avvolsi l'asciugamano attorno alla vita. Lasciai la cella e uscii nel corridoio coperto di urina, notando subito che lì faceva più caldo. Camminai in mezzo al fiume di urina fino a raggiungere l'ultima cella, dove erano tenute le uniformi della prigione. La visita era l'unico momento in cui accettavamo di indossarle. Mi guardai attorno e presi la prima che capitava. Stavo per infilarmi la giacca quando «D» disse:
«Togliti l'asciugamano e mettiti là sopra,» indicando un grande specchio che stava sul pavimento. Mi ordinò quindi di piegarmi in avanti e di toccarmi le punte dei piedi, ma io mi rifiutai. Chiamarono « A» e quando questi arrivò tutti e tre mi si avventarono contro, costringendomi con la forza a piegarmi in avanti. «A» e «D» mi tennero stretto mentre «C» mi perquisiva l'ano.
Dopo alcuni secondi mollarono la presa. Mi raddrizzai e cominciai a vestirmi. «Bastardi,» pensai. «Non mi hanno neppure ordinato di aprire la bocca per ispezionarla. A loro non interessava perquisirmi, ma solo umiliarmi...»
Uscii dalla cella vestito e disgustato, cercando di fissarmi bene in mente il fatto di non essere stato perquisito in bocca e ricordando a me stesso che il peggio doveva ancora arrivare.
Mi chiusero a chiave tra i due cancelli d'acciaio all'inizio del braccio. Avevo un aspetto pietoso: il viso non lavato, la barba e i capelli arruffati e addosso l'uniforme della prigione, di diverse taglie più grande della mia, che pendeva da ogni parte. Non me ne importava nulla. Al diavolo il mio aspetto! Mi stavano torturando, non sottoponendomi a un trattamento di bellezza.
Arrivò un secondino ad aprire il cancello e mi consegnò a un altro, che mi stava aspettando per scortarmi fino alla visita. Costui mi condusse all'esterno e mi fece salire su un furgone blindato, che attendeva fuori dalla porta del cortile con il motore acceso. Rabbrividii mentre prendevo posto sul duro sedile a forma di panca. Avevo sperato che vi fossero anche ragazzi di altri bracci che andavano alla visita come me, ma il furgoncino era vuoto e buio. La mia scorta salì da dietro e chiuse la portiera. L'oscurità più totale ci avvolse.
«Tutto a posto!» gridò al guidatore, che immediatamente partì.
Attraversammo il cancello principale dei Blocchi H. «Il cancello dell'Ade,» pensai. La mia scorta prese a maledire la portiera che, mezza rotta, sbatacchiava e dovette regger la con la mano per impedire che si aprisse completamente. Cercò di scambiare qualche parola con me.
«Da quanto tempo stai facendo la "blanket protest"?» mi chiese, e aggiunse immediatamente: «Non pensi che sia ora di smetterla?».
«No,» fu la mia secca risposta.
«Non otterrete nulla,» disse con distaccata sicurezza.
«Non ci si ferma mai finché non si raggiunge la meta,» gli ribattei.
«Devi essere pazzo,» continuò. «Io non lo farei mai, se fossi nelle tue condizioni.»
«Certo che no. Tu sei un secondino e io un prigioniero politico.»
«Non gli è piaciuta l'ultima cosa che ho detto,» pensai, dal momento che quello se ne stava tutto silenzioso al buio. «Sono sicuro che ora è tutto rosso in faccia.»
«E poi,» ripresi, toccandolo sul vivo, «alla fine avrete tutto il diritto di sentirvi i più fregati.»
«Che vuoi dire?» borbottò.
«Be',» continuai. «Quando il governo inglese, con un semplice tratto di penna, deciderà di concederci di nuovo lo status di prigionieri politici, o meglio ancora, quando dichiarerà la propria intenzione di andarsene dall'Irlanda, cosa che farà sicuramente nel momento in cui vi sarà costretto, se ne fregherà completamente di voi. Che farete a quel punto?»
«Non accadrà mai,» rispose nervosamente.
«Certo che accadrà. In passato ha fatto anche di peggio in posti come Aden, Cipro e Palestina. Sì, lo farà sicuramente di nuovo.»
Il furgone si fermò bruscamente. Il secondino aprì la portiera, scese giù e con un cenno mi invitò a seguirlo. «Non è più così loquace come prima,» notai. L'idea spaventava anche i più duri di loro: a nessuno andava di essere piantato in asso, soprattutto dopo tutte le atrocità che avevano compiuto e che stavano ancora compiendo, delle quali un giorno avrebbero dovuto rispondere.
Passai accanto alle baracche delle perquisizioni, dove stavano facendo un energico trattamento ai ragazzi che tornavano dalle visite. La baracca dove venivano perquisiti i "blanket men", isolata dalle altre, appariva sinistra e minacciosa. I cumuli di neve ai lati della sua struttura in legno le conferivano un aspetto solitario e desolato, sebbene fosse perfettamente funzionante. Un tonfo e un grido provenienti dal suo interno ne furono la conferma.
Entrai nell'edificio dove avevano luogo le visite. La mia scorta mi lasciò sotto una forte luce e andò a informarsi in quale box mi doveva portare. Dozzine di guardie mi squadrarono dall'alto in basso mentre mi passavano accanto, facendo le solite battute di circostanza, piene di disprezzo.
La confusione che mi circondava mi sembrò irreale. Non ero abituato a un così brusco cambiamento di atmosfera. Non era quella carica di tensione che incombeva su di me ogni giorno nei Blocchi H. Anche lì era pieno di secondini spietati, ma questi erano occupati a fare cose che, grazie a Dio, almeno per una volta non riguardavano me.
La mia scorta tornò e mi condusse verso lo stanzone delle visite.
«Box numero sette,» disse.
Dio mio! Il 7 era uno degli ultimi, quello attorno al quale si concentrava la maggior parte dei secondini. La mia guardia aprì la porta dello stanzone e io vi entrai dentro.
Fu come muoversi in un palcoscenico, tra i personaggi di un'opera teatrale. La prima cosa che mi colpì fu il ronzio di quel parlare a bassa voce, poi le nuvole di fumo, i vestiti colorati dei gruppetti di persone che, appiccicate le une alle altre, si protendevano sui tavoli parlando sommessamente e, infine, la massa nera dei secondini, che camminavano avanti e indietro, si piegavano sulle loro spalle per sentire quello che veniva detto e scherzavano tra loro, riempiendo l'aria con le loro risa forti e sguaiate.
Gettai un'occhiata ai numeri dei box: 12, 11, 10, 9... Mi diressi verso il numero 7. Volti amici e solidali mi sorridevano per farmi coraggio. Donne anziane, mogli, figlie, sorelle e fratelli, bimbi e padri dei miei compagni. Ricambiavo i sorrisi come potevo, provando per loro molto di più di dolore e solidarietà.
«Dio ti benedica!» mi gridò un'anziana signora, e aggiunse: «Non mollare!».
Mi venne da piangere. «Muoviti!» ringhiò un secondino.
Ero stordito. Gettai uno sguardo dentro i box mentre vi passavo accanto. I miei compagni e le loro famiglie mi sorridevano e mi chiamavano. Giunto all'altezza del numero 7 vi entrai dentro e, soprappensiero, mi sedetti dalla parte sbagliata. I secondini che erano appostati lì attorno per poco non mi mangiarono vivo.
«Alzati immediatamente da quella sedia e siediti dall'altra parte del tavolo!» mi urlarono, sembrando quasi in competizione l'uno con l'altro per vedere chi tra loro fosse il più autoritario e brutale.
Mi spostai sull'altro lato. «Che bastardi!» mi dissi.
«Come va?» mi gridò un anziano signore con l'accento di Derry.
«Sopravvivo,» risposi, e non c'era veramente nient'altro che potessi aggiungere.
«Coraggio! Che Dio vi protegga tutti!» disse una donna di mezza età, con un accento che sembrava quello di Tyrone.
«Un lungo viaggio per una visita di solo mezz'ora,» pensai.
I secondini continuavano ad andare avanti e indietro, osservando tutto e ascoltando ogni parola che veniva detta. Altri tre più la mia scorta si piazzarono accanto al mio box e si misero a parlare tra loro.
Vidi un gruppetto di persone venire nella mia direzione. Poi apparve mia madre, seguita da mio padre e da mia sorella. Quando furono vicini mi alzai in piedi per salutarli. Mia madre gettò una rapida occhiata tutt'intorno e un secondo prima che mi abbracciasse sentii la sua mano toccare la giacca della mia uniforme cadente. La visuale dei secondini che si trovavano accanto al nostro box era stata parzialmente coperta dall'arrivo di mio padre e di mia sorella, mentre quelli che si aggiravano attorno ai box in quel momento ci stavano volgendo le spalle.
Quella di mia madre era stata una mossa veloce. Sapevo bene cos'era successo e cosa fosse quel che ora si trovava nella mia tasca sinistra.
Mia sorella mi abbracciò e mio padre mi strinse la mano.
Gettai un'occhiata ai secondini, per capire se avessero visto qualcosa. Dall'espressione dei loro volti sembrava che non si fossero accorti di nulla, ma il mio cuore si fermò quando uno di loro si mosse verso di noi. Mia madre si sedette e io mi misi accanto a lei. Mio padre e mia sorella si sistemarono sul lato opposto del nudo tavolo di legno che fungeva da elemento divisorio fra il prigioniero e i visitatori.
«Ehi, tu!» tuonò un secondino.
Le urla che mi piovvero addosso da ogni parte mi fecero quasi cadere dalla sedia.
«Si allontani subito dal prigioniero e si sieda dall'altro lato del tavolo!» urlò poi quello a mia madre.
Per alcuni interminabili secondi pensai che mi avesse scoperto: sarebbe stato proprio quello che ci voleva. Il mio cuore batteva all'impazzata e un improvviso senso di nausea mi strinse il petto come in una morsa.
«Prigioniero?» disse mia madre con tono esasperato. «E' mio figlio! Non posso sedermi vicino a mio figlio?»
«Temo proprio di no,» si sentì rispondere.
«No, non può. Regolamento della prigione,» aggiunse un altro intromettendosi. Io ero troppo impegnato a riprendermi dal terribile spavento per ribattere. Mia madre, temendo che la visita potesse finire lì, portò la sedia dall'altro lato del tavolo e si sedette vicino a mio padre e a mia sorella.
I secondini stettero a guardare inflessibili che il loro ordine venisse eseguito, poi indietreggiarono di circa un metro e si misero a parlare tra loro a bassa voce, senza staccarci gli occhi di dosso.
Mi girai verso i miei familiari e cominciai a parlare con loro, volgendo le spalle alle guardie.
«Come stai?» mi chiese mia madre.
«Abbastanza bene,» risposi, leggendo l'angoscia sul suo viso mentre esaminava il mio aspetto terribile.
«La barba ti è cresciuta un bel po' dall'ultima volta che ci siamo visti,» disse mio padre scherzando.
Mia sorella mi chiese se faceva freddo nelle celle. Mio padre estrasse un pacchetto di sigarette e me ne porse una. Con una mano presi un cerino dalla scatola di fiammiferi che a loro veniva concesso di portare con sé, mentre mia madre mi teneva l'altra nelle sue.
Sentivo dei piedi muoversi alle mie spalle. Non avevo dubbi sul fatto che i secondini stessero osservando ogni nostro movimento, soppesando ogni parola che dicevamo.
«Voi come state?» chiesi, aggiungendo che mi sembravano in gran forma.
La sigaretta mi faceva girare la testa, ma l'avevo desiderata troppo per buttarla via.
«Come stanno tutti gli altri?» domandai, e ascoltai attentamente quello che mi dicevano. Tutti e tre si interrompevano a vicenda per poter parlare. C'erano così tante cose da dire e tante domande a cui dovevo rispondere! Era un parlare concitato e sommesso. Ignoravamo i nostri ascoltatori indesiderati e quando stavamo per dire qualcosa che non volevamo loro sentissero abbassavamo la voce fino a trasformarla in un sussurro. Avrei preferito che non riuscissero a udire nulla, ma non era possibile. Mia madre e mio padre gettavano continue occhiate verso di loro, ma sapevo che questo non li avrebbe fatti indietreggiare neppure di un centimetro.
Mia sorella mi comunicava tante piccole notizie. Io mi sforzavo di tenere a mente tutto per riferirlo più tardi ai ragazzi, cercando al tempo stesso di non dimenticare quello che volevo chiedere loro.
Mia madre mi sussurrò di fare attenzione al pacchettino che avevo in tasca. Disse che conteneva un po' di tabacco ridotto in briciole, alcune cartine di sigaretta e una breve lettera di mia sorella Bernadette. La mia mente era in subbuglio mentre ascoltavo tutte quelle notizie e facevo mille domande. Il tale era morto; il tal altro stava morendo; tutti sembravano sul punto di sposarsi. I soldati inglesi avevano di nuovo devastato la nostra casa e il figlio di un nostro conoscente era stato arrestato. Era prevista una serie di scioperi lì da noi, mentre in Inghilterra erano già in corso. I giornali parlavano dei molti casi di influenza tra i prigionieri, nonché dei bagni e dei tagli di capelli forzati che venivano effettuati nei Blocchi H. Avevano fatto un albero di Natale a Falls Road, vicino a Dunville Park, con incisi i nomi di tutti i "blanket men".
Raccoglievo nella mia mente ogni notizia, pensando sempre al pacchettino di tabacco che avevo nella mia tasca sinistra.
Feci un rapido resoconto di come stavano le cose e raccomandai loro di andare all'Ufficio informazioni sui Blocchi H a Falls Road, per riferire di Pee Wee O'Donnell, Liam Clarke e Seán Hughes, nonché di quel che era accaduto quella mattina durante il cambio di braccio. La barba nascondeva i segni delle percosse che avevo ricevuto in quell'occasione, perciò mia madre e mia sorella mi esaminarono attentamente il viso e le mani, per vedere se vi fossero segni rivelatori del maltrattamento subito. Continuavano a chiedermi se ero sicuro di sentirmi bene. Accesi un'altra sigaretta, servendomi della prima che ormai stava per finire. Mi sentivo meglio e potevo fumarne un'altra.
Gli altri box si stavano svuotando rapidamente. Alle mie spalle sentivo la gente dirigersi verso la porta d'uscita, ma non mi voltai. L'avevo fatto altre volte e non volevo vedere di nuovo quei volti afflitti e pieni di dolore.
Mia sorella mi parlò del suo bambino. Mia madre mi riportò le notizie pubblicate nel «Republican News» della settimana precedente e mio padre aggiunse altri particolari. Riferii loro i messaggi che avevo per le famiglie di alcuni ragazzi, poi ascoltai con attenzione il resoconto della manifestazione. Mio padre si inserì di nuovo nel discorso per dirmi del crescente interesse che si stava manifestando in America, in Francia e in altri paesi europei nei confronti di quello che accadeva nei Blocchi H.
La nostra conversazione continuava. Accesi una terza sigaretta. «Ancora dodici minuti,» notai, tenendo d'occhio l'orologio di mio padre.
«Buona fortuna, ragazzi! Che Dio vi benedica!» gridò a tutti uno dei visitatori, mentre se ne stava andando. Sapevo che il mio corpo non lavato puzzava, ma ignorai la cosa. I miei familiari non avrebbero fatto alcun commento, come sempre. Mia sorella mi raccontò come stavano andando le cose nel nostro quartiere e chi era andato a trovarli per avere mie notizie. Poi parlò di suo marito. Mia madre aveva appena cominciato a riferirmi degli scontri che c'erano stati nella nostra zona quando improvvisamente un secondino la interruppe.
«Tempo scaduto!» abbaiò da dietro le mie spalle, e subito restituì il permesso di visita a mia madre, facendo così capire chiaramente che dovevano andarsene.
«Mancano ancora otto minuti alla mezz'ora,» gli dissi freddamente.
«Si rivolga al Direttore,» mi rispose seccato. Mia madre e mia sorella mi guardarono allarmate.
«Non importa, caro. Di sicuro si tratta solo di un paio di minuti,» disse mia madre, preoccupata delle conseguenze che avrei dovuto subire una volta portato via, qualora fosse sorta una discussione.
Mi alzai dalla sedia sapendo che, qualunque cosa avessi detto, la visita era finita. Ero disgustato e in collera, ma non volevo preoccupare i miei familiari. Avevano già troppe cose per cui stare in ansia.
Mia madre e mia sorella mi abbracciarono e mi baciarono, mentre le lacrime, apparse improvvisamente dal nulla, scendevano sulle loro guance. Ero sconvolto.
I secondini cominciarono a spingermi da dietro. «Andiamo! Basta così ;! Andiamo!»
«Ci rivediamo il mese prossimo,» dissi a mia madre e a mia sorella. Mio padre riuscì a rubare una veloce stretta di mano proprio prima che le guardie mi spedissero verso la porta d'uscita dei prigionieri. Vidi di sfuggita i gruppetti di persone tutte pigiate che ancora rimanevano a parlare a bassa voce attorno ai tavoli. In qualche box un secondino stava seduto accanto a chi era venuto a far visita. Erano le cosiddette «visite d'appello» ;. Dicevi una parola che non si riferiva al caso in appello e i secondini ti saltavano addosso come cani da guardia, ponendo fine alla visita.
Riuscii a intravedere per l'ultima volta la mia famiglia che mi salutava, prima che un secondino mi sbattesse la porta in faccia.
«Tu,» ruggì. «Aspetta lì.»
Non era lo stesso che mi aveva fatto da scorta e che sembrava essersi dileguato. A quanto pareva ero bloccato lì con quel bastardo, che andò a prendere disposizioni per la mia perquisizione dopo la visita. Rimasi là, tremando leggermente. Ero disorientato e non mi sentivo affatto bene, disabituato com'ero a essere fuori dalla mia piccola e nauseabonda cella di cemento simile a una tomba. La vista della gente che mi sorrideva, quei volti amici e solidali, le espressioni vivaci, i vestiti colorati, il conforto anche solo di vedere di nuovo la mia famiglia... Tutto questo era troppo per il mio corpo a pezzi e per la mia mente martoriata.
Attorno a me c'era un gran movimento. I secondini erano dappertutto. Dio mio, il pacchettino! Mi toccai la giacca in preda al panico. Era ancora lì... Guardai attorno e, quando fu il momento buono, misi la mano in tasca e lo tirai fuori. Un secondino mi passò a fianco, squadrandomi da cima a fondo. Mi sembrava di avere in mano una bomba e pregavo che la mia scorta non ritornasse proprio in quel momento.
Via libera! Mi decisi e in un attimo mi ficcai il pacchettino in bocca. Era piccolo e avvolto in un pezzetto di cellophane.
Guardai il riflesso della mia immagine nella finestra che mi stava di fronte: la barba nascondeva ogni rigonfiamento sospetto della guancia. Ora dovevo solo sopportarne il fastidio in bocca. Altri secondini mi passarono accanto. I loro occhi indagatori mi guardarono fisso, come fossi qualcosa fuori del comune. «In fondo lo sono,» pensai, osservando di nuovo la mia immagine riflessa nel vetro: i capelli erano arruffati e la barba lunga e irsuta come un cespuglio di rovo; il mio viso, di un bianco mortale, pieno di rughe e invecchiato prima del tempo, faceva quasi paura; le guance erano incavate e dagli affossamenti degli occhi le mie pupille, vitree e penetranti, mi stavano guardando. Infine, coperto dall'uniforme della prigione, il mio corpo nudo, fisicamente distrutto.
«Muoviti!» ringhiò la mia scorta, interrompendo i miei pensieri e l'esame che stavo facendo della mia immagine riflessa.
Mi condusse fuori, verso le baracche delle perquisizioni. Passai accanto alla prima, destinata ai prigionieri comuni, e alla seconda, riservata ai detenuti in attesa di processo. La terza, che conoscevo fin troppo bene, era separata dalle altre e appariva grigia, desolata e sinistra.
Era la «baracca speciale», nella quale venivamo fatti entrare solo noi, i "blanket men", i prigionieri di guerra repubblicani. La mia scorta, come sempre alle mie spalle, mi ordinò:
«Sbrigati! Va dentro!».
A fatica riuscivo a inghiottire la saliva, a causa del pacchettino che avevo in bocca. Avvertii dell'impazienza nella sua voce. Non ce la faceva più ad aspettare che io entrassi, tanto che mi spinse dentro facendomi quasi sfondare la porta.
L'interno della baracca era grigio quanto l'esterno. Un gruppo di secondini stava accanto a una stufa a petrolio a scaldarsi le mani. Fuori faceva freddo e la neve ricopriva ancora il suolo. Sentii l'agitazione crescermi dentro man mano che ognuno di loro cominciò a osservarmi, posando inevitabilmente lo sguardo anche sul mio viso. Aspettavo le parole fatidiche: «Cos'hai in bocca?», ma nessuno parlò. Rimasi fermo, in piedi, per un'eternità. Mi guardai attorno. Lì dentro faceva molto più ; caldo che non nella tomba gelida e puzzolente in cui stavo ritornando. Qua e là vi erano delle sedie e, sopra la stufa a petrolio, un pacco di salviette e una bacinella di plastica piena di disinfettante blu. Sul pavimento un grande specchio, con un manico di legno, sembrava proprio fuori posto. I secondini cominciarono a muoversi tutti insieme attorno a me, con i manganelli che penzolavano sui fianchi. Per qualche ragione inspiegabile mi venne in mente la stanza di un dentista, forse perché quelli con cui avevo avuto a che fare non erano mai stati troppo pieni di attenzioni nei miei confronti.
«Dài, barbone, spogliati,» disse uno bruscamente.
Mi spogliai e rimasi nudo davanti a loro. Mi stavano tutti intorno, fissando attentamente ogni parte del mio corpo. Mi sentivo imbarazzato e umiliato. Non riuscivo a capire quali fossero le loro intenzioni. L'umiliazione era tuttavia poca cosa rispetto alla gola secca, alla piccola bomba che avevo in bocca e a ciò che si agitava nella mia mente al pensiero di quello che ancora mi aspettava, soprattutto se avessero scoperto il pacchettino.
«Dio mio,» pensai. «A che atti abietti ci costringono, per poi magari trovarci addosso la lettera d'amore della fidanzata, o il messaggio pieno d'ansia di una madre prostrata dal dolore, oppure anche solo un misero pacchettino di tabacco! Questa è pura tortura...»
«Girati!» borbottò rabbioso un altro secondino dal fare prepotente.
Feci un giro completo su me stesso. Mentre continuavano a osservarmi il panico si impadronì di me. Attendevo da un momento all'altro le fatidiche parole: «Apri la bocca!»
«Girati di nuovo!» ringhiò il secondino che mi aveva fatto da scorta.
«Un'altra volta!» mi dissi. «Questa tortura non finisce più...»
Se fossi riuscito a parlare avrei detto loro che mi avevano già umiliato abbastanza. Non avrebbero potuto farmi nulla di ancor più umiliante: la degradazione a cui mi avevano costretto era più che sufficiente.
Rimasi fermo, in silenzio. Lui mi minacciò, poi mi urlò di nuovo il suo comando.
Lo ignorai.
Fu come se qualcosa fosse caduto loro addosso. Per un attimo rimasero ammutoliti. Mi guardavano stupiti, increduli del fatto che io avessi osato disobbedire a un loro ordine. Erano rossi in viso e perplessi. La rabbia stava crescendo dentro di loro.
«Ci siamo,» mi dissi. «Ora ci siamo proprio...»
«Appoggiati a quel muro a braccia e gambe larghe,» grugnì alla fine uno, rompendo un silenzio che era sembrato interminabile.
Rimasi all'apparenza impassibile, anche se in realtà ero agitatissimo. Stavo tremando e non per il freddo. Ero così paralizzato dalla paura che stavo quasi per sputare il pacchettino per terra.
Mi afferrarono per le braccia e mi sbatterono contro il muro. L'impatto provocò un rumore sordo. Mi misero a braccia e gambe larghe, con le mani appoggiate alla parete. Mi arrivò un pugno nelle costole, poi presero a calci le mie caviglie per farmi allargare ancor più le gambe. Sentii una fitta lancinante alle braccia e il dolore che già provavo a causa dei lividi e delle escoriazioni si fece ancor più intenso. Continuarono a colpirmi alle caviglie con i loro pesanti stivali, senza smettere un attimo di gridare, di insultarmi, di minacciarmi.
Sentii i bordi freddi e smussati del grande specchio che mi veniva spinto tra le gambe. Stavano per ispezionarmi l'ano e lo specchio sarebbe servito loro per avere una visuale completa.
Una mano mi penetrò con forza e mi perquisì. Non ancora soddisfatti, mi presero a calci nella parte posteriore delle ginocchia, costringendomi carponi. Mi ispezionarono ancora con lo specchio e poi, per completare il lavoro, fecero cadere una pioggia di calci e pugni sul mio corpo nudo e martoriato.
Stramazzai sul pavimento sporco e bagnato dalla neve che, portata dentro dai loro stivali, si era sciolta. Mi alzai immediatamente tentando di inghiottire la saliva, ma il pacchettino mi andò di traverso e per poco non lo sputai a terra. Il mio viso si contorse e divenne tutto rosso mentre cercavo affannosamente di trattenere un colpo di tosse. Afferrai l'uniforme e cominciai a vestirmi più in fretta che potevo, per averla addosso prima che quelli terminassero di lavare le loro sadiche mani nella bacinella di disinfettante.
«Forse questo ti aiuterà a ritrovare la lingua!» disse uno di loro con voce stridula, asciugandosi le mani con una salvietta.
Il minimo accenno a una qualsiasi zona della bocca vicina al pacchettino mi faceva tremare. Finii di vestirmi in un attimo. Alle mie spalle una mano mi sollevò i capelli, per vedere se tenevo nascosto qualcosa dietro le orecchie. In preda al panico fui sul punto di far passare il pacchettino dalla bocca a una tasca che non mi avrebbero più perquisito, ma il secondino si allontanò da me e si diresse verso la bacinella di disinfettante.
Cercai con tutte le forze di arrivare alla porta, con l'uniforme che pendeva da ogni parte. Solo allora mi resi conto di quanto dolore stessi provando. La mia scorta mi seguì ringhiando. Raggiunsi la soglia, aspettandomi che dicessero: «Dove vai? Non abbiamo ancora finito!» ma non accadde nulla.
Avevo la gola in fiamme. L'aria fresca mi avvolse, rianimandomi un po'.
Fuori della baracca ragazzi di altri Blocchi stavano attendendo il loro turno. I loro volti erano bianchi come fantasmi e come la neve che avevano sotto i piedi. Sicuramente avevano sentito le grida e i colpi mentre io ero ancora dentro e sapevano fin troppo bene cosa li aspettava.
«Come va, Bobby?» mi chiese uno di loro.
Non riuscii a rispondere. Feci un cenno col capo per salutarli e far capire che ero loro vicino. Pensai a quello che avrebbero subìto e mi consolai all'idea di essermi già lasciato alle spalle quella tortura.
Cominciai a camminare lentamente verso i Blocchi H. Non c'erano furgoni a disposizione e io fui felice di percorrere a piedi quel breve tratto, godendomi il lusso di quei pochi minuti di aria fresca. «Superato il primo e più difficile ostacolo,» pensai.
La strada davanti a me era larga e coperta di neve. Ai lati vi era una palizzata scura, con in cima un orribile groviglio di chilometri di filo spinato. Tutt'intorno non vi erano altro che palizzate e una vera e propria giungla di filo spinato, fiancheggiate a intervalli regolari da sinistri posti di guardia mimetizzati, da cui i soldati inglesi tenevano sotto controllo tutta la prigione. Mi venne in mente un film che avevo visto quand'ero piccolo, ambientato in un campo di concentramento nazista in inverno. Ricordo ancora che ne ero rimasto impressionato, ma mi ero sentito al sicuro, seduto sulla mia sedia accanto al fuoco. Avevo pensato che un luogo come quello era solo un orrore del passato. Un orrore che non sarebbe mai stato più permesso o tollerato di nuovo, tantomeno in Irlanda, né mai mi sarebbe potuto capitare di viverlo in prima persona.
Pensai allora alla gente che parlava sottovoce attorno ai tavoli dello stanzone delle visite, ai volti di quelle madri segnati dal dolore, a quei padri che rimanevano in silenzio, ai bimbi che scoppiavano a piangere nel vedere i loro papà portati via in tutta fretta da mostri in uniforme nera. Erano gli stessi mostri spietati che si piegavano sulle nostre spalle per sentire ogni parola, ogni sillaba che pronunciavamo, che tenevano la nostra gente ad aspettare per ore e ore per una visita di solo mezz'ora, ammassando le persone come bestie tra un cancello e l'altro, tra un'umiliante perquisizione e l'altra, trattando tutti come animali.
Provavano per i nostri familiari lo stesso odio e disprezzo che avevano per noi. Li insultavano, li maltrattavano, li facevano soffrire enormemente, torturandone i figli. Quand'ero piccolo ero proprio ingenuo... E ora stavo per ritornare in una fetida tomba di cemento a combattere per sopravvivere, per difendere il mio diritto di essere riconosciuto come prigioniero di guerra, un diritto per il quale non avrei mai cessato di lottare.
Davanti a me, sulla destra, si profilò il Blocco H. Stetti ad aspettare che aprissero il cancello: l'entrata dell'Inferno. C'era un silenzio inquietante: non un sospiro di vento, né un canto di uccello. «Ma neppure a Belsen si cantava,» pensai, mentre superavo il cancello dell'Inferno.
Attraversai il cortile e giunsi alla porta principale del Blocco. Alla mia sinistra i ragazzi dell'altro braccio erano alle finestre. In alcune celle la luce era accesa, mentre le altre erano immerse nell'oscurità. Le prime sembravano piccole caverne, i cui abitanti erano avvolti in logore coperte. Facevano quasi paura, con le loro barbe lunghe e i volti pallidi, mentre mi guardavano da dietro le sbarre di cemento. Nelle celle al buio riuscii a distinguere i movimenti delle ombre che le popolavano.
«Tutto bene, Bobby?» mi gridò un ragazzo.
Non ce la feci a rispondere, così li salutai con la mano, sentendomi un po' stupido.
«Tieni duro! Ormai manca poco!» gridò un altro. Poi i ragazzi cominciarono a scherzare tra loro da una finestra all'altra.
Guardai alla mia destra l'altro braccio della H, quello in cui mi trovavo io. Le finestre sembravano essere scomparse e all'esterno non filtrava neppure un filo di luce. Lamiere e tavole ricoprivano il braccio per tutta la sua lunghezza, impedendo alla luce di entrare e la vista sul cortile. «Grazie a Dio non sono ancora arrivati sul mio lato,» pensai. «Ma non ci metteranno molto...»
Entrai nel Blocco e attesi ai cancelli. La mia scorta rabbiosa e indesiderata se ne andò. Fui fatto passare tra le due inferriate, poi «A» apparve e mi fece rientrare nel braccio.
Per tutto il corridoio riecheggiava forte, fastidioso e monotono, il rumore della macchina che aspirava le pozzanghere di urina che ancora rimanevano sul pavimento.
Il carrello del tè era sistemato fuori dalla cella delle perquisizioni. Passandovi accanto notai che sopra il tè ormai freddo si era formata una sottile pellicola. Le fette di pane raffermo erano ammucchiate l'una sull'altra. Nei piatti vi era un pezzo di carne che voleva somigliare a un hamburger e non più di una ventina di fagioli.
Entrai nella cella delle perquisizioni. La vista di «C» e di « D» mi fece passare in un attimo la voglia di mangiare. Ritornando dalla visita, mentre camminavo davanti alla mia scorta, ero riuscito a spostare leggermente il pacchettino in bocca e a inghiottire la saliva, ma ora avevo di nuovo la gola secca.
Cominciai a togliermi l'uniforme: pochi minuti ancora e sarei stato fuori pericolo. Solo pochi minuti! Mi sfilai i pantaloni e mi avvolsi l'asciugamano attorno alla vita. Me l'ero appena messo addosso quando «D» mi disse: «Togliti l'asciugamano e girati!».
Feci ciò che mi aveva ordinato, aspettando che mi dicesse anche di piegarmi in avanti, ma con mia sorpresa non aggiunse altro. Raccolsi l'asciugamano e me lo sistemai di nuovo in vita, dirigendomi verso la porta.
Non accadde nient'altro. Ce l'avrei fatta?
Varcai la soglia e uscii nel corridoio, aspettando le grida che mi avrebbero sommerso se si fossero accorti del pacchettino. Ma non fu così. Stentavo a credere alla mia fortuna. «A» disse ridacchiando:
«Portati la cena in cella prima che diventi fredda!».
«C» e «D» trovarono la battuta molto divertente. Gli inservienti che stavano lì attorno, a loro volta, scoppiarono in una risata isterica. Mentre prendevo il mio piatto e il mio bicchiere di tè notai quanto scarso fosse il loro contenuto. Camminai lungo il corridoio, che da quella parte era già asciutto.
L'inserviente con la macchina che assorbiva l'urina stava ancora lavorando in fondo al corridoio, ma aveva quasi finito. Il rumore della macchina faceva scoppiare il cervello. Mi sentivo felice come un'allodola e non ce la facevo più ad aspettare di tornare in cella. Non sopportavo l'idea di ritrovarmi là, ma allo stesso tempo non vedevo l'ora di togliermi dalla bocca il mio pacchettino proibito, arrivato a destinazione.
«A» mi aprì la porta e io rientrai nell'oscurità della mia tomba fredda e puzzolente. La porta fu sbattuta alle mie spalle, lasciandomi al buio.
Vittoria!
Avrei voluto poter dire loro che ce l'avevo fatta, che li avevo fregati tutti quanti, primo fra tutti quel bastardo di «C». Non riuscivo ancora a credere di essere riuscito a ritornare in cella senza problemi. Appoggiai sul pavimento il tè gelido ed estrassi dalla bocca il pacchettino. Fu un sollievo. Era bagnato, così lo asciugai con il bordo dell'asciugamano. Mi sistemai addosso le tre coperte e nascosi il pacchettino in una piega di quella che avevo attorno alla vita.
Le porte venivano aperte e chiuse una dopo l'altra a mano a mano che il tè veniva servito di cella in cella. Il rumore assordante della macchina che puliva la superficie del corridoio continuava implacabile. Probabilmente l'avrebbero lasciata accesa per delle ore, per farci impazzire. Mi chiedevo cosa fosse successo durante la mia assenza. Versai il tè fuori dalla finestra, poi gettai una rapida occhiata agli angoli della cella dov'era ammucchiata la spazzatura, per vedere se, per caso, qualche topo avventuroso avesse deciso di guardarsi un po' intorno mentre ero via. Non sarebbe stata comunque una novità: una volta era accaduto persino di notte.
Mi sedetti sul materasso e cominciai a mangiare, ripensando all'evento più importante di ogni mese, la mia visita. Quand'ebbi finito lasciai piatto e bicchiere vicino alla porta. «Eccomi di nuovo a lottare per sopravvivere,» mi dissi. Avevo freddo, così mi alzai per riprendere nell'oscurità il mio interminabile cammino senza meta. Controllai che il pacchettino fosse al sicuro e pensai con grande soddisfazione al mio successo. Non riuscivo tuttavia a spiegarmi perché, quand'ero ritornato, «C» e «D» non mi avessero ordinato di piegarmi in avanti per sottopormi a un'altra umiliante perquisizione. Mi erano sembrati quasi impazienti di sbattermi di nuovo in cella.
Il pavimento era gelido, così distesi una coperta a terra per poter continuare a camminare. Fuori c'era ancora la neve. Aveva ripreso a nevicare leggermente e i piccoli fiocchi stavano entrando dalla finestra.
Il frastuono della macchina, deliberatamente lasciata accesa, continuava. Cercai di pensare a qualcosa per vincere quel rumore assordante. Avrei voluto raccontare a Seán la bella notizia del mio successo, ma non mi avrebbe sentito.
Ripensai alle piccole "scéal" di cui ero venuto a conoscenza durante la visita. Più tardi le avrei riferite ai ragazzi. Non doveva mancare molto al momento in cui ci avrebbero portato dell'altro da mangiare, dal momento che la cena era stata servita tardi. Neppure in questo caso c'era da aspettarsi gran che: probabilmente solo un'altra tazza di tè tiepido, con pane e margarina. Ma la cosa importante era che, di lì a poco, i secondini avrebbero chiuso a chiave le nostre porte e nessuna cella sarebbe stata riaperta fino al mattino seguente.
Gettai un'occhiata fuori dalla finestra e pensai che più tardi, quando tutto si sarebbe calmato, avrei potuto pur sempre guardare i topi correre su e giù per il cortile. Non sarei riuscito a mettermi a dormire troppo presto, perché il freddo me lo avrebbe impedito. Ero stanco e stremato, ma la giornata non poteva considerarsi ancora finita.
Mi chiedevo come stessero i ragazzi che si trovavano nelle celle di punizione. Forse qualcuno di un altro braccio o di un altro Blocco H sarebbe ritornato oggi da quell'inferno e avrebbe potuto dirci cos'altro era accaduto. Le grida alle finestre per comunicare con gli altri bracci e gli altri Blocchi H sarebbero tuttavia cominciate solo più tardi, quando l'atmosfera si faceva più tranquilla e le guardie se n'erano già andate.
Sentii sbattere la porta della cella di fronte alla mia. Il rumore era stato appena percettibile. Probabilmente stavano ritirando i piatti. Con quel frastuono non aveva senso gridare, perché nessuno avrebbe sentito.
Accesero la luce e aprirono la mia porta. L'inserviente raccolse piatto e bicchiere e uscì, richiudendola con un colpo. Non feci a tempo a vedere i secondini, perché per un attimo rimasi abbagliato. L'improvviso passaggio dall'oscurità alla luce mi ferì gli occhi.
La mia cella disgustosa mi apparve così di nuovo, gridandomi addosso ancora una volta.
Le fette di pane raffermo che avevano gettato via davano un nuovo aspetto alla spazzatura che c'era negli angoli. Notai alcune macchie su di esse, così ne raccolsi una dai rifiuti. Era coperta di muffa blu. «Per fortuna non ho mangiato il pane,» pensai, controllando se anche le altre fossero nelle stesse condizioni. Capii allora quel che era successo, e il motivo per cui «C» e «D» non mi avessero ordinato di piegarmi in avanti durante la perquisizione, ma fossero stati così impazienti di rispedirmi di nuovo in cella a mangiare la mia cena al buio. Mentre rientravo ero stato troppo occupato a pensare al pacchettino che avevo in bocca per esaminare il pane che avevo nel piatto.
Il frastuono della macchina continuava. La luce era molto forte e gli occhi mi facevano già male. I primi temuti accenni di emicrania cominciarono a farsi sentire. Continuai a camminare inspirando profonde boccate d'aria alla finestra, per liberarmi dall'opprimente senso di soffocamento che stavo cominciando a provare.
Il rumore della macchina diventava sempre più insopportabile. Fuori la temperatura stava diminuendo e il ghiaccio che ricopriva il filo spinato si era fatto più spesso.
Estrassi il mio pacchettino e gli diedi un'occhiata. Potevo vederne il contenuto attraverso il cellophane: la lettera, le cartine di sigaretta e il tabacco scuro. Non era ancora il momento di aprirlo, così lo rimisi dov'era, in attesa di farlo più tardi. Avere un messaggio di mia sorella, alcune cartine di sigaretta e un quarto d'oncia di tabacco mi faceva sentire un re.
Cosa avrei provato se, di colpo, avessero aperto la porta lasciandomi libero? Non ce l'avrei fatta. Dio mio! A fatica ero in grado di sostenere una visita. Non riuscivo proprio a immaginare come mi sarei sentito se improvvisamente mi avessero liberato da quella tortura. Avevo imparato ad apprezzare le piccole cose che sembravano senza importanza, quelle che un tempo avrei dato per scontate o neppure notato. Quand'era stata l'ultima volta che avevo mangiato un pasto caldo e decente? «E' strano come ci si possa adattare, soprattutto quando si sta morendo di fame,» mi dissi, ricordandomi di quando, durante l'estate, inservienti e secondini avevano gettato dei vermi nei nostri piatti. A noi non era rimasto altro che raccoglierli a uno a uno, buttarli via e cominciare a mangiare come se nulla fosse successo. O facevamo così o morivamo di fame!
Il frastuono della macchina cessò improvvisamente e un silenzio terribile e innaturale cadde di nuovo su di noi. Sentii avvicinarsi i passi del secondino che l'aveva spenta. Guardai attraverso la fessura: era «A» . Superò la cella e si diresse verso il suo piccolo ufficio. La televisione era accesa, ma non riuscivo a udire nulla perché gli inservienti stavano facendo baccano. Sentii «C» gridare: « Andiamo!». Il chiasso cessò immediatamente, seguito dal rumore del carrello del tè che procedeva lungo il corridoio.
«Tè in arrivo!» gridarono i ragazzi in gaelico.
Cominciarono ad aprire e chiudere le porte. Passarono accanto alla mia mentre servivano l'altro lato. In alcune celle più avanti qualcuno stava canticchiando, riportando così un po' di vita nel braccio. Alla fine il carrello del tè raggiunse la mia porta. Quando l'aprirono mi trovai di fronte le solite facce odiose. L'inserviente mi porse una tazza di tè e una fetta di pane piegata in due. Sorpresi «A» a ridacchiare quando mi vide esaminare il pane, in cerca di macchie di muffa blu. Non ce n'erano.
La porta fu sbattuta e io tornai sul materasso, avvertendo uno strano calore. Vidi del vapore che usciva dal bicchiere di plastica. Era caldo! Quasi non ci credevo. Mi sedetti e l'assaggiai, un po' sorpreso. Era leggerissimo: del tè aveva solo il colore, ma decisi di berlo lo stesso. In una notte come quella qualsiasi cosa calda era un dono di Dio, persino dell'acqua. Mangiai la fetta di pane, sorseggiando il tè. «Fra non molto chiuderanno a chiave le porte,» pensai, pregustando il piacere che avrei provato nell'aprire il pacchettino e fumare una sigaretta.
A quell'ora mio padre e mia madre erano già a casa e probabilmente stavano molto male. Avevano avuto una giornata dura e, dopo aver visto il mio aspetto, non potevano che essere preoccupati. Pensai a tutti i genitori i cui figli stavano facendo la "blanket protest", o le cui figlie sostenevano la nostra protesta nel carcere di Armagli. C'era dolore ovunque. Quei maledetti gironi infernali non causavano altro che un'enorme, infinita sofferenza.
Non riuscii a finire il tè: mi dava la nausea. Mi alzai e lo gettai fuori dalla finestra, rimanendo a guardare la piccola nuvola di vapore che saliva verso l'alto mentre il tè sprofondava nella neve. Misi poi il bicchiere vicino all'entrata della cella e ripresi a camminare, non appena ricominciarono ad aprire e chiudere le porte.
«Raccolta dei bicchieri!» sentii gridare.
Avevo i piedi congelati. Per scaldarli li battei sulla coperta che avevo sistemato per terra. Il freddo sarebbe stato molto intenso quella notte.
Il ragazzo che si era messo a canticchiare intonò un'altra canzone. Non vi era alcun motivo per cantare, ma in qualche modo dovevamo pur vincere quella terribile monotonia. Io stesso ero annoiato a morte, ma la mia era soprattutto impazienza: non ce la facevo più ad aspettare di aprire il pacchettino. Spalancarono la porta, presero il bicchiere e la richiusero con forza. Non mi preoccupai neppure di guardare chi fossero. Secondini e inservienti continuarono la loro processione lungo il corridoio.
Per l'ennesima volta mi sedetti sul materasso per riprendere fiato. Sul lato opposto del corridoio erano otto i ragazzi che fumavano, e sul mio nove, me compreso, ma tre erano rinchiusi in cella di punizione: così, in tutto, eravamo quattordici. Quella notte sarei riuscito a far avere a tutti una sigaretta e forse mi sarebbe avanzato anche un po' di tabacco. Per riuscire in questo bisognava far passare una cordicella sotto la porta che aveva la fessura più ampia e farla arrivare dall'altra parte del corridoio. I ragazzi che si trovavano su quel lato non potevano passarsi le cose dalle finestre, perché le loro erano state sbarrate con tavole e lamiere. Così, in corrispondenza delle tubature, avevano ricavato dei piccoli buchi nei muri, che consentivano di far passare di cella in cella sigarette e acciarino. Per fare un acciarino occorreva un pezzo di vetro, una pietrina e un batuffolo di lana. Si faceva quindi uno stoppino, lo si accendeva e si passava con cautela quel materiale incandescente da una cella all'altra, fino a che tutti avevano acceso la loro sigaretta.
Lanciare una cordicella dall'altra parte del corridoio era complicato e pericoloso. I secondini sapevano di tutto questo ed erano sempre all'erta. Di notte stavano in agguato, aggirandosi in punta di piedi per il braccio. E poiché «B» sarebbe stato di turno quella notte dovevamo essere ancora più accorti.
Controllai se la lunga cordicella che avevo intrecciato fosse ancora dove l'avevo nascosta. Sì, c'era.
Seán batté sul muro.
«Avvicinati alle tubature,» gli dissi.
Andai nell'angolo e mi misi sopra il materasso, con la testa vicina al punto del muro dove scorrevano le tubature. Queste ultime non emanavano molto calore e quel poco che c'era si disperdeva fuori dalla finestra, nella notte buia e gelida.
«E allora, Bobby?» mi chiese Seán con ansia.
«"Go h-an mhaith" (16), Seán,» risposi soddisfatto. «Ce l'ho fatta a ritornare con tutto.»
«"Maith thú" (17),» disse.
Gli raccontai della mia visita, di ciò che era successo durante le perquisizioni e tutto il resto. Sentii l'eccitazione crescere nella sua voce mano a mano che lo rendevo partecipe di ogni avvenimento, della grande partecipazione della gente alla manifestazione e della massiccia offensiva nell'ambito della nostra guerra. Nel complesso le cose stavano andando bene. I tentativi del governo inglese di criminalizzare il Movimento repubblicano erano falliti miseramente e ora tutti erano consapevoli di quale fosse il vero scopo delle torture nei Blocchi H.
Continuai la mia conversazione con Seán. Dopo un po' cominciai a sentirmi tutto indolenzito in quella posizione scomoda contro le tubature e il muro, perciò decisi di rimettermi a camminare. Avevo i piedi intirizziti. Seán capì, perché era nelle mie stesse condizioni. Gli dissi che l'avrei chiamato di nuovo più tardi. Entrambi lasciammo il nostro angolo per riprendere quell'interminabile cammino da dove l'avevamo interrotto.
I secondini cominciarono a sbarrare porte e cancelli, in vista della chiusura delle celle per la notte. Gli inservienti se n'erano andati nei loro dormitori: due grandi stanze attigue ai bracci, appositamente attrezzate per loro e dotate di lussi quali televisione, radio, registratore e altre cose. Era il compenso per lo sporco lavoro che eseguivano fin troppo bene. Alcuni di loro non ci importunavano, ma erano veramente pochi.
«A», «C» e «D» erano all'inizio del braccio. Parlavano e scherzavano tra loro, aspettando il momento di chiudere a chiave le celle. «Non deve mancare molto,» pensai. «Forse un quarto d'ora.» Ci dovevano contare due volte: la prima toccava ai secondini che se ne andavano, «A» e compagni, l'altra a quelli del turno di notte che sarebbero arrivati di lì a poco. Questi ultimi erano solo quattro. A volte guardavano la televisione, giocavano a carte o si ubriacavano a tal punto da non darci alcun problema. Tuttavia quasi sempre succedeva qualcosa, soprattutto quando c'era qualcuno come «B». E «B» sarebbe stato di guardia quella notte!
Ero stanco di camminare, così decisi di sedermi e di correre il rischio di aprire il pacchettino. Era improbabile che venissero a perquisire le celle, ma il pericolo c'era sempre e perciò dovevo essere molto prudente. Sarebbe stato terribile se mi avessero scoperto, dopo tutto quello che avevo passato quel giorno. Ero tuttavia troppo impaziente per aspettare ancora. Estrassi il mio piccolo tesoro, tolsi il cellophane e recuperai il biglietto. Prima di cominciare a leggere la lettera di mia sorella riavvolsi il resto del contenuto nel cellophane, per precauzione.
Mi sedetti e per alcuni minuti rimasi fermo e in silenzio. Riuscii a decifrare ogni parola della sua chiara e minuscola scrittura. Quando ebbi finito rilessi tutto di nuovo. Era bello avere ancora sue notizie. Mi sembrava che fosse passata un'eternità dall'ultima volta che l'avevo vista. Diceva che stava bene e che era preoccupata per me più di qualsiasi altra cosa. Mi chiedeva notizie dei ragazzi che conosceva. Dovevo cercare di farle avere una risposta il più presto possibile. Per scrivere avevamo a disposizione solo una misera matita e un refill di penna biro, che venivano fatti passare di cella in cella, avanti e indietro, da una parte all'altra del braccio. Ce ne servivamo per riempire ogni minimo spazio dei pezzetti di carta igienica che usavamo per far avere nostre notizie a mogli, madri e fidanzate in ansia, per le lettere ai giornali o per i brevi messaggi, scritti in tutta fretta e destinati all'Ufficio informazioni sui Blocchi H, in cui descrivevamo i pestaggi e gli orrori che avvenivano ogni giorno. Avrei cos ì dovuto attendere il mio turno per poter usare il refill o la matita.
Strappai il breve messaggio di mia sorella e lo gettai fuori dalla finestra. Guardai i pezzettini di carta svolazzare per il cortile coperto di neve, fino a confondersi con i fiocchi che stavano cadendo.
«A» e compagni si trovavano ancora all'inizio del braccio, vicino ai cancelli. Riuscivo a sentire il tintinnio delle chiavi e le loro voci. Decisi di rischiare un'altra volta e di aprire di nuovo il picchettino: volevo preparare le sigarette, per averle pronte nel momento in cui sarebbe stato possibile farle passare dall'altra parte del corridoio. Svolsi di nuovo il cellophane ed estrassi la piccola quantità di tabacco fresco e debitamente pressato. Cominciai a sminuzzarlo e a lavorarlo fra le dita, fino a farlo diventare un mucchietto filamentoso. Il suo aroma era piacevolmente diverso dal puzzo insopportabile che appestava la mia cella. Separai le cartine di sigaretta le une dalle altre, fino a averne un numero sufficiente per tutti e anche qualcuna in più. Quand'ebbi tutto pronto cominciai ad arrotolarle, con le orecchie tese a percepire il minimo rumore di passi o di chiavi. Continuavo a ripetermi che non mancava ancora molto al momento in cui me ne sarei stato disteso sul materasso a fumare.
Cinque pronte... Cominciai a preparare la sesta. Pensai a quanto importante fosse anche una sola sigaretta e quanto potesse risollevare il morale persino ai ragazzi che non fumavano. In un modo o nell'altro a tutti faceva piacere venire a sapere che uno di noi era riuscito a fregare dei bastardi come « A» e «C», e questo voleva dire molto. Presi un'altra cartina per preparare la settima sigaretta...
«Orsi in arrivo!»
Sentii tintinnare una chiave. Gettai in tutta fretta una coperta sopra la mia roba, mentre la mia serratura veniva fatta scattare e la porta si spalancava. Cercai di comportarmi normalmente, sebbene fossi in preda al panico. « A» guardò dentro la cella.
«Uno,» disse, mentre «C» richiudeva la porta con un colpo.
«L'appello!» gridai, con il terrore nella voce.
«Due,» continuò «A», e la porta di Seán fu sbattuta. «Quattro... Sei... Otto...,» sentii gridare lungo il braccio.
Un brivido mi percorse tutto. «C'è mancato poco,» pensai, guardando la coperta che copriva il tabacco e le sigarette. Se ne intravedeva una addirittura, ma non l'avevano notata. Rimasi incollato al materasso, mentre quelli terminavano di contarci.
«Venti... Ventidue... Ventiquattro... Ventisei...» disse alla fine «A».
«Orsi in partenza!» gridò un ragazzo quando l'ultimo numero venne pronunciato, per avvisare gli altri del cessato pericolo.
«A», « C» e «D» chiusero la porta dell'ufficio e se ne andarono dal braccio.
Recuperata la calma e la mia roba clandestina ritornai ad arrotolare le sigarette. «Dovrei aver finito prima del secondo e ultimo appello,» pensai. «B» si sarebbe fatto sentire ancor prima di entrare nel braccio, perché sarebbe tornato sicuramente ubriaco.
Continuai il mio lavoro finché ebbi preparato tutte le sigarette, poi le divisi e feci due pacchetti: uno per noi e uno per i ragazzi che si trovavano sull'altro lato del braccio. Presi la lunga e sottile cordicella che avevo intrecciato e legai ad essa entrambi i pacchetti. Per appesantirla fissai a un'estremità un pezzo di pane raffermo e coperto di muffa blu.
Picchiai sul muro per chiamare Seán.
«Ciao,» mi disse.
«Metti fuori la mano,» gli gridai, e cominciai a far oscillare la cordicella nella sua direzione. Quando l'afferrò gli spiegai cosa contenevano i pacchetti. Gli dissi di far arrivare la cordicella e un pacchetto al ragazzo che avrebbe effettuato l'operazione, in modo tale che potesse prepararsi. Seán batté sull'altro muro e cominciò a far passare le sigarette.
Nascosi sotto il cuscino la mia più altre due, una per Seán e una per me.
Un cancello che veniva aperto, un tintinnio di chiavi e un mucchio di oscenità annunciarono l'arrivo di «B». Venne avanti lungo il corridoio con passi lunghi e pesanti, mentre l'ultimo appello cominciava dalla parte opposta del corridoio, con un'altra ondata di porte sbattute. Procedettero dall'una all'altra, finché aprirono la mia. «B» guardò dentro la cella: riusciva a malapena a stare in piedi e a contare. Nell'andarsene quasi inciampò su se stesso, poi la mia porta venne chiusa di nuovo.
«Orsi in partenza!» Fu il segnale di cessato pericolo.
Nessuno si era preoccupato di avvisare gli altri dell'arrivo dei secondini, perché tutti sapevano che prima o poi sarebbe accaduto.
Sul braccio scese il silenzio. Dal fondo del corridoio una voce gridò:
«Bene, ragazzi, adesso diciamo il rosario. Chi recita il Primo Mistero?».
«Io,» gridò uno.
«E il Secondo?»
«Io,» disse Seán.
Altri tre ragazzi si offrirono per le tre decine di preghiere che rimanevano.
«Stasera reciteremo i Misteri Dolorosi,» disse la prima voce.
Pronunciò il segno della Croce e le formule iniziali. Il rosario cominciò e i ragazzi gridarono una preghiera dopo l'altra da dietro le loro porte.
A metà del Terzo Mistero un secondino iniziò a sbattere ripetutamente il suo manganello contro le grate di un cancello. La recita del rosario non si interruppe e, come al solito, quello si stancò e se ne andò.
Quando il rosario fini il braccio prese ad animarsi come un alveare.
I ragazzi di alcune celle più avanti decisero di far passare le sigarette dall'altra parte del braccio, prima che «B» o qualche altro secondino si mettessero in agguato.
«Ehi, Bobby, controlli tu il corridoio, nel caso arrivi qualcuno?» mi gridò uno di loro.
«Sì, certo,» gli risposi, e mi diressi verso la mia fessura. Lanciare il filo dall'altra parte era sempre un'operazione difficile.
«Seán, riesci a veder fuori dalla tua porta?» chiese la stessa voce.
«No,» rispose Seán.
«Io sì,» disse Brian, uno dei ragazzi in fondo.
«Ce la fai a vedere quella di Gerard?»
«Sì, la vedo bene.»
«"Maith thú",» disse chi stava per effettuare il lancio. «Allora ci guiderai tu.»
«Ci sei, Bobby?» si assicurò un altro, per maggior precauzione. Se ci avessero scoperto sarebbe stato un disastro.
«Sì, sono qui,» risposi, non azzardandomi a staccare l'occhio dalla fessura.
Alla cordicella doveva essere attaccato un bottone che, con un colpetto, veniva lanciato sul pavimento del corridoio, attraverso la fessura della porta. Chi si trovava dall'altro lato doveva cercare di arrivare al bottone che era stato lanciato di fronte alla sua cella, servendosi di una striscia di carta. A quel punto faceva scivolare la carta sotto il bottone e poi, pian piano, li tirava entrambi indietro, fino a farli scorrere sotto la sua porta. Cominciava allora il passaggio di messaggi, sigarette o altro. Le sigarette venivano legate alla cordicella e, come un lungo treno, fatte arrivare dall'altra parte del corridoio.
«Sei pronto, Gerard?» chiese il lanciatore.
«Comincia pure, Pat.»
Si udì un colpo secco e il bottone che strisciava sul pavimento.
«Riesci a vederlo, Brian?» domandò Pat a chi, qualche cella più in là, gli stava facendo da guida.
«Troppo lontano a sinistra,» disse Brian. «Lancialo di nuovo.»
Pat tirò indietro la cordicella. Si sentì di nuovo il colpo secco e il bottone che correva sulla superficie del corridoio. Nel braccio era sceso un silenzio di tomba. Ogni orecchio era teso a captare ogni minimo segnale premonitore.
«Com'è adesso?»
«Troppo corto,» rispose Brian con voce tesa.
La cordicella venne tirata indietro per la seconda volta. Il terzo lancio fu troppo forte: il bottone rimbalzò contro la porta e dovette essere lanciato un'altra volta. Sentimmo il quarto colpo secco.
«E adesso?» chiese Pat nervosamente.
Tutto il braccio ascoltava con trepidazione.
«Lascialo dov'è!» rispose Brian tutto eccitato, e aggiunse:
«Gerard, fa' scivolare fuori la striscia di carta». La carta passò con un fruscio sotto la porta. «Spostala verso sinistra,» ; continuò Brian. «Ancora qualche centimetro... Ecco... Ci siamo... Adesso spingila in fuori più che puoi... No, non così... Prova di nuovo...»
Il mio occhio, premuto contro la fessura, cominciava a farmi male. C'era assoluto silenzio. Nessuno osava parlare, tranne i ragazzi al lavoro.
Si sentì di nuovo il fruscio della carta.
«Spingila in fuori lentamente, Gerard... Ci siamo! Piano, piano... " Maith thú", Gerard! Adesso la carta è sotto il bottone. Tirala verso di te lentamente... Così!... Così!... Con calma...»
«L'ho preso!» sentimmo gridare finalmente.
«Tutto bene, Bobby?»
«Sì, almeno credo, Pat.»
«Tira la cordicella verso di te, Gerard,» disse Pat, «ma senza strappi.»
Le sigarette passarono sotto la porta di Pat e scivolarono nel corridoio.
« Fa' piano,» disse Brian, «o rimarranno incastrate.»
Una dopo l'altra Gerard recuperò tutte le sigarette, tranne l'ultima, che rimase impigliata nella cordicella.
«Non tirarla troppo... Muovila un po'... Ecco... Si sta districando da sola... Prova adesso...»
In quell'attimo intravidi un'ombra e sentii lo scricchiolio di uno stivale.
«Orsi in arrivo!» gridai, mentre l'ombra mi sfrecciava davanti.
«Non fermarti, Gerard!» gridò Brian.
Sentimmo una gran confusione: il secondino stava cercando di afferrare la cordicella. Poi ritornò il silenzio, interrotto solo dal rumore dei passi che si allontanavano. Quando quello mi passò davanti riuscii a vederlo in viso. Non lo conoscevo.
«Tutto bene, Gerard?» chiese Pat.
«Sì. Ce l'ho fatta a recuperarle tutte, ma lui è riuscito a prendersi il bottone.»
Almeno le sigarette erano in salvo. La perdita del bottone non era di per sé una cosa grave, ma per noi era pur sempre una perdita, viste le condizioni in cui ci trovavamo.
«Bene, ragazzi,» disse l'O/C. «Adesso svuotiamo i buglioli.» ;
Cominciammo a far passare l'urina puzzolente sotto le porte. Bisognava farlo, perché altrimenti quella sarebbe stata la prima cosa che i secondini avrebbero fatto il mattino seguente. Non era certo piacevole essere svegliati dal rumore dell'urina rovesciata fuori dai buglioli fetidi. Erano comunque quasi vuoti, dal momento che quel giorno erano già stati svuotati.
Mi misi ai piedi della porta e cercai di far fuoriuscire tutto.
Quand'ebbi finito mi sedetti sul materasso per riprendere un po' di forza. Ero completamente senza fiato e ansimante. «E' un chiaro segno del mio cattivo stato di salute,» pensai, ritrovandomi stremato in così breve tempo. Rimasi ad aspettare l'arrivo dello stoppino acceso che mi sarebbe servito da fiammifero. «Siamo stati abbastanza fortunati con i lanci,» ; mi dissi. Se la guardia fosse arrivata pochi secondi prima sarebbe riuscita a portar via tutto.
Seán picchiò sul muro.
«Ehi, Bobby, eccolo.»
Sapevo cos'era, così misi la mano fuori dalla finestra per afferrare la cordicella che oscillava, con lo stoppino improvvisato e incandescente legato a un'estremità. Riuscii a prenderlo e accesi la sigaretta.
«Ecco fatto, Seán,» gridai.
«Rilanciamelo ora,» mi rispose, e io gli rispedii indietro la cordicella. Seán batté sull'altro muro per far passare di nuovo lo stoppino alle altre celle e io mi sdraiai a fumare la sigaretta. Era un sollievo poter stare distesi a godersi qualcosa, senza il timore che la porta venisse aperta improvvisamente. Le chiavi delle nostre celle non venivano tenute nei Blocchi H, ma da un'altra parte. Inoltre i ragazzi dell'altro braccio avrebbero potuto accorgersi dell'arrivo di un secondino con le chiavi e dare l'allarme.
«Orsi in cortile!» sentii gridare, ma non c'era da preoccuparsi, a meno che uno non stesse per passare qualcosa dalla finestra.
I secondini erano in fondo al cortile e stavano lanciando insulti ai ragazzi che si trovavano più in giù nel braccio. Finii la sigaretta e andai alla finestra per vedere chi fossero. Venivano avanti con la loro aria da spacconi. «B» urlava a più non posso, quasi con la bava alla bocca. Insieme a lui altri due ce la mettevano tutta per far sentire le loro ingiurie da quattro soldi. I tre passarono vicino alla mia finestra e si diressero verso l'altro braccio.
L'O/C chiese l'attenzione di tutti. Si fece subito silenzio. Domandò se qualcuno aveva visto o era riuscito a capire quel che era successo durante lo svuotamento dei buglioli e cos'era accaduto a Pee Wee O'Donnell. Gli riferii quello che avevo sentito e visto dalla fessura. Dopo di me diversi altri aggiunsero ulteriori particolari. L'O/C volle poi sapere chi era rimasto ferito durante il cambio di braccio avvenuto nelle prime ore del mattino. I terribili resoconti dei maltrattamenti subiti furono gridati da dietro le porte.
«Okay, ragazzi,» disse l'O/C quando ritornò il silenzio. « ;Nient'altro?»
Era stato messo al corrente di tutto e di ogni cosa era stata presa nota per l'Ufficio informazioni sui Blocchi H. «Ci sono "scéal", Bobby?» mi chiesero.
Per alcuni minuti riferii ciò che avevo saputo dai miei familiari.
«E questo è tutto,» dissi, quando fui certo di aver finito. Ci furono grida ed esclamazioni di gioia, poi i ragazzi ripresero a parlare tra loro alle finestre, vicino alle tubature e alle porte, commentando ogni più piccola notizia. Le mie "scéal" erano buone e questo voleva dir molto per noi. Frattanto, attraverso il cortile, i ragazzi che avevano le finestre sbarrate stavano ricevendo da quelli del braccio di fronte il resoconto di ciò che era accaduto quel giorno negli altri due bracci del nostro Blocco: un prigioniero di ogni braccio era stato portato in cella di punizione; uno era stato brutalmente picchiato; sei celle erano state allagate dagli idranti usati per pulire i muri dall'esterno...
Gli orribili resoconti del giorno continuarono. Il puzzo che proveniva dal corridoio era insopportabile, così mi alzai e mi avvicinai alla finestra per respirare un po' d'aria fresca. Fuori la neve brillava, illuminata da mille luci. Un leggero vento ci portava le voci e i canti provenienti dai Blocchi dove si trovavano gli altri "blanket men". Centinaia di uomini nudi, fisicamente distrutti, erano ancora vivi.
Il freddo era molto intenso. Per l'ennesima volta mi misi addosso le coperte e mi sistemai l'asciugamano attorno alla testa e al collo, a mo' di sciarpa.
Anche i ragazzi degli altri Blocchi del campo continuavano a gridarsi messaggi gli uni con gli altri, avanti e indietro. Ci arrivarono così altre notizie terribili: diversi uomini picchiati a sangue durante un cambio di braccio e due portati in cella di punizione; in un altro braccio tre uomini ustionati e due trasferiti in cella di punizione, dopo essere stati scoperti con addosso del tabacco mentre tornavano dalla visita; uno rientrato dalla cella di punizione, dove era stato picchiato duramente e lavato con la forza; diversi altri, in cella di punizione, sottoposti allo stesso trattamento; Pee Wee O'Donnell ricoverato in ospedale; altri ragazzi gravemente contusi.
«Stai ascoltando, Seán?» gli chiesi.
«Sì, Bobby.»
Gli agghiaccianti resoconti in gaelico non si interrompevano. In un altro braccio quarantaquattro detenuti erano stati picchiati, lavati e rasati con la forza. Due si trovavano in ospedale e di altri due non si era più saputo nulla: probabilmente erano stati portati in cella di punizione. Il Blocco H5 riferì all'H3 che, durante lo svuotamento dei buglioli, diversi prigionieri erano stati feriti dai secondini e uno di loro era stato portato in cella di punizione. L'H3 aveva ricevuto sei nuovi "blanket men", condannati il giorno prima.
Le grida continuavano. I Blocchi H erano distanti tra loro, ma le voci giungevano ugualmente, riecheggiando nella notte attraverso la neve, sopra le grigie palizzate e il filo spinato. Molto spesso i messaggi dovevano essere ripetuti più volte prima di essere compresi. Sovente le parole venivano scandite una lettera dopo l'altra, ma con un po' di pazienza questo sistema funzionava. Quando ci avrebbero sbarrato le finestre, tuttavia, la comunicazione con gli altri Blocchi non sarebbe più stata possibile.
«Luci spente!» gridò un ragazzo che si trovava sull'altro lato del braccio. I secondini avevano cominciato a spegnere le luci. Molto probabilmente sarebbero ritornati per riaccenderle nel bel mezzo della notte. «Comunque non riusciremo a dormire molto lo stesso, visto il freddo che fa,» pensai mentre rimanevo al buio. Picchiai sul muro per chiamare Seán.
«Ciao,» mi salutò.
«Fatti dare di nuovo lo stoppino,» gli dissi.
«"Maith thú",» mi rispose, e chiese agli altri di farglielo avere.
«Mi senti, Seán?» gli domandai. «Quando ti rimando indietro la cordicella ti faccio avere una sigaretta.»
«"Maith thú",» rispose di nuovo.
La cordicella raggiunse la finestra di Seán e lui la fece oscillare verso di me. Mi accesi la seconda sigaretta, legai la sua al filo e glielo rimandai indietro.
«Tutto bene, amico?»
«Sì, Bobby.»
Mi sedetti di nuovo. Continuavo a pensare che era valsa la pena rischiare così tanto. Nella semioscurità vidi il fumo che saliva verso il soffitto e usciva dalla finestra. Per qualche minuto il fetore della cella fu coperto dall'aroma del tabacco. Faceva molto freddo, perciò decisi di rimettermi a camminare una volta finita la sigaretta. «Povero Pee Wee!» pensai. «Sarà nell'ospedale della prigione o forse addirittura a Musgrave!» Sicuramente i ragazzi che si trovavano in cella di punizione erano più morti che vivi e stavano soffrendo molto. Neppure io, comunque, mi sentivo bene. Le ferite mi facevano sempre più male, ma sapevo che le mie condizioni erano molto migliori delle loro.
Stetti a guardare la brace incandescente della sigaretta spegnersi sul pavimento sporco, poi mi alzai a camminare, usando la coperta come tappeto.
«Orsi in cortile!» sentimmo gridare da un altro Blocco.
Il freddo si era fatto ancora più intenso. La neve, ormai alta, continuava a cadere senza interruzione.
Chissà cosa stavano facendo in quel momento i nostri aguzzini. Probabilmente «A» se ne stava a bere al bar della prigione, insieme al resto dei suoi amici mercenari e a soldati inglesi. «C» e « D» erano a casa con le loro famiglie. Mi domandavo cosa avrebbero risposto se i loro bambini avessero chiesto loro: «Cosa hai fatto oggi, papà ;?». Cosa avrebbero pensato le loro mogli e i loro figli, se avessero saputo cosa ci stavano facendo, quanta sofferenza, dolore e tortura stavano infliggendo a centinaia di uomini nudi?
Camminavo in cerchio senza meta. I ragazzi stavano ancora parlando e scherzando tra di loro. Un paio cantavano da soli. Stavo per sedermi di nuovo sul materasso quando fu gridato l'allarme:
«Orsi in arrivo! Equipaggiamento pesante!».
Sapevo quel che stava per accadere. Corsi verso il materasso e lo misi in piedi contro il muro, nell'angolo più lontano dalla porta. Dimenticando il freddo sistemai le coperte dietro al materasso, poi nascosi ciò che restava del mio pacchettino di tabacco in una piega dell'asciugamano, che mi avvolsi attorno alla vita. Udii il primo splash di liquido che veniva rovesciato contro il fondo della porta di fronte alla mia. Equipaggiamento pesante... Già respiravo il detergente a base di ammoniaca, un disinfettante fortissimo ed estremamente pericoloso. I secondini lo stavano rovesciando nelle fessure, sotto e ai lati delle porte. Quando accesero le luci del corridoio mi arrischiai a guardar fuori: un gesto molto avventato, perché se il disinfettante mi fosse finito negli occhi me li avrebbe bruciati, accecandomi in un attimo. «B» stava svuotando un secchio pieno di quel liquido sotto la porta di fronte alla mia, gridando agli altri secondini di sbrigarsi e di portarne ancora. Udii chi stava in quella cella tossire come se fosse stato sul punto di soffocare. I ragazzi che si trovavano sull'altro lato del braccio dovevano proprio essere nei guai, perché le loro finestre erano sbarrate. Le esalazioni del disinfettante producevano un effetto analogo a quello dei gas lacrimogeni: irritavano fortemente gli occhi e la gola, causando conati di vomito e cecità temporanea.
Sentii che stavano svolgendo la pompa dell'acqua in cima al corridoio.
«Pompa in arrivo!» urlai, e mi allontanai dalla porta. «B» continuava a rovesciare il disinfettante sotto le porte come un forsennato, ridendo in continuazione. Portava una maschera sul viso per proteggersi dalle esalazioni. Di sicuro lui e compagni avevano addosso delle tute blu di nylon. La pompa venne azionata e i suoi potentissimi getti si infransero contro il fondo delle porte. Udii un sibilo, poi vidi il liquido color verdastro penetrare da sotto la mia. Le esalazioni mi raggiunsero immediatamente. Cominciai a tossire e a sputare, cercando con gli occhi pieni di lacrime di arrivare alla finestra. Sentii il mio stomaco contrarsi e pensai di essere sul punto di vomitare, mentre cercavo disperatamente di respirare un po' d'aria alla finestra, con la testa schiacciata contro le sbarre di cemento. Dovevamo essere tutti alle finestre a tossire: era tutto ciò che riuscivo a sentire, a causa del rumore dei potenti getti d'acqua. Le lacrime mi facevano inciampare. Non riuscivo a vedere nulla.
Poi l'acqua entrò dalle fessure della porta e allagò il pavimento sporco. Non me ne importava nulla. Stavo malissimo e continuavo a tossire. Avevo la gola in fiamme. Sapevo che l'acqua avrebbe diluito il disinfettante, ma sarebbero occorsi parecchi minuti prima che le esalazioni cominciassero a diminuire d'intensità. L'acqua non cessava di entrare da sotto la porta e si fermò solo quando passarono alla cella successiva.
Continuavo a tossire e a sputare, anche se le esalazioni stavano divenendo meno forti. Seán era in preda a forti conati di vomito. In tutto il braccio non si sentivano altro che lamenti e colpi di tosse. «B» non la smetteva di urlare: «Vi piace, eh? Vi piace?». Poi si mise a cantare l'unica canzone che conosceva, "The Sash". Mi azzardai ad avvicinarmi al mio spioncino e vidi che stava camminando a fatica in mezzo al fiume d'acqua, disinfettante e urina, con la maschera in una mano e il secchio vuoto nell'altra. Rideva come un pazzo. Un altro secondino lo seguiva trascinando il tubo dell'acqua, mentre un terzo gridava oscenità e insulti dal fondo del corridoio.
Avevo gli occhi in fiamme, ma cominciavo a stare un po' meglio. Sentivo che nelle altre celle i ragazzi continuavano a tossire. C'erano almeno tre centimetri d'acqua sul pavimento. Il fondo del mio materasso era completamente bagnato, ma le coperte erano al sicuro sopra le tubature.
Cominciai il massacrante e interminabile lavoro che consisteva nello spingere quel mare di liquido sotto la porta, raschiando il pavimento come meglio potevo.
«Come va, Seán?» gridai.
«Sono distrutto,» mi rispose.
I colpi di tosse a poco a poco cessarono. A essi si sostituì il rumore dei buglioli che grattavano il pavimento, quando ognuno di noi si mise a far fuoriuscire l'acqua nel corridoio.
La spazzatura maleodorante e in putrefazione galleggiava qua e là attorno ai miei piedi e ostruiva ogni più piccolo spazio sotto la porta. Dovevo continuamente tirarla via con le mani. Raccoglievo manciate di pane fradicio e altre schifezze e le ributtavo nell'angolo.
Il livello dell'acqua cominciò a diminuire. Le esalazioni riempivano ancora l'aria, ma non erano più intense come prima.
Fuori la neve stava cadendo fitta e un vento leggero la faceva entrare dalla finestra. «Dio mio,» pensai. «Cosa ci aspetta ancora?» Avevo i piedi bagnati e gelidi, ma mi sentivo esausto e tutto sudato mentre continuavo a grattare il pavimento. Quand'ebbi finito strizzai l'estremità del materasso zuppa d'acqua, poi strappai un pezzetto di gommapiuma e cercai di prosciugare le pozzanghere che ancora rimanevano.
Diedi un'occhiata veloce al fiume di urina, sporcizia e rifiuti di ogni genere che aveva formato un lago nel corridoio. I secondini sarebbero tornati nel mezzo della notte, per prosciugarlo con la loro macchina dal rumore insopportabile.
Gettai in un angolo il pezzetto di gommapiuma e andai alla finestra a riprender fiato. Ero stremato e non potevo rimanere in piedi sul pavimento gelido troppo a lungo. I fiocchi di neve continuavano a entrare. Avevo solo l'asciugamano che mi copriva, così presi le coperte e me le avvolsi addosso. Il pavimento era ancora scivoloso e bagnato. Più tardi non avrei avuto altra scelta che rimettere il materasso per terra, pur sapendo che l'umidità sarebbe filtrata attraverso la gommapiuma, penetrandomi nelle ossa. L'alternativa era continuare a camminare, anche se non sarei riuscito comunque a farlo per molto. Si preannunciava una notte lunga, gelida e inquieta.
Alle finestre i ragazzi parlavano delle disastrose condizioni in cui si trovavano. Molti avevano i materassi bagnati fradici, altri le coperte nello stesso stato. Io non potevo lamentarmi, perché di bagnato avevo solo il fondo del materasso. Il rumore dei buglioli che raschiavano il pavimento era cessato. Materassi e coperte si stavano asciugando, per quanto possibile.
«C'è qualcuno che vuole cantare una canzone?» fu la domanda che tutti conoscevamo bene. Dopo quel che era successo dovevamo pur fare qualcosa per risollevare il nostro morale, anche perché ognuno di noi sarebbe stato costretto a continuare a camminare. Ci furono grida di approvazione, poi un grande applauso accolse il primo cantante. Mi misi a camminare avanti e indietro, ascoltando la prima canzone, "The Old Alarm Clock". La seconda, "My Old Home Town on the Foyle", fu cantata da uno dei ragazzi di Derry. Uno dopo l'altro quelli che venivano chiamati si mettevano a ridosso delle porte a cantare. Poi venne il mio turno, così mi avvicinai alla porta e intonai "The Curragh of Kildare". Per tutta la durata della canzone mi aspettai che «B» ritornasse di nascosto e mi gettasse un secchio di disinfettante sulla faccia, attraverso la fessura laterale della porta. Quasi senza fiato, terminai la mia canzone tra gli applausi e quando annunciarono il cantante successivo ricominciai a muovermi avanti e indietro. Avevo i piedi congelati. Il pavimento si era asciugato molto poco ed era ancora scivoloso. Mi resi conto che non ce la facevo più a camminare, così rimisi il materasso per terra in un angolo e mi ci rannicchiai sopra, nella parte che era rimasta asciutta. Le ferite che mi avevano provocato durante il cambio di braccio e nel corso della perquisizione dopo la visita mi facevano molto male. Fui tentato di preparare un'altra sigaretta per me e per Seán, ma poi decisi di non farlo e di conservare il tabacco per la sera dopo. Ce la saremmo potuta fumare in due, passandocela con la cordicella, e da come si stavano mettendo le cose sarebbe stata certamente di gran conforto.
Le canzoni si susseguivano. Rompevano la monotonia e alleggerivano la tensione che c'era nell'aria, permettendo alla nostra mente di estraniarsi per alcuni minuti dall'inferno in cui ci trovavamo.
Non vi erano segni del ritorno di «B». Probabilmente se ne stava da qualche parte in mezzo alla confusione dei secondini, oppure a ubriacarsi ancora.
Un ragazzo cantò una canzone sui "blanket men" che lui stesso aveva composto, davvero molto bella, poi un altro intonò "Ashtown Road". Nel braccio si fece silenzio assoluto e io rimasi seduto ad ascoltare, tremando leggermente, ogni parola, ogni nota di quella bellissima ballata che quel ragazzo cantava con voce molto triste. Il mio morale si risollevò. Ancora una volta fui fiero di continuare a resistere. Meglio soffrire mentre si cerca di resistere, piuttosto che essere torturati e non opporre resistenza alcuna.
Quando il ragazzo ebbe finito di cantare il braccio fu scosso da un'ondata di applausi. Il «Maestro di Cerimonie» gli chiese un'ultima canzone ed egli cominciò di nuovo, questa volta con "The Wind that Shakes the Barley".
La neve continuava a entrare dalla finestra senza vetri. Mi venne in mente quella notte in cui fummo costretti a mandarli in frantumi a mani nude, perché i secondini ave vano gettato litri di fortissimo disinfettante sotto le porte. I ragazzi che stavano sull'altro lato dovevano essersela vista brutta. Li avevo sentiti maledire le finestre sbarrate quando «B» aveva rovesciato il disinfettante sotto le loro porte.
Il cantante terminò l'ultima canzone di quella sera e tutti gli fecero un calorosissimo applauso. Poi i ragazzi ripresero a chiacchierare tra loro.
Sull'altro lato qualcuno stava ricevendo un messaggio in gaelico proveniente dall'altro braccio, che fu subito trasmesso all'O/C. Un ragazzo stava molto male. Avevano chiamato i secondini, ma quelli avevano staccato il campanello d'emergenza e completamente ignorato la cosa. La madre di un altro era morta il giorno prima. Gli era stato tuttavia negato il permesso di partecipare al funerale, com'era capitato a tutti quelli che, prima di lui, si erano trovati nella sua stessa dolorosa situazione.
Mi alzai in piedi sul materasso e guardai fuori dalla finestra. Il filo spinato era coperto da uno spesso strato di ghiaccio, che mi ricordò l'interno di un frigorifero.
Sentii alcuni ragazzi augurarsi la buonanotte. Altri dicevano che avrebbero cercato di camminare il più a lungo possibile, perché i loro materassi erano ancora bagnati fradici. Solo pochi rimasero a parlare alle finestre.
Seán picchiò sul muro. «"Oíche mhaith" (19),` Bobby.»
«"Oíche mhaith", Seán,» gli risposi, e aggiunsi: «Il tuo materasso è bagnato?».
«Solo un po',» disse. «Cercherò di scaldarmi sotto le coperte.»
«"Maith thú. Oíche mhaith, a chara" (20),» gli augurai.
«"Oíche mhaith",» mi gridò ancora.
*
La neve non cadeva più e soffiava solo un vento leggero. Il manto di neve, prima soffice e immacolato, portava ora i segni delle impronte dei secondini. Le nuvole bianche e gonfie di neve avevano abbandonato il cielo, ora di nuovo nero come l'inchiostro. Qualche stella brillava qua e là. «A quest'ora la maggior parte della gente sta dormendo,» pensai. Mi chiedevo cosa avrebbero provato se, svegliandosi, avessero dovuto affrontare quel che aspettava noi il giorno seguente. Non c'era da meravigliarsi se nelle ultime due settimane avevo avuto parecchi incubi, tutti legati a quei gironi infernali. «Dio mio, quando finirà? E' proprio terribile se neppure il sonno mi permette di evadere,» pensai ancora.
Il silenzio era sceso sugli altri Blocchi. I ragazzi attardatisi alle finestre se ne erano ora allontanati, chi per cercare di dormire, chi per una veglia forzata, dovuta allo stato dei loro materassi. Tutto taceva. Fuori le luci multicolori continuavano a far scintillare la neve. Il silenzio era inquietante. Nell'oscurità sentii il verso di un chiurlo che volava via. Lontano, il faro di un elicottero vagante danzava nell'oceano nero del cielo.
Pensavo ai miei familiari. Sarebbero stati preoccupati a morte, fino alla prossima visita.
Era stata una giornata dura, ma non era forse così ogni giorno? Solo Dio sapeva cosa ci aspettava domani. A chi sarebbe capitata la sventura di fornire la propria carne martoriata alle celle di punizione? Chi sarebbe stato il bersaglio degli idranti? Chi picchiato a sangue e chi massacrato di botte durante un cambio di braccio? Domani non avremmo avuto altro che ulteriori torture, sofferenze, dolore, noia e paura.
L'oscurità, il freddo intenso, lo stomaco vuoto, le fetide tombe popolate da incubi, con le loro quattro mura che ci gridavano addosso... Ecco cosa attendeva domani centinaia di prigionieri di guerra repubblicani. Ma se il futuro non ci avrebbe riservato nient'altro che torture, era altrettanto vero che avremmo continuato a resistere e non avremmo mai ceduto. «E' dura. Molto, molto dura,» pensai, mentre mi sdraiavo sul materasso bagnato e mi avvolgevo addosso le coperte. «Ma un giorno la vittoria sarà nostra e mai più nessun uomo o donna d'Irlanda dovrà marcire in un buco d'inferno inglese.»
Faceva molto freddo. Mi girai su un lato e sistemai il mio prezioso pacchettino di tabacco sotto il materasso. Sentii che l'umidità stava attaccando i miei piedi. «Un giorno di meno alla vittoria,» pensai.
Avevo molta fame. Sembravo uno scheletro rispetto a quello che ero stato un tempo, ma questo non aveva importanza. L'unica cosa che importava era continuare a resistere. Mi girai di nuovo. Il freddo mi stava penetrando tutto. «Non c'è nulla nel loro intero arsenale militare che riesca ad annientare la resistenza di un prigioniero politico repubblicano che non vuole cedere,» pensai, ed era proprio vero. «Non possono e non potranno mai uccidere il nostro spirito.»
Mi rigirai ancora, tremando per il freddo. La neve entrò dalla finestra e si posò sulle mie coperte.
«"Tiocfaidh ár lá",» mi dissi. «" Tiocfaidh ár lá".»