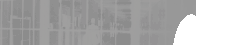La dolcezza delle pene (60).
L'arte di punire deve dunque riposare su tutta una tecnologia della rappresentazione. L'impresa non può riuscire se non quando si inscriva in una meccanica naturale. «Simile alla gravitazione dei corpi, una forza segreta ci spinge sempre verso il nostro benessere. Questo impulso non è ostacolato altro che dalle leggi che vi si oppongono. Tutte le diverse azioni dell'uomo sono gli effetti di questa tendenza interiore». Trovare per un delitto il castigo che gli conviene, è trovare lo svantaggio di cui l'idea sia tale da rendere definitivamente priva di attrazione l'idea di un misfatto. Arte di energie che si combattono, arte di immagini che si associano, fabbricazione di legami stabili che sfidino il tempo: si tratta di costituire coppie di rappresentazione con valori opposti, di instaurare differenze quantitative tra le forze in presenza, di stabilire un gioco segni-ostacoli che possa sottomettere il movimento delle forze ad un rapporto di potere. «Che la idea del supplizio sia sempre presente nel cuore dell'uomo debole e domini il sentimento che lo spinge al delitto» (61). Questi segni-ostacoli devono costituire il nuovo arsenale delle pene, come i marchi-vendetta organizzavano gli antichi supplizi. Ma, per funzionare, essi devono obbedire a numerose condizioni.
1. Essere il meno arbitrari possibile. E' vero che è la società a definire, in funzione dei propri interessi, ciò che deve essere considerato delitto: quest'ultimo non è dunque cosa naturale. Ma se si vuole che la punizione possa, senza difficoltà, presentarsi allo spirito dal momento che si pensa al delitto, bisogna che dall'uno all'altra il legame sia il più immediato possibile: di rassomiglianza, di analogia, di prossimità. Bisogna dare «alla pena tutta la possibile conformità con la natura del delitto, affinché il timore di un castigo allontani lo spirito dalla strada dove lo conduceva la prospettiva di un crimine vantaggioso» (62). La punizione ideale sarà il trasparente del crimine che sanziona; così, per colui che la contempla, sarà infallibilmente il segno del delitto che essa castiga e per colui che si immagina il delitto, la sola idea del misfatto risveglierà il segno punitivo. Vantaggio per la stabilità del legame, vantaggio per il calcolo delle proporzioni tra delitto e castigo e per la lettura quantitativa degli interessi; vantaggio anche perché, prendendo la forma di una successione naturale, la punizione non appare come l'effetto arbitrario di un potere umano: «Trarre il delitto dal castigo è il mezzo migliore per proporzionare la punizione al crimine. Se questo è il trionfo della giustizia è anche il trionfo della libertà, perché allora le pene, non derivando più dalla volontà del legislatore, ma dalla natura delle cose, non mostrano più l'uomo fare violenza sull'uomo» (63). Nella punizione analogica, il potere che punisce si nasconde.
Pene che siano naturali per istituzione e che rappresentino nella loro forma il contenuto del crimine: i riformatori ne hanno proposto tutta una panoplia. Vermeil, ad esempio: coloro che abusano della libertà pubblica, saranno privati della loro; i diritti civili saranno tolti a coloro che hanno abusato dei benefici della legge e dei privilegi delle funzioni pubbliche; l'ammenda punirà la concussione e l'usura; la confisca punirà il furto; l'umiliazione i delitti di «vana gloria»; la morte, l'assassinio; il rogo, l'incendio. Quanto all'avvelenatore, «il boia gli presenterà una coppa, di cui gli getterà il liquido in faccia, per schiacciarlo con l'orrore del suo misfatto offrendogliene l'immagine» (64). Semplici fantasie? Forse. Ma il principio di una comunicazione simbolica è chiaramente formulato ancora da Le Peletier quando, nel 1791, presenta la nuova legislazione criminale: «Sono necessari rapporti esatti tra la natura del delitto e la natura della punizione»; colui che è stato feroce nel suo delitto, subirà dolori fisici; colui che sarà stato fannullone, sarà costretto a un lavoro pubblico; colui che sarà stato abbietto, subirà una pena infamante (65).
Malgrado crudeltà che richiamano da vicino i supplizi dell'"Ancien Régime", un tutt'altro meccanismo opera in queste pene analogiche. Non si oppone più l'atroce all'atroce in un duello di potere; non è più la simmetria della vendetta, è la trasparenza del segno rispetto a ciò che esso significa; si vuole, nel teatro dei castighi, stabilire un rapporto immediatamente intelleggibile ai sensi, che possa dar luogo ad un calcolo semplice. Una sorta di ragionevole estetica della pena. «Non è semplicemente nelle belle arti che si deve seguire fedelmente la natura; le istituzioni politiche, almeno quelle che hanno carattere di saggezza ed elementi di durata, sono fondate sulla natura» (66). Che il castigo discenda dal delitto, che la legge abbia l'aria di essere una necessità di cose e che il potere agisca mascherandosi sotto la forza dolce della natura.
2. Questo gioco di segni deve incidere sulla meccanica delle forze: diminuire il desiderio che rende attraente il delitto, accrescere l'interesse che fa sì che la pena sia temibile; invertire il rapporto delle intensità, fare in modo che la rappresentazione della pena e dei suoi svantaggi sia più viva di quella del crimine coi suoi piaceri. Tutta una meccanica, dunque, dell'interesse, del suo movimento, del modo in cui lo si rappresenta e della vivacità della rappresentazione. «Il legislatore deve essere un abile architetto che sappia nello stesso tempo impiegare tutte le forze che possono contribuire alla solidità dell'edificio e smorzare tutte quelle che potrebbero rovinarlo» (67).
Numerosi i mezzi. «Andare diritti alla fonte del male» (68). Spezzare la molla che anima la rappresentazione del delitto. Privare di forza l'interesse che l'ha fatto nascere. Dietro i delitti di vagabondaggio, c'è la pigrizia; questa, si deve combattere. «Non si riuscirà a nulla rinchiudendo i mendicanti entro prigioni infette, che sono piuttosto cloache», bisognerà costringerli a lavorare. «Utilizzarli, è il modo migliore di punirli» (69). Contro una malvagia passione, una buona abitudine; contro una forza, un'altra forza, ma si tratta di quella della sensibilità e della passione, non di quella del potere con le sue armi. «Non dobbiamo dedurre tutte le pene da quel principio così semplice così felice, e già noto, di sceglierle in ciò che vi è di più deprimente per la passione che ha condotto al crimine commesso?» (70).
Far giocare contro la passione la forza che ha portato verso il delitto. Dividere l'interesse, servirsene per rendere temibile la pena. Che il castigo lo irriti e lo ecciti, più di quanto l'errore non abbia potuto adularlo. Se l'orgoglio fa commettere un misfatto, che lo si ferisca, che lo si colpisca attraverso la punizione. L'efficacia delle pene infamanti è di poggiare sulla vanità che era alla radice del delitto. I fanatici si gloriano e delle loro opinioni e dei supplizi che sopportano per esse. Facciamo dunque giocare contro il fanatismo l'orgogliosa testardaggine che lo sostiene: «Schiacciarlo col ridicolo e con la vergogna; se umiliamo l'orgogliosa vanità dei fanatici davanti ad una grande folla di spettatori, ci si devono aspettare da questa pena felici effetti». Non servirebbe a niente, al contrario, imporre loro dei dolori fisici (71).
Rianimare un interesse utile e virtuoso, che il crimine prova essersi indebolito. Il sentimento del rispetto per la proprietà - quella delle ricchezze, ma anche quella dell'onore, della libertà, della vita - il malfattore l'ha perduto quando ruba, calunnia, rapisce o uccide. Bisogna dunque insegnarglielo di nuovo. E si comincerà ad insegnarglielo per lui stesso: gli si farà provare quello che è perdere la libera disposizione dei suoi beni, del suo onore, del suo tempo, del suo corpo, perché egli la rispetti a sua volta negli altri (72). La pena che crea segni stabili e facilmente leggibili deve anche ricomporre l'economia degli interessi e la dinamica delle passioni.
3. Utilità in conseguenza di una modulazione temporale. La pena trasforma, modifica, stabilisce dei segni, predispone degli ostacoli. Quale sarebbe la sua utilità se dovesse essere definitiva? Una pena che non avesse termine sarebbe contraddittoria: tutte le costrizioni che impone al condannato e di cui, ridivenuto virtuoso, non potrebbe mai profittare, non sarebbero più altro che supplizi; e lo sforzo fatto per riformarlo sarebbero pena e costo perduti da parte della società. Se esistono degli incorreggibili, bisogna risolversi ad eliminarli. Ma per tutti gli altri le pene non possono funzionare altro che a termine. Analisi accettata dai Costituenti: il Codice del 1791 prevede la morte per i traditori e gli assassini; tutte le altre pene devono avere un termine (il massimo è vent'anni).
Ma soprattutto il ruolo della durata deve essere integrato all'economia della pena. I supplizi nella loro violenza rischiavano di avere questo risultato: più il crimine era grave, meno il castigo era lungo. La durata, certamente, interveniva nell'antico sistema delle pene: giornate di gogna, anni di bando, ore passate a spirare sulla ruota. Ma era un tempo di prova, non di trasformazione concertata. La durata deve permettere ora l'azione peculiare del castigo: «Un susseguirsi prolungato di privazioni penose risparmiando all'umanità l'orrore delle torture, colpisce assai di più il colpevole che non un istante passeggero di dolore... Essa rinnova senza posa agli occhi del popolo che ne è testimone il ricordo di leggi vendicatrici e fa rivivere in ogni momento un terrore salutare» (73). Il tempo, operatore della pena.
Ora, la fragile meccanica delle passioni vuole che queste non vengano costrette né nello stesso modo, né con la stessa insistenza a misura che si correggono; è opportuno che la pena si attenui insieme agli effetti che produce. Può essere fissa, certamente, nel senso di essere determinata, per tutti e nello stesso modo, dalla legge; è il suo meccanismo interno che dev'essere variabile. Nel suo progetto alla Costituente, Le Peletier proponeva pene di intensità regressiva: un condannato alla pena più grave subirà la segreta (catene ai piedi e alle mani, oscurità, solitudine, pane e acqua) solo durante una prima fase; indi avrà la possibilità di lavorare due, poi tre giorni la settimana. Ai due terzi della pena, potrà passare al regime della «costrizione» (cella rischiarata, catena attorno alla vita, lavoro solitario cinque giorni la settimana, ma in comune gli altri due giorni; questo lavoro gli sarà pagato e gli permetterà di migliorare il suo vitto). Infine, quando si avvicinerà alla fine della condanna, potrà passare al regime della prigione: «Potrà riunirsi ogni giorno con gli altri prigionieri, per un lavoro comune» (74).
4. Dalla parte del condannato, la pena è una meccanica dei segni, degli interessi, della durata. Ma il colpevole non è che uno dei bersagli del castigo: questo riguarda soprattutto gli altri, i possibili colpevoli. Che questi segni-ostacoli che vengono incisi poco a poco nella rappresentazione del condannato, circolino dunque rapidamente e largamente; che siano accettati e ridistribuiti da tutti; che formino il discorso che ciascuno tiene a tutti gli altri e per mezzo del quale tutti si proibiscono il delitto - la buona moneta che si sostituisce, negli spiriti, al falso profitto del crimine.
Per ottenere questo, è necessario che il castigo sia considerato non solo naturale, ma conveniente; bisogna che ciascuno possa leggervi il proprio vantaggio. Non più quelle pene clamorose, ma inutili. Non più, neppure, pene segrete; ma che i castighi vengano considerati come una retribuzione data dal colpevole a ciascuno dei suoi concittadini per il delitto che li ha tutti lesi: pene «che si presentino senza posa agli occhi dei cittadini» e che facciano «risaltare l'utilità pubblica di movimenti comuni e individuali» (77). L'ideale sarebbe che il condannato apparisse come una sorta di proprietà redditizia: uno schiavo messo al servizio di tutti. Perché la società dovrebbe sopprimere una vita e un corpo di cui potrebbe appropriarsi? Sarebbe più utile farlo «servire lo Stato in una schiavitù che sarebbe più o meno estesa secondo la natura del delitto»; la Francia ha fin troppe strade impraticabili che danneggiano il commercio: i ladri, che anch'essi ostacolano la libera circolazione delle merci, non dovranno far altro che ricostruire le strade. Più della morte, sarebbe eloquente «l'esempio, sempre sotto gli occhi, di un uomo al quale sia stata tolta la libertà e che sia obbligato ad impiegare il resto della sua vita a riparare il danno causato alla società» (76).
Nell'antico sistema, il corpo del condannato diveniva cosa del re, sulla quale il sovrano imprimeva il proprio marchio e abbatteva gli effetti del proprio potere. Ora diverrà piuttosto bene sociale, oggetto di una appropriazione collettiva ed utile. Di qui il fatto che i riformatori hanno quasi sempre proposto i lavori pubblici come una delle migliori pene possibili. I "Cahiers de doléance" li hanno d'altronde seguiti: «Che i condannati a qualunque pena al disotto della morte, lo siano ai lavori pubblici del paese, per un tempo proporzionato al loro delitto» (77). E lavori pubblici significava due cose: interesse collettivo alla pena del condannato e carattere visibile, controllabile del castigo. Il colpevole paga due volte: col lavoro che fornisce e coi segni che produce. Nel cuore della società, sulle piazze pubbliche o sulle grandi strade, il condannato è sorgente di profitti e di significazioni. Visibilmente, serve ad ognuno, ma, nello stesso tempo, fa scivolare nello spirito di tutti il segno delitto-castigo: utilità secondaria, puramente morale, questa, ma quanto più reale.
5. Di qui tutta una sapiente economia della pubblicità. Nel supplizio corporale, il terrore era il supporto dell'esempio: terrore fisico, spavento collettivo, immagini che devono stamparsi nella memoria degli spettatori come il marchio sulla guancia o sulla spalla del condannato. Il supporto dell'esempio, ora, è la lezione, il discorso, il segno decifrabile, la messa in scena della moralità pubblica. Non è più la restaurazione terrificante della sovranità a sostenere la cerimonia del castigo, è la riattivazione del Codice, il rafforzamento collettivo del legame tra l'idea del crimine e l'idea della pena. Nella punizione, piuttosto che vedere la presenza del sovrano, si leggeranno le leggi stesse. Queste avevano associato a un certo delitto un certo castigo. Non appena commesso il delitto e senza perdere tempo, verrà la punizione, ponendo in atto il discorso della legge e mostrando che il Codice, che collega le idee, collega anche le realtà. La congiunzione, immediata nel testo, deve esserlo anche negli atti. «Considerate quei primi momenti, in cui la notizia di un'azione atroce si diffonde nelle nostre città e nelle nostre campagne; i cittadini assomigliano a uomini che vedono il fulmine cadere presso di loro; ognuno è penetrato di indignazione e di orrore... Ecco il momento di castigare il delitto: non lo lasciate scappare; affrettatevi all'istruzione e al giudizio. Rizzate i patiboli, i roghi, trascinate il colpevole sulle piazze pubbliche, chiamate a gran voce il popolo. Voi lo sentirete allora applaudire la proclamazione dei vostri giudizi, come a quella della pace e della libertà, lo vedrete accorrere a quei terribili spettacoli come al trionfo delle leggi» (78). La punizione pubblica è la cerimonia della ricodificazione immediata.
La legge si ristabilisce e viene a riprendere posto accanto al misfatto che l'aveva violata. Al contrario, il malfattore viene distaccato dalla società. La lascia. Ma non in quelle ambigue feste dell'"Ancien Régime", in cui il popolo fatalmente si prendeva una sua parte o del crimine o dell'esecuzione, ma in una cerimonia di lutto. La società che ha ritrovato le sue leggi, ha perduto quel cittadino che le aveva violate. La punizione pubblica deve mostrare questa duplice afflizione: che si sia potuto ignorare la legge, e che si sia obbligati a separarsi da un cittadino. «Legate al supplizio il più lugubre e il più commovente degli apparati; che questo giorno terribile sia per la patria un giorno di lutto; che il dolore generale si ammanti ovunque di aspetti sontuosi... Che il magistrato coperto di crespi funerei annunci al popolo l'attentato e la triste necessità di una vendetta legale. Che le scene di questa tragedia colpiscano tutti i sensi, muovano tutte le affezioni dolci e oneste» (79).
Lutto il cui senso deve essere chiaro per tutti; ogni elemento del suo rituale deve parlare, descrivere il crimine, ricordare la legge, mostrare la necessità della punizione, giustificarne la misura. Manifesti, scritte, simboli, devono essere moltiplicati, perché ciascuno possa apprendere le significazioni. La pubblicità della punizione non deve diffondere un effetto fisico di terrore; deve aprire un libro di lettura. Le Peletier proponeva che il popolo una volta al mese potesse visitare i condannati «nel loro penoso ritiro: leggerà, tracciato a grandi caratteri sopra la porta della cella, il nome del colpevole, il delitto e il giudizio» (80). E nello stile "na�f" e militare delle cerimonie imperiali, Bexon immaginerà, qualche anno più tardi, tutto un quadro di segni araldici penali: «Il condannato a morte sarà condotto al patibolo in una vettura 'coperta o dipinta di nero intercalato al rosso'; se ha tradito ci sarà una camicia rossa sulla quale sarà scritto 'traditore'; se è parricida, avrà la testa coperta da un velo nero e sulla sua camicia saranno ricamati dei pugnali o gli strumenti di morte di cui si sarà servito; se ha avvelenato, la sua camicia rossa sarà ornata di serpenti e di altri animali velenosi» (81).
Lezione leggibile, ricodificazione rituale; bisogna ripeterle il più spesso possibile perché i castighi siano una scuola piuttosto che una festa; un libro sempre aperto piuttosto che una cerimonia. La durata che rende il castigo efficace per il colpevole, è utile anche per gli spettatori. Essi devono poter consultare ad ogni istante il lessico permanente del delitto e del castigo. Pena segreta, pena a metà perduta. Sarà necessario che i bambini possano andare nei luoghi in cui essa viene eseguita; vi apprenderanno lezioni di civismo. E gli uomini fatti vi riapprenderanno periodicamente le leggi. Concepiamo i luoghi di castigo come un Giardino delle Leggi, che le famiglie visiteranno la domenica. «Vorrei che di tanto in tanto, dopo aver preparato gli spiriti con un discorso ragionato sulla conservazione dell'ordine sociale, sull'utilità dei castighi, si conducessero i giovani, e gli uomini anche, alle miniere, ai lavori forzati, per contemplare la sorte terribile dei proscritti. Questi pellegrinaggi sarebbero più utili di quelli che fanno i turchi alla Mecca» (82). E Le Peletier riteneva che la visibilità dei castighi fosse uno dei principi fondamentali del nuovo Codice penale: «Spesso, a tempi determinati, la presenza del popolo deve portare vergogna sulla fronte del colpevole; come la presenza del colpevole nello stato penoso in cui l'ha ridotto il delitto deve apportare nell'anima del popolo un'utile istruzione» (83). Assai prima d'esser concepito come un oggetto di scienza, il criminale è intravisto come elemento di istruzione. Dopo la visita della carità, per condividere le sofferenze dei prigionieri - il secolo Diciassettesimo l'aveva inventata o ripresa - si sognò di queste visite di bambini venuti ad imparare come il beneficio della legge si applica al crimine; vivente lezione al museo dell'ordine.
6. Allora potrà invertirsi nella società il tradizionale discorso del crimine. Grave preoccupazione per gli autori di leggi nel secolo Diciottesimo: come estinguere la dubbia gloria dei criminali? Come far tacere l'epopea dei grandi malfattori cantati dagli almanacchi, dai fogli volanti, dai racconti popolari? Se la ricodificazione punitiva è ben fatta, se la cerimonia del lutto si svolge opportunamente, il crimine non potrà più apparire altro che una disgrazia e il malfattore un nemico cui riinsegnare la vita sociale. In luogo di quelle lodi che eroicizzano il criminale, non circoleranno più nei discorsi degli uomini che quei segni-ostacoli che arrestano il desiderio del crimine col calcolato timore del castigo. La meccanica positiva giocherà nel linguaggio di tutti i giorni e sarà fortificata senza posa da nuovi racconti. Il discorso diventerà il veicolo della legge: principio costante di ricodificazione universale. I poeti del popolo si riuniranno finalmente a coloro che si definiscono i «missionari dell'eterna ragione»; si faranno moralisti. «Pieno di queste terribili immagini e di queste idee salutari, ogni cittadino le diffonderà nella sua famiglia, e là, con lunghi racconti fatti con altrettanto calore quanto avidamente ascoltati, i figli riuniti attorno a lui apriranno la loro giovane memoria per ricevere, a tratti inalterabili, l'idea del delitto e del castigo, l'amore delle leggi e della patria, il rispetto e la confidenza per la magistratura. Gli abitanti delle campagne, anch'essi testimoni di questi esempi, li semineranno attorno alle loro casupole, il gusto della virtù si radicherà in quelle anime grossolane mentre il cattivo, costernato della pubblica gioia, atterrito di trovarsi tanti nemici, rinuncerà forse a dei progetti il cui sbocco non è meno pronto che funesto» (84).
Ecco dunque come bisogna immaginare la città punitiva. Agli incroci, nei giardini, sui bordi delle strade che vengono rifatte o dei ponti che vengono costruiti, nei laboratori aperti a tutti, nel fondo delle miniere che si vanno a visitare; mille piccoli teatri di castighi. Ad ogni crimine, la sua legge; ad ogni criminale la sua pena. Pena visibile, pena loquace, che dice tutto, che spiega, si giustifica, convince: cartelli, berretti, affissi, manifesti, simboli, testi letti o stampati, tutto ripete instancabilmente il Codice. Scenografie, prospettive, effetti ottici, "trompe-l'oeil", dilatano talvolta la scena, la rendono più temibile di quanto non sia, ma anche più chiara. Da dove si trova il pubblico, possono apparire talune crudeltà che, di fatto, non hanno luogo. Essenziale, per queste severità reali o amplificate, è, secondo una rigorosa economia, impartire lezioni: che ogni castigo sia un apologo. E, contrappunto di tutti gli esempi diretti di virtù, che si possano in ogni istante incontrare, come una scena vivente, le disgrazie del vizio. Attorno ad ognuna di queste «rappresentazioni»morali, gli scolari si affolleranno coi loro maestri e gli adulti impareranno le lezioni da impartire ai loro figli. Non più il grande rituale terrificante dei supplizi, ma, lungo il filo dei giorni e delle strade, un teatro severo, con scene multiple e persuasive. E la memoria popolare riprodurrà nei suoi discorsi il discorso austero della legge. Ma forse sarà necessario, al di sopra di questi mille spettacoli e racconti, porre il segno massimo della punizione per il più terribile dei crimini: la chiave di volta dell'edificio penale. Vermeil, in ogni caso, aveva immaginato la scena della punizione assoluta, che doveva dominare tutti i teatri del castigo quotidiano: il solo caso in cui si dovesse cercare di raggiungere l'infinito punitivo. Un po' l'equivalente, nella nuova penalità, di quello che era stato il regicidio nell'antica. Il colpevole avrebbe avuto gli occhi trafitti; lo si sarebbe messo in una gabbia di ferro, sospesa in aria, in una piazza pubblica, completamente nudo, una cintura di ferro intorno alla vita, attaccato alle sbarre; fino alla fine dei suoi giorni, lo si sarebbe nutrito di pane e acqua. «Egli sarebbe così esposto a tutti i rigori delle stagioni, talvolta il capo coperto di neve, talvolta calcinato dal sole cocente. E' in questo supplizio energico, rappresentante piuttosto il prolungamento di una morte dolorosa che non quello di una vita penosa, che si potrebbe veramente riconoscere uno scellerato votato all'orrore dell'intera natura, condannato a non più vedere il cielo ch'egli ha oltraggiato e a non più abitare la terra che egli ha insozzato» (85). Al di sopra della città punitiva, questa ragnatela di ferro; e colui che la nuova legge deve così crocifiggere è il parricida.
Tutto un arsenale di castighi pittoreschi. «Guardatevi dall'infliggere sempre le stesse punizioni», diceva Mably. Bandita l'idea di una pena uniforme, modulata solo dalla gravità della colpa. Più precisamente: l'utilizzazione della prigione come forma generale di castigo non viene mai presentata in questi progetti di pene specifiche, visibili e parlanti. Senza dubbio, la prigione è prevista, ma framezzo ad altre pene, ed è allora il castigo specifico di certi delitti, quelli che attentano alla libertà dell'individuo, come il ratto, o quelli che nascono dall'abuso della libertà, come il disordine, la violenza. Ma non ricopre tutto il campo della penalità, avendo la durata come solo principio di variazione. Meglio, l'idea della carcerazione penale è esplicitamente criticata da molti riformatori. Perché è incapace di rispondere alla specificità dei delitti. Perché è sprovvista di effetti sul pubblico. Perché è inutile alla società, anzi, nociva: è costosa, mantiene i condannati nell'ozio, moltiplica i loro vizi (86). Perché il compimento di una tale pena è difficile da controllare e si rischia di esporre i detenuti all'arbitrio dei guardiani. Perché il mestiere di privare un uomo della libertà e di sorvegliarlo in prigione è un esercizio di tirannia. «Voi esigete che ci siano fra voi dei mostri; e questi uomini odiosi, se esistessero, dovrebbero forse essere trattati dal legislatore come assassini» (87). La prigione, nell'insieme, è incompatibile con tutta la tecnica della pena-effetto, della pena-rappresentazione, della pena-funzione generale, della pena-segno e discorso. Esso è l'oscurità, la violenza, il sospetto. «E' un luogo di tenebre, dove l'occhio del cittadino non può contare le vittime, dove di conseguenza il loro numero è inutile all'esempio... Mentre quando, senza moltiplicare i delitti, si può moltiplicare l'esempio dei castighi, si perviene alla fine a renderli meno necessari; d'altronde la oscurità delle prigioni diviene un soggetto di diffidenza per i cittadini. Essi facilmente suppongono che vi si commettano grandi ingiustizie... C'è sicuramente qualcosa che va male quando la legge, che è fatta per il bene della moltitudine, in luogo di suscitarne la riconoscenza ne eccita continuamente i mormorii» (88).
Che la carcerazione possa, come oggi, ricoprire, tra la morte e le pene leggere, tutto lo spazio mediano della punizione, è un'idea che i riformatori non potevano avere immediatamente.
Ora, ecco il problema: in pochissimo tempo, la detenzione è divenuta la forma essenziale del castigo. Nel Codice penale del 1810, tra la morte e le ammende, essa occupa, sotto un certo numero di forme, quasi tutto il campo delle possibili punizioni. «Qual è il sistema di pene ammesso dalla nuova legge? E' la carcerazione sotto tutte le forme. Paragonate infatti le quattro pene principali che restano nel Codice penale. I lavori forzati sono una forma di carcerazione. Il bagno è una prigione all'aria aperta. La detenzione, la reclusione, l'incarceramento correzionale non sono, in qualche modo, che i nomi diversi di un solo e medesimo castigo» (89). E questo imprigionamento, voluto dalla legge, l'Impero aveva presto deciso di trascriverlo nella realtà, secondo tutta una gerarchia penale, amministrativa, geografica; al grado più basso, associate ad ogni corte di pace, stabilimenti di polizia municipale; in ogni distretto, gli stabilimenti per l'arresto; in tutti i dipartimenti, una casa di correzione; al sommo, numerosi stabilimenti centrali per i condannati ai delitti maggiori o per quelli dei tribunali correzionali per condanne a più di un anno; infine, in qualche porto, i bagni. Viene programmata una grande struttura carceraria, di cui i differenti livelli devono adattarsi esattamente ai livelli della centralizzazione amministrativa. Al patibolo, dove il corpo del suppliziato era esposto alla forza ritualmente espressa del sovrano, al teatro punitivo dove la rappresentazione del castigo sarebbe stata offerta in permanenza al corpo sociale, si era sostituita una grande architettura chiusa, complessa e gerarchizzata che si integra al corpo stesso del meccanismo statale. Una tutt'altra materialità, una tutt'altra fisica del potere, una tutt'altra maniera di investire il corpo umano. A partire dalla Restaurazione e sotto la monarchia di Luglio, saranno, con modesti scarti, da 40 a 43000 i detenuti nelle carceri francesi (circa un prigioniero ogni 600 abitanti). L'alto muro, non più quello che circonda e protegge, non più quello che manifesta, col suo prestigio, la potenza e la ricchezza, ma il muro accuratamente chiuso, invalicabile in un senso e nell'altro, che cela il lavoro, divenuto misterioso, della punizione, sarà, molto presto, e talvolta nel centro delle città del secolo Diciannovesimo, la figura monotona, materiale e simbolica insieme, del potere di punire. Già sotto il Consolato, il ministro dell'Interno aveva incaricato di indagare sui differenti luoghi di sicurezza già funzionanti o che avrebbero potuto essere utilizzati nelle diverse città. Qualche anno più tardi erano stati previsti dei crediti per costruire, all'altezza del potere che dovevano rappresentare e servire, questi nuovi castelli dell'ordine civile. L'Impero li utilizzò, in effetti, per un'altra guerra (90). Una economia meno suntuaria, ma più ostinata, finisce per costruirli, poco a poco, nel secolo Diciannovesimo.
In meno di vent'anni, in ogni modo, il principio, così chiaramente formulato alla Costituente, delle pene scientifiche, adeguate, efficaci, che siano, in ciascun caso, lezione per tutti, è divenuto il principio della detenzione per ogni infrazione importante, quando non merita la morte. A quel teatro punitivo, sognato nel secolo Diciottesimo, e che avrebbe giocato essenzialmente sullo spirito dei giustiziandi, si è sostituito il grande apparato uniforme delle prigioni, la cui rete di immensi edifici sta per estendersi su tutta la Francia e l'Europa. Ma attribuire vent'anni di cronologia a questo rivolgimento è, forse, ancora troppo. Possiamo dire che è stato quasi istantaneo. Basta guardare più da vicino il progetto di Codice criminale presentato da Le Peletier alla Costituente. Il principio formulato all'inizio è che sono necessari «rapporti esatti tra la natura del delitto e la natura della punizione»; dolori per coloro che sono stati feroci, lavoro per coloro che sono stati pigri, infamia per coloro la cui anima è degradata. Ora, le pene afflittive effettivamente proposte, sono tre forme di detenzione: la segreta dove la pena detentiva è aggravata da diverse misure (concernenti la solitudine, la privazione della luce, le restrizioni del vitto), la "g�ne", in cui le misure annesse sono attenuate; infine, la prigione propriamente detta consistente nella pura e semplice reclusione. La diversità, così solennemente promessa, si è alla fine ridotta a questa penalità uniforme e grigia. Ci furono d'altronde, sul momento, dei deputati che si stupirono che in luogo di stabilire un rapporto naturale tra delitti e pene, fosse stato seguito un tutt'altro indirizzo: «In modo che, se ho tradito il mio paese mi si imprigiona; se ho ucciso mio padre, mi si imprigiona; tutti i delitti immaginabili vengono puniti nel più uniforme dei modi. Mi sembra di vedere un medico che per tutte le malattie usa lo stesso rimedio» (91).
Pronta sostituzione che non fu privilegio della Francia. La ritroviamo, uguale, in altri paesi. Quando Caterina Seconda, negli anni che seguono immediatamente il trattato "Dei delitti e delle pene", fa redigere un progetto «per un nuovo codice di leggi», la lezione di Beccaria sulla specificità e la varietà delle pene, non viene dimenticata, anzi è ripresa quasi parola per parola: «E' il trionfo della libertà civile, allorché le leggi criminali derivano ogni pena dalla natura particolare di ciascun delitto. Allora tutto l'arbitrio cessa; la pena non dipende più dal capriccio del legislatore, ma dalla natura della cosa; non è minimamente l'uomo che fa violenza sull'uomo, ma la stessa azione dell'uomo» (92). Qualche anno più tardi, sono proprio sempre i principi generali di Beccaria a servire di fondamento al nuovo codice toscano ed a quello dato da Giuseppe Secondo all'Austria; e tuttavia queste due legislazioni fanno dell'imprigionamento - modulato secondo la durata e aggravato in certi casi dal marchio o dai ferri - una pena quasi uniforme: trent'anni almeno di detenzione per attentato contro il sovrano, per moneta falsa e per assassinio aggravato da furto; da quindici a trent'anni per omicidio volontario o per furto a mano armata; da un mese a cinque anni, per furto semplice, eccetera (93).
Ma se questa colonizzazione delle pene da parte della prigione aveva di che sorprendere, è perché essa non era, come noi immaginiamo, un castigo già solidamente installato nel sistema penale, proprio al di sotto della pena di morte, e che, in modo assolutamente naturale, avrebbe occupato il posto lasciato vuoto dalla sparizione dei supplizi. In realtà la prigione - e su questo punto molti paesi erano nella stessa situazione della Francia - non aveva che una posizione ristretta e marginale nel sistema delle pene. I testi lo provano. L'ordinanza del 1670, tra le pene afflittive, non cita la detenzione. Senza dubbio, la prigione perpetua o temporanea aveva figurato in alcuni diritti consuetudinari (94); ma sappiamo che essa cade in desuetudine come altri supplizi: «Esistevano un tempo delle pene che non si praticano più in Francia, come scrivere sul viso o sulla fronte del condannato la sua pena, e la prigione perpetua; e così pure non si deve condannare un criminale né ad essere esposto alle bestie feroci, né alle miniere» (95). Nella realtà, è certo che la prigione era stata conservata tenacemente, per sanzionare gli errori poco gravi, a discrezione delle consuetudini o delle abitudini locali. In questo senso Soulatges parlava di «pene leggere», che l'ordinanza del 1670 non aveva menzionato: il biasimo, l'ammonizione, l'interdizione di un luogo, la soddisfazione alla persona offesa e la prigione a tempo. In alcune regioni, soprattutto quelle che avevano meglio conservato il particolarismo giuridico, la pena della prigione aveva ancora grande estensione, ma la cosa presentava alcune difficoltà, come nel Roussillon, di recente annesso.
Ma attraverso queste divergenze, i giuristi si attengono fermamente al principio che «la prigione non viene riguardata come una pena nel nostro diritto civile» (96). Il suo ruolo è di costituire una presa di garanzia sulla persona e sul corpo suo: "ad continendos homines, non ad puniendos", dice l'adagio; in questo senso l'imprigionamento di un sospetto ha un po' lo stesso ruolo di quello di un debitore. Con la prigione ci si assicura di qualcuno, non lo si punisce (97). Tale è il principio generale. E se la prigione talvolta gioca il ruolo di pena, e in casi importanti, è essenzialmente a titolo sostitutivo: sostituisce la galera per coloro - donne, bambini, invalidi - che non vi possono servire: «La condanna ad essere rinchiusi a tempo o per sempre in una casa di forza è equivalente a quella delle galere» (98). In questa equivalenza, vediamo chiaramente disegnarsi una possibile sostituzione. Ma perché essa avvenga, è stato necessario che la prigione mutasse di "status" giuridico.
Ed è stato anche necessario che fosse sormontato un secondo ostacolo, che, almeno per la Francia, era considerevole. La prigione, in effetti, era tanto più squalificata in quanto era, in pratica, direttamente legata all'arbitrio reale ed agli eccessi del potere sovrano. Le «case di forza», gli ospizi generali, gli «ordini del re» o quelli del luogotenente di polizia, le "lettres de cachet" ottenute dai notabili o dalle famiglie, avevano costituito tutta una tecnica repressiva, sovrapposta alla «giustizia regolare» e più spesso ancora opposta ad essa. E questa detenzione extragiudiziaria si trovava ad essere respinta altrettanto decisamente sia dai giuristi classici che dai riformatori. Prigione, fatto del principe, diceva un tradizionalista come Serpillon che si riparava dietro l'autorità del presidente Berthier: «Benché i principi per ragioni di Stato si determinino talvolta ad infliggere questa pena, la giustizia ordinaria non fa uso di questa sorta di condanna» (99). Detenzione, figura e strumento privilegiato del dispotismo, dicono i riformatori, in innumerevoli declamazioni: «Cosa diremo di quelle prigioni segrete immaginate dallo spirito fatale del monarchismo, riservate principalmente o ai filosofi, nelle cui mani la natura ha messo la sua fiaccola e che osano rischiarare il loro secolo, o a quelle anime fiere e indipendenti che non hanno la vigliaccheria di tacere i mali della loro patria; prigioni, di cui misteriose lettere aprono le porte funeste per seppellirvi per sempre le infelici vittime? Cosa diremo anche di queste lettere, capolavori di un'ingeniosa tirannia, che rovesciano il privilegio che ogni cittadino ha di essere sentito prima di essere giudicato e che sono mille volte più pericolose per gli uomini che non l'invenzione di Falaride...» (100).
Senza dubbio queste proteste, venute da orizzonti così diversi non concernono la prigione come pena legale, ma la utilizzazione «fuori-legge» della detenzione arbitraria e indeterminata. Resta tuttavia che la prigione appariva, in linea generale, come segnata dall'abuso di potere. E molti "cahiers de doléances" la rifiutano come incompatibile con una buona giustizia. Talvolta in nome dei principi classici: «Le prigioni, nell'intenzione della legge, essendo destinate non a punire, ma ad assicurarsi delle loro persone...» (101). Talvolta in nome degli effetti della prigione che punisce coloro che non sono ancora condannati, che comunica e generalizza il male che dovrebbe prevenire, e che va contro il principio dell'individualità delle pene sanzionando un'intera famiglia; si dice che «la prigione non è una pena. L'umanità si rivolta contro questo terribile pensiero che non sia punizione privare un cittadino del più prezioso dei beni, immergerlo ignominiosamente nel soggiorno del crimine, strapparlo a tutto ciò che ha di caro, precipitarlo forse nella rovina e di togliere non solo a lui ma alla sua disgraziata famiglia ogni mezzo di sussistenza». Ed i "cahiers", in numerose riprese, chiedono la soppressione delle case di internamento: «Noi crediamo che le case di forza debbano essere distrutte...» (103). E in effetti il decreto del 13 marzo 1790 ordina che si rimettano in libertà «tutte le persone detenute nei castelli, case religiose, case di polizia od altre prigioni qualsiasi a causa di "lettres de cachet" o per ordine di agenti del potere esecutivo».
In qual modo la detenzione, così visibilmente legata a quell'illegalismo denunciato perfino nel potere del principe, ha potuto, e in così poco tempo, divenire una delle forme più generali dei castighi legali?
La spiegazione data più spesso è il costituirsi, durante l'età classica, di alcuni grandi modelli di carcerazione punitiva. E loro prestigio, tanto più grande in quanto i più recenti provenivano dall'Inghilterra e soprattutto dall'America, avrebbe permesso di sormontare il doppio ostacolo costituito dalle regole secolari del diritto e dal funzionamento dispotico della prigione. Assai presto, essi avrebbero spazzato via le meraviglie punitive immaginate dai riformatori e imposto la realtà severa della detenzione. Non c'è da dubitare della grande importanza dei nuovi modelli. Ma sono proprio questi che, ancor prima di fornire la soluzione, pongono i problemi: quello della loro esistenza e quello della loro diffusione. Come sono potuti nascere e soprattutto come hanno potuto essere accettati in modo così generale? Poiché è facile dimostrare che se presentano coi principi generali della riforma penale un certo numero di conformità, ne sono, in molti punti, del tutto eterogenei e talvolta perfino incompatibili.
Il più antico di questi modelli, quello che passa per aver ispirato, da vicino o da lontano, tutti gli altri è il Rasphuis di Amsterdam, aperto nel 1596 (104), in teoria destinato a mendicanti o giovani malfattori. Il suo funzionamento obbediva a tre grandi principi: la durata delle pene poteva, almeno entro certi limiti, esser determinata dalla stessa amministrazione, secondo la condotta del prigioniero (questa latitudine poteva d'altronde essere prevista dalla sentenza: nel 1597 un detenuto era stato condannato a dodici anni di prigione, che avrebbero potuto essere ridotti ad otto, se il suo comportamento avesse dato soddisfazione). Il lavoro era obbligatorio e si faceva in comune (la cella individuale non era utilizzata che a titolo di punizione supplementare; i detenuti dormivano a due o tre per letto, in celle che contenevano da quattro a dodici persone) e per il lavoro fatto i prigionieri ricevevano un salario. Infine uno stretto impiego del tempo, un sistema di divieti e di obblighi, una sorveglianza continua, esortazioni, letture spirituali; tutto un gioco di mezzi per «attirare verso il bene» e «distogliere dal male», inquadrava i detenuti lungo tutta la giornata. Possiamo prendere il Rasphuis di Amsterdam come figura di base. Storicamente costituisce il legame tra la teoria, caratteristica del secolo Sedicesimo, di una trasformazione pedagogica e spirituale degli individui per mezzo di un esercizio continuo, e le tecniche penitenziarie ideate nella seconda metà del secolo Diciottesimo. Esso conferì alle tre istituzioni che furono allora attuate i principi fondamentali, e ciascuna di esse li svilupperà in una direzione particolare.
La casa di forza di Gand organizzò il lavoro penale soprattutto intorno ad imperativi economici. La ragione data è che l'ozio è la causa generale della maggior parte dei crimini. Una inchiesta - una delle prime senza dubbio - fatta sui condannati nella giurisdizione di Alost, nel 1794, mostra che i malfattori non erano «artigiani o contadini (i lavoratori pensano unicamente al lavoro che li nutre) ma dei fannulloni votati alla mendicità» (105). Di qui, l'idea di una casa che avrebbe assicurato, in qualche modo, la pedagogia universale del lavoro a coloro che vi si mostrassero refrattari. Quattro vantaggi: diminuire il numero delle istruttorie penali, che sono costose per lo Stato (in Fiandra si sarebbero così potute economizzare 100000 lire); non essere costretti a condoni d'imposta ai proprietari dei boschi rovinati dai vagabondi; formare gruppi di nuovi lavoratori, il che «contribuirebbe, facendo concorrenza, a diminuire la manodopera», infine permettere ai veri poveri di beneficiare della necessaria carità (106). Pedagogia utile che ricostituirà nel soggetto pigro il gusto del lavoro, lo riimmetterà di forza in un sistema di interessi in cui il lavoro è più vantaggioso della pigrizia, formerà intorno a lui una piccola società ridotta semplificata e coercitiva in cui apparirà chiaramente la massima: chi vuol vivere deve lavorare. Obbligo del lavoro, ma anche retribuzione che permette al detenuto di migliorare la sua sorte durante e dopo la detenzione. «L'uomo che non possiede mezzi di sussistenza deve assolutamente volgersi al desiderio di procurarseli col lavoro; gliela si offre coi regolamenti dello Stato e la disciplina; lo si forza, in qualche modo, a dedicarvisi; l'esca del guadagno lo eccita in seguito; corretto nei costumi, abituato a lavorare, nutrito senza preoccupazione, con qualche profitto che serba per la sua uscita», egli ha appreso un mestiere «che gli assicura una sussistenza senza pericolo» (107). Ricostituzione dell'"homo oeconomicus", che esclude l'uso di pene troppo brevi - il che impedirebbe l'acquisizione delle tecniche e del gusto del lavoro, o definitive - il che renderebbe inutile ogni apprendistato. «Il termine di sei mesi è troppo breve per correggere i criminali e portarli allo spirito del lavoro»; al contrario «il termine della vita li porta alla disperazione; essi sono indifferenti alla correzione dei costumi e allo spirito del lavoro; non sono occupati che da progetti di evasione e di rivolta; e poiché non è stato giudicato opportuno di privarli della vita, perché si cercherebbe di renderla loro insopportabile?» (108). La durata della pena ha senso solo rispetto ad una possibile correzione e utilizzazione sociale dei criminali corretti.
Al principio del lavoro, il modello inglese aggiunge, come condizione essenziale della correzione, l'isolamento. Lo schema era stato dato nel 1775 da Hanway, che lo giustificava prima di tutto con ragioni negative: la promiscuità nelle prigioni fornisce cattivi esempi e possibilità di evasione nell'immediato presente, di ricatti o di complicità nell'avvenire. La prigione assomiglierebbe troppo ad una manifattura se si lasciassero i condannati lavorare insieme. Seguono le ragioni positive: l'isolamento costituisce uno «choc terribile» e partendo da esso il condannato, sfuggendo alle cattive influenze, può fare un ritorno in se stesso e riscoprire nel fondo della coscienza la voce del bene; il lavoro solitario diverrà allora un esercizio tanto di conversione che di apprendimento; egli non riformerà semplicemente solo il gioco di interessi proprio all'"homo oeconomicus", ma anche gli imperativi del soggetto morale. La cella, questa tecnica del monachesimo cristiano e che esisteva oramai solo nei paesi cattolici, diviene in questa società protestante lo strumento con cui si può ricostruire insieme l'"homo oeconomicus" e la coscienza religiosa. Tra il crimine ed il ritorno al diritto e alla virtù, la prigione costituirà uno «spazio fra due mondi», un luogo per le trasformazioni individuali che restituiranno allo Stato i sudditi che aveva perduto. Apparato per modificare gli individui, che Hanway chiama «riformatorio» (109). Sono questi i principi generali che Howard e Blackstone mettono in opera nel 1779 quando l'indipendenza degli Stati Uniti impedisce le deportazioni e viene preparata una legge per modificare il sistema delle pene. La detenzione, ai fini della trasformazione dell'anima e della condotta, fa il suo ingresso nel sistema delle leggi civili. Il preambolo della legge, redatto da Blackstone e Howard, descrive la detenzione individuale nella sua tripla funzione di temibile esempio, di strumento di conversione e di condizione per un apprendistato: sottomessi «a una detenzione isolata, a un lavoro regolare e all'influenza dell'istruzione religiosa» taluni criminali potranno «non solo ispirare lo spavento a coloro che fossero tentati d'imitarli, ma ancora correggere se stessi e contrarre l'abitudine al lavoro» (110). Di qui la decisione di costruire due penitenziari, uno per gli uomini e uno per le donne, in cui i detenuti isolati saranno costretti «ai lavori i più servili ed i più compatibili con l'ignoranza, la negligenza e l'ostinatezza dei criminali»: camminare in una strada per muovere una macchina, fissare un argano, lucidare il marmo, battere la canapa, estrarre il colore dal legno di campeggio, sfilacciare stracci, fare cordami e sacchi. In effetti un solo penitenziario fu costruito, quello di Gloucester, e non rispondente che parzialmente allo schema iniziale: isolamento totale per i criminali più pericolosi, per gli altri lavoro di giorno in comune e separazione la notte.
Infine, il modello di Filadelfia. Il più celebre senza dubbio perché appariva legato alle innovazioni politiche del sistema americano ed inoltre perché non fu vittima, come gli altri, di uno scacco immediato e dell'abbandono; esso fu continuamente ripreso e trasformato fino alle grandi discussioni degli anni 1830 sulla riforma penitenziaria. In molti punti la prigione di Walnut Street, aperta nel 1790, sotto l'influenza diretta dell'ambiente quacchero, riprendeva il modello di Gand e di Gloucester (111). Lavoro obbligatorio in laboratori, costante occupazione dei detenuti, finanziamento della prigione per mezzo di questo lavoro, ma anche retribuzione individuale dei prigionieri per assicurare loro il reinserimento morale e materiale nel mondo dell'economia: i condannati sono dunque «costantemente impiegati in lavori produttivi per sopperire alle spese della prigione, per non lasciarli nell'inazione e per preparare loro qualche risorsa per il momento in cui la loro cattività dovrà cessare» (112). La vita è dunque inquadrata secondo un impiego del tempo assolutamente rigoroso, sotto una sorveglianza ininterrotta; ogni istante della giornata ha una sua destinazione, prescrive un tipo di attività e porta con sé i suoi obblighi e le sue interdizioni: «Tutti i prigionieri si alzano al primo apparire della luce, in modo che dopo aver rifatto i letti, essersi puliti e lavati e aver adempiuto altre necessità, cominciano generalmente il lavoro al levare del sole. Da questo momento, nessuno può andare nelle sale o in altri luoghi che non siano i laboratori e luoghi assegnati al lavoro... Al calar del sole, si suona una campana che li avverte di lasciare il lavoro... si dà loro una mezz'ora per sistemare i letti, dopo di che non si permette loro di conversare ad alta voce o di fare il minimo rumore» (113). Come a Gloucester, l'isolamento non è totale; lo è per alcuni condannati che in altri tempi avrebbero subita la pena capitale e per quelli che all'interno della prigione meritano una punizione speciale: «Là, senza occupazione, senza niente per distrarlo, nell'attesa e nell'incertezza del momento in cui sarà liberato», il prigioniero passa lunghe ore ansiose, chiuso nelle riflessioni che si presentano a tutti i colpevoli» (114). Come a Gand, infine, la durata della detenzione può variare con la condotta del detenuto: gli ispettori della prigione, dopo la consultazione del dossier; ottengono dalle autorità - senza difficoltà fin verso gli anni 1830 - la grazia per i detenuti che si sono ben comportati.
Walnut Street comporta inoltre un certo numero di tratti specifici, o che per lo meno sviluppano quanto era virtualmente presente negli altri modelli. Prima di tutto il principio della non pubblicità della pena. Se la condanna e ciò che l'ha motivata devono essere conosciute da tutti, l'esecuzione della pena deve al contrario avvenire nel segreto; il pubblico non deve intervenire né come testimonio, né come garante della punizione. La certezza che dietro le mura il detenuto sconta la sua pena, deve bastare a costituire un esempio: non più quegli spettacoli di strada cui la legge del 1786 aveva dato luogo imponendo ad alcuni condannati lavori pubblici da eseguire nelle città e per le strade (115). Il castigo e la correzione ch'esso deve operare sono processi che si svolgono tra il prigioniero e coloro che lo sorvegliano. Processi che impongono una trasformazione dell'individuo tutto intiero - del suo corpo e delle sue abitudini, per mezzo del lavoro quotidiano cui viene costretto; del suo spirito e della sua volontà, per mezzo delle cure spirituali di cui è oggetto: «Vengono fornite Bibbie ed altri libri di religione pratica; il clero delle diverse obbedienze che si trovano nella città e nei sobborghi, assicura il servizio una volta alla settimana e ogni altra persona edificante può avere in ogni momento libero accesso ai prigionieri» (116). Ma la stessa amministrazione ha il ruolo di intraprendere questa trasformazione. La solitudine e il ritorno a se stessi non sono sufficienti, non più delle esortazioni puramente religiose. Deve esser fatto un lavoro sull'anima del detenuto, il più spesso possibile. La prigione, apparato amministrativo, sarà nello stesso tempo una macchina per riformare gli spiriti. Quando il detenuto entra, gli viene letto il regolamento; «nello stesso tempo gli ispettori cercano di fortificare in lui le obbligazioni morali ch'egli ha; gli rappresentano l'infrazione in cui è caduto rispetto ad esse, il male che ne è conseguentemente risultato per la società che lo proteggeva e la necessità di fornire una compensazione coll'esempio e coll'emendamento. Essi l'impegnano poi a fare il suo dovere con gaiezza, a condursi decentemente, promettendogli o facendogli sperare che, prima dello spirare del termine della sentenza, potrà ottenere il rilascio se si comporterà bene... Di tanto in tanto gli ispettori si fanno dovere di conversare coi criminali uno dopo l'altro, relativamente ai loro doveri come uomini e come membri della società» (117).
Ma la cosa più importante è, senza dubbio, che questo controllo e questa trasformazione del comportamento si accompagnano - condizione e conseguenza insieme - alla formazione di un sapere sugli individui. Insieme al condannato l'amministrazione riceve un rapporto sul crimine, sulle circostanze in cui è stato commesso, un riassunto dell'interrogatorio dell'imputato, delle note sul modo in cui si è comportato prima e dopo la sentenza. Altrettanti elementi indispensabili se si vuole «determinare quali saranno le cure necessarie per distoglierlo dalle sue antiche abitudini» (118). Durante tutto il tempo della detenzione egli verrà osservato, e la sua condotta annotata, giorno per giorno. Gli ispettori - dodici notabili della città designati nel 1795 - che, due a due, visitano la prigione ogni settimana, dovranno informarsi di quanto è accaduto, prender conoscenza della condotta di ogni condannato e designare quelli per i quali verrà chiesta la grazia. Questa conoscenza degli individui, continuamente aggiornata, permette di ripartirli nella prigione non tanto in funzione dei loro crimini quanto delle disposizioni di cui dànno prova. La prigione diviene una sorta di osservatorio permanente che permette di distribuire le varietà del vizio o della debolezza. A partire dal 1797, i prigionieri vengono divisi in quattro classi: la prima per quelli esplicitamente condannati all'isolamento o che hanno commesso, in prigione, colpe gravi; un'altra riservata a coloro che sono «ben conosciuti per essere delinquenti abituali... o di cui la morale depravata, il carattere pericoloso, le disposizioni irregolari o la condotta disordinata» si sono manifestate durante il tempo trascorso in prigione; un'altra per quelli «il cui carattere e le circostanze, prima e dopo la condanna fanno credere che non siano delinquenti abituali». Infine esiste una sezione speciale, una classe di prova per quelli il cui carattere non è ancora conosciuto, o che, seppur conosciuti, non meritano di rientrare nella categoria precedente (119). Tutto un sapere individualizzante si organizza, prendendo come campo di riferimento non tanto il delitto commesso (almeno allo stato isolato) ma la virtualità di pericolo che si nasconde in un individuo e che si manifesta nella condotta quotidianamente osservata. Qui la prigione funziona come un apparato di sapere.
Tra questo apparato punitivo proposto dai modelli olandese, inglese, americano - tra questi «riformatori» e tutti i castighi immaginati dai riformatori, possiamo stabilire punti di convergenza e disparità.
Punti di convergenza. In primo luogo il capovolgimento temporale della punizione. I «riformatori» si attribuiscono, anch'essi, la funzione non di cancellare un delitto, ma di evitare che ricominci. Sono dispositivi rivolti verso l'avvenire, posti in opera per bloccare la ripetizione del misfatto. «L'oggetto delle pene non è l'espiazione del crimine, di cui bisogna lasciare la determinazione all'Essere supremo, ma il prevenire i delitti della stessa specie» (120). E in Pennsylvania, Buxton affermava che i principi di Montesquieu e di Beccaria dovevano aver ormai «forza d'assiomi», «la prevenzione dei delitti è il solo fine del castigo» (121). Non si punisce dunque per cancellare un delitto, ma per trasformare un colpevole (attuale o virtuale); il castigo deve portare con sé una certa tecnica correttiva. Qui di nuovo Rush si avvicina ai giuristi riformatori - lo faceva, forse, con la metafora che impiega - quando dice: son pur state inventate macchine per facilitare il lavoro; quanto maggiormente dovremmo lodare colui che inventasse «i metodi più rapidi e più efficaci per ricondurre alla virtù e alla felicità la parte più viziosa dell'umanità e per estirpare una parte del vizio che esiste nel mondo» (122). Infine, i modelli anglosassoni, come i progetti dei legislatori e dei teorici, si richiamano a procedimenti per individualizzare la pena: per la durata, per la natura, per l'intensità, per il modo in cui si svolge, il castigo deve essere adattato al carattere individuale ed a quanto esso comporta di pericolosità per gli altri. Il sistema di pene deve essere aperto a variabili individuali. Nel loro schema generale, i modelli più o meno derivati dal Rasphuis di Amsterdam non erano in contraddizione con ciò che i riformatori proponevano. Si potrebbe perfino pensare, a un primo sguardo, ch'essi non ne erano che lo sviluppo - o l'abbozzo - a livello di istituzioni concrete.
E tuttavia la disparità risulta evidente quando si tratti di definire le tecniche di questa correzione individualizzante. La differenza si manifesta nella procedura d'accesso all'individuo, nel modo in cui il potere punitivo esercita la sua presa su di lui, negli strumenti che mette in opera per assicurare la trasformazione: è nella tecnologia della pena, non nel suo fondamento teorico; nel rapporto che essa stabilisce rispetto al corpo e all'anima e non nel modo con cui si inserisce all'interno del sistema di diritto.
Sia il metodo dei riformatori. Quale il punto cui si aggancia la pena, quello per cui essa ha presa sull'individuo? Le rappresentazioni: rappresentazione degli interessi, rappresentazione dei vantaggi, degli svantaggi, del piacere e del dispiacere; e se accade che il castigo si impadronisca del corpo, gli applichi tecniche che non hanno niente da invidiare ai supplizi, è nella misura in cui esso è - per il condannato o per gli spettatori - un oggetto di rappresentazione. Lo strumento con cui si agisce sulle rappresentazioni? Altre rappresentazioni, o piuttosto accoppiamenti di idee (delitto-punizione, vantaggio immaginato del crimine - svantaggio percepito dei castighi). Questi accoppiamenti non possono funzionare che nell'elemento della pubblicità: scene punitive che li stabiliscano o li rinforzino agli occhi di tutti, discorsi che li facciano circolare e valorizzino ad ogni istante il gioco dei segni. Il ruolo del criminale nella punizione è di riintrodurre, di fronte al codice e ai delitti, la presenza reale dei significati - ossia di quella pena che secondo i termini del codice deve essere infallibilmente associata all'infrazione. Produrre in abbondanza ed evidenziare questo significato, riattivare con ciò il sistema significante del codice, far funzionare l'idea del crimine come un segno di punizione: è con questa moneta che il malfattore paga il suo debito alla società. La correzione individuale deve dunque assicurare il processo di riqualificazione dell'individuo come soggetto di diritto, mediante il rafforzamento sia dei sistemi di segni che delle rappresentazioni che questi fanno circolare.
L'apparato della penalità correttiva agisce in tutt'altro modo. Il punto d'applicazione della pena non è la rappresentazione, ma il corpo, il tempo, i gesti e le attività di tutti i giorni; l'anima anche, ma nella misura in cui essa è sede di abitudini. Il corpo e l'anima, come principi di comportamento, formano l'elemento che viene ora proposto all'intervento punitivo. Piuttosto che su un'arte di rappresentazioni, questo deve riposare su una manipolazione riflessa dell'individuo: «Ogni crimine trova la sua guarigione nell'influenza psichica e morale»; bisogna dunque, per determinare i castighi, «conoscere il principio delle sensazioni e delle simpatie che si producono nel sistema nervoso» (123). Quanto agli strumenti utilizzati, non sono più dei giochi di rappresentazione ad essere rinforzati e fatti circolare, ma delle forme di coercizione, degli schemi di costrizione applicati e ripetuti. Esercizi, non segni: orari, impieghi del tempo, movimenti obbligatori, attività regolari, meditazione solitaria, lavoro in comune, silenzio, applicazione, rispetto, buone abitudini. Alla fine, ciò che si cerca di ricostituire in questa tecnica di correzione non è tanto il soggetto di diritto, che si trova preso negli interessi fondamentali del patto sociale, quanto il soggetto obbediente, l'individuo assoggettato a certe abitudini, regole, ordini, un'autorità che si esercita continuamente intorno a lui e su di lui e ch'egli deve lasciar funzionare automaticamente in lui. Due modi dunque ben distinti di reagire all'infrazione: ricostituire il soggetto giuridico del patto sociale - o formare un soggetto obbediente piegato alla forma, generale e meticolosa insieme, di un qualunque potere.
Tutto ciò non costituirebbe forse altro che una differenza essenzialmente speculativa - poiché in entrambi i casi si tratta di formare degli individui sottomessi - se la penalità «di coercizione» non portasse con sé alcune conseguenze capitali. La correzione della condotta attraverso il pieno impiego del tempo, l'acquisizione di abitudini, le costrizioni del corpo implicano tra colui che punisce e colui che viene punito un rapporto del tutto particolare. Rapporto che rende non semplicemente inutile la dimensione di spettacolo: la esclude (124). L'agente di punizione deve esercitare un potere totale, che nessun terzo può intervenire a turbare. L'individuo da correggere deve essere interamente avviluppato nel potere che si esercita su di lui. Imperativo del segreto. E, dunque, anche autonomia almeno relativa di questa tecnica di punizione: essa dovrà avere un suo funzionamento, sue regole, sue tecniche ed un suo sapere; dovrà fissare le sue norme, decidere i suoi risultati: discontinuità, o in ogni caso, specificità in rapporto al potere giudiziario che dichiara la colpevolezza e fissa i limiti generali della punizione. Ora, queste due conseguenze - segreto e autonomia nell'esercizio del potere di punire - escono dai limiti di una teoria e di una politica della penalità che si proponevano due scopi: far partecipare tutti i cittadini al castigo del nemico sociale, rendere l'esercizio del potere di punire interamente adeguato e trasparente rispetto alle leggi che pubblicamente lo delimitano. Castighi segreti e non codificati dalla legislazione, un potere di punire che si esercita nell'ombra secondo criteri e con strumenti che sfuggono al controllo - è tutta la strategia della riforma che rischia di essere compromessa. Dopo la sentenza si costituisce un potere che fa pensare a quello esercitato dal sistema classico. Il potere che applica le pene minaccia di essere altrettanto arbitrario, altrettanto dispotico di quello che un tempo ne decideva.
Insomma, la divergenza è la seguente: città punitiva o istituzione punitiva? Da un lato, un funzionamento del potere penale ripartito in tutto lo spazio sociale; presente ovunque come scena, spettacolo, segno, discorso; leggibile come un libro aperto, operante attraverso una codificazione permanente dello spirito dei cittadini; garante della repressione del crimine per mezzo di ostacoli posti all'idea del delitto; agente in maniera invisibile e inutile sulle «fibre molli del cervello», come diceva Servan. Un potere di punire che si snodi attraverso tutta la rete sociale, agisca in ciascuno dei suoi punti e finisca per non essere più percepito come potere di alcuni su alcuni, ma come reazione immediata di tutti nei riguardi di ciascuno. Dall'altro lato, un funzionamento compatto del potere di punire: una presa in carico meticolosa del corpo e del tempo del colpevole, un inquadramento dei suoi gesti, delle sue condotte, per mezzo di un sistema d'autorità e di sapere; un'ortopedia concertata applicata ai colpevoli al fine di rieducarli individualmente; una gestione autonoma di questo potere che si isola altrettanto bene dal corpo sociale che dal potere giudiziario propriamente detto. Ciò che viene impegnato nell'emergere della prigione, è l'istituzionalizzazione del potere di punire o, più precisamente: il potere di punire (con l'obiettivo strategico che si è attribuito alla fine del secolo Diciottesimo, la riduzione degli illegalismi popolari) verrà meglio assicurato nascondendosi sotto una funzione sociale generale, nella «città punitiva», o investendosi in una istituzione coercitiva, nel chiuso del «riformatorio»?
In ogni modo, possiamo dire che alla fine del secolo Diciottesimo ci troviamo davanti a tre maniere di organizzare il potere di punire. La prima, è quella che funzionava ancora e si appoggiava sul vecchio diritto monarchico. Le altre due si riferiscono entrambe ad una concezione preventiva, utilitaria, correttiva di un diritto di punire che apparterrebbe all'intera società, ma sono molto differenti a livello dei dispositivi cui dànno luogo. Con una larga schematizzazione, possiamo dire che, nel diritto monarchico, la punizione è un cerimoniale di sovranità; utilizza i marchi rituali della vendetta che applica sul corpo del condannato e ostenta agli occhi degli spettatori un effetto di terrore tanto più intenso quanto più discontinuo, irregolare e sempre al di sopra delle sue proprie leggi, è la presenza fisica del sovrano e del suo potere. Nel progetto dei giuristi riformatori, la punizione è una procedura per riqualificare gli individui come soggetti di diritto; essa utilizza non dei marchi, ma dei segni, degli insiemi codificati di rappresentazioni, e di questi, la scena del castigo deve assicurare la circolazione più rapida e l'accettazione più universale possibile. Infine, nel progetto di istituzione carceraria che viene elaborato, la punizione è una tecnica di coercizione degli individui; essa pone in opera dei processi di addestramento del corpo - non dei segni - con le tracce che questo lascia, sotto forma di abitudini, nel comportamento; essa suppone la messa in opera di un potere specifico di gestione della pena. Il sovrano e la sua forza, il corpo sociale, l'apparato amministrativo. Il marchio, il segno, la traccia. La cerimonia, la rappresentazione, l'esercizio. Il nemico vinto, il soggetto di diritto in via di riqualificazione, l'individuo assoggettato ad una coercizione immediata. Il corpo suppliziato, l'anima di cui si manipolano le rappresentazioni, il corpo che viene addestrato: sono tre serie di elementi che caratterizzano i tre dispositivi che si affrontano nella seconda metà del secolo Diciottesimo. Non possiamo ridurli né a teorie del diritto (benché essi le ritraccino) né identificarli con apparati o istituzioni (benché appoggino su queste), né farli derivare da scelte morali (benché vi trovino la loro giustificazione). Essi sono modalità secondo le quali si esercita il potere di punire. Tre tecnologie di potere.
Il problema è allora il seguente: come accadde che il terzo si sia alla fine imposto? Come il modello coercitivo, corporale, solitario, segreto, del potere di punire si sostituì al modello rappresentativo, scenico, significante, pubblico, collettivo? Perché l'esercizio fisico della punizione (e che non è il supplizio) si sostituì, con la prigione che ne è il supporto istituzionale, al gioco sociale dei segni di punizione e alla loquace festa che li faceva circolare?