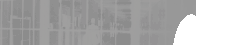PUNIZIONE.
Capitolo primo.
La punizione generalizzata.
«Che le pene siano moderate e proporzionate ai delitti, che quella di morte non sia più pronunciata che contro i colpevoli di assassinio, e che i supplizi che rivoltano l'umanità siano aboliti» (1). La protesta contro i supplizi, la troviamo ovunque, nella seconda metà del secolo Diciottesimo: proviene dai filosofi e dai teorici del diritto; da giuristi, uomini di legge, parlamentari (2); la troviamo nei "cahiers de doléance" e tra i legislatori delle assemblee. E' necessario punire diversamente: abolire lo scontro fisico del sovrano col condannato; sciogliere il corpo a corpo che si svolge tra la vendetta del principe e la collera contenuta del popolo, intermediari il suppliziato e il boia. Improvvisamente, il supplizio è divenuto intollerabile. Rivoltante quando si guardi dal lato del principe, dove tradisce la tirannia, l'eccesso, la sete di vendetta, il «crudele piacere di punire» (3). Vergognoso, quando si guardi dal lato della vittima, che viene ridotta alla disperazione e che ancora si vorrebbe benedicesse «il cielo ed i propri giudici, da cui sembra abbandonata» (4). Pericoloso sempre, per l'appoggio che vi trovano, l'una contro l'altra, la violenza del re e quella del popolo. Come se il potere sovrano non vedesse, in questa emulazione d'atrocità, una sfida che egli stesso lancia, ma che potrà un giorno essere rilanciata: abituato «a veder sgorgare il sangue», il popolo impara presto «che non può vendicarsi che col sangue» (5). In quelle cerimonie che sono oggetto di tante denunce ostili, si percepisce l'incrociarsi tra la dismisura della giustizia armata e la collera del popolo minacciato. In questo rapporto, Joseph de Maistre riconoscerà uno dei meccanismi fondamentali del potere assoluto: tra il principe e il popolo, il boia forma un congegno di trasmissione; la morte che egli dà è come quella dei servi della gleba che costruivano San Pietroburgo sopra paludi e pestilenze; essa è principio di universalità; della singola volontà del despota, fa una legge per tutti, e da ciascuno di quei corpi distrutti, una pietra per lo Stato; che importa se colpisce degli innocenti! Al contrario, di questa stessa violenza, rischiosa e rituale, i riformatori del secolo Diciottesimo denunciano quanto eccede, da una parte e dall'altra, l'esercizio legittimo del potere: la tirannia, secondo loro, vi fronteggia la rivolta; esse si chiamano l'un l'altra. Doppio pericolo. Bisogna che la giustizia criminale, invece di vendicarsi, finalmente punisca.
Questa necessità di castigo senza supplizio viene formulata dapprincipio come un grido del cuore o della natura indignata: nel peggiore degli assassini, una cosa almeno deve essere rispettata quando si punisce: la sua «umanità». Verrà un giorno, nel secolo Diciannovesimo, in cui quest'«uomo», scoperto nel criminale, diverrà il bersaglio dell'intervento penale, l'oggetto ch'esso pretende di correggere e di trasformare, il campo di tutta una serie di scienze e di pratiche specifiche - «penitenziarie», «criminologiche». Ma in quest'epoca dei Lumi non è come tema di un sapere positivo che l'uomo viene opposto alla barbarie dei supplizi, ma come limite al diritto: frontiera legittima del potere di punire. Non ciò che il potere deve colpire se vuole modificare l'uomo, ma ciò che deve lasciare intatto per essere in grado di rispettarlo. "Noli me tangere". Questo segna un punto d'arresto alla vendetta del sovrano. L'«uomo» che i riformatori hanno eretto contro il dispotismo del patibolo è anch'esso un uomo-misura: non delle cose, tuttavia, ma del potere.
Problema, dunque: come quest'uomo-limite è stato opposto alla pratica tradizionale dei supplizi? In qual modo è divenuto la grande giustificazione morale del movimento di riforma? Perché quest'orrore così unanime per i supplizi ed una tale insistenza lirica per castighi che sarebbero «umani»? Oppure, ed è la stessa cosa, come si articolano l'uno sull'altro, in una strategia unica, questi due elementi presenti ovunque nella rivendicazione di una penalità addolcita: «misura» e «umanità»? Elementi così necessari e tuttavia così incerti quali sono, così fluidi, e ancora associati nella medesima incerta relazione, che ritroviamo ancor oggi quando si pone di nuovo, e sempre, il problema dell'economia dei castighi? Tutto si svolge come se il secolo Diciottesimo avesse aperto la crisi di questa economia, proposto per risolverla la legge fondamentale che il castigo deve avere l'«umanità» come «misura», senza per altro aver potuto dare un senso definitivo a questo principio, considerato tuttavia come inaggirabile. Bisogna dunque raccontare la nascita e la prima storia di questa enigmatica «dolcezza».
Si glorificano i grandi «riformatori» - Beccaria, Servan, Dupaty, o Lacretelle, Duport, Pastoret, Target, Bergasse, i redattori dei "Cahiers" ed i Costituenti - per aver imposto questa dolcezza ad un apparato giudiziario e a dei teorici «classici» che, ancora nel tardo secolo Diciottesimo, la rifiutavano, e con rigore di argomentazioni (6).
Bisogna tuttavia inserire questa riforma in un processo che gli storici hanno individuato recentemente attraverso lo studio degli archivi giudiziari: la diminuita tensione nel sistema penale, nel corso del secolo Diciottesimo o, più precisamente, un doppio movimento per cui, durante questo periodo, i crimini sembrano perdere parte della loro violenza, mentre le punizioni, reciprocamente, si alleggeriscono di una parte della loro intensità, ma a prezzo di interventi che si moltiplicano. Dalla fine del secolo Diciassettesimo, in effetti, si nota una considerevole diminuzione dei delitti di sangue e, in linea generale, delle aggressioni fisiche; i delitti contro la proprietà sembrano dare il cambio ai crimini violenti; il furto e la truffa agli omicidi, le ferite, le percosse; la diffusa delinquenza, occasionale ma frequente, delle classi più povere è sostituita da una delinquenza limitata ed «abile»; i criminali del secolo Diciassettesimo sono «degli uomini spossati, mal nutriti, tutto all'improvviso, tutto di collera, dei criminali d'estate»; quelli del secolo Diciottesimo, «dei sornioni, degli astuti, degli scaltri che calcolano», criminalità di chi è «ai margini» (7); infine, l'organizzazione della delinquenza si modifica: le grandi bande di malfattori (saccheggiatori riuniti in piccole unità armate, gruppi di contrabbandieri che fanno fuoco contro i commessi della Ferme, soldati licenziati o disertori che vagabondano insieme) tendono a dissolversi; senza dubbio si dà loro meglio la caccia ed essi sono obbligati a farsi più piccoli per passare inosservati - spesso non più d'un pugno d'uomini -, si contentano di operazioni più furtive, con un minimo di spiegamento di forze e minimi rischi di massacro: «La liquidazione fisica o lo smembramento istituzionale delle grandi bande... lascia, dopo il 1755, il campo libero ad una delinquenza antiproprietà che si rivela ormai individualista o che diviene l'affare di gruppi molto piccoli composti da ladruncoli notturni di pastrani o da borsaioli: i loro effettivi non superano le quattro persone» (8). Un movimento globale fa deviare l'illegalismo dall'attacco al corpo verso lo stornamento più o meno diretto dei beni; e dalla «criminalità di massa» verso una «criminalità di frange e di margini», riservata in parte a dei professionisti. Tutto accade dunque come se ci fosse un progressivo abbassamento di livello - «un disinnesco delle tensioni che regnano nei rapporti umani,... un miglior controllo degli impulsi violenti» (9) - e come se le pratiche illegali avessero da sole allentata la loro stretta sul corpo e si fossero indirizzate verso altri bersagli. Addolcirsi dei crimini, prima dell'addolcirsi delle leggi. Ora, questa trasformazione non può essere separata da numerosi processi che la sottendono e, prima di tutto, come nota P. Chaunu, da una modificazione del gioco delle pressioni economiche, da un innalzamento generale del livello di vita, da un forte incremento demografico, da una moltiplicazione delle ricchezze e delle proprietà e dal «bisogno di sicurezza che ne è conseguenza» (10). Inoltre, nel corso del secolo Diciottesimo, si constata un appesantirsi della giustizia, le cui norme, in molti casi, divengono più severe: in Inghilterra sui 223 crimini capitali definiti all'inizio del secolo Diciannovesimo, solo 156 lo erano stati durante gli ultimi cent'anni (11); in Francia, la legislazione sul vagabondaggio era stata riformata ed aggravata a più riprese, a partire dal secolo Diciassettesimo. Un esercizio più rigoroso e meticoloso della giustizia tende a prendere in considerazione tutta una piccola delinquenza che in altri tempi lasciava più facilmente sfuggire: «essa diventa, nel secolo Diciottesimo, più lenta, più pesante, più severa verso il furto, di cui la frequenza relativa è aumentata, e verso il quale essa prende ormai degli atteggiamenti borghesi di giustizia di classe» (12); si sviluppa, in Francia soprattutto, ma più ancora a Parigi, un apparato di polizia che impedisce l'affermarsi di una criminalità organizzata e in piena luce; ci si sposta verso forme più discrete. E, a questo insieme di precauzioni, bisogna aggiungere la convinzione generalmente diffusa, di un aumento incessante e pericoloso dei crimini. Mentre gli storici di oggi constatano una diminuzione delle grandi bande di malfattori, Le Trosne le vedeva abbattersi, come nubi di cavallette, su tutta la campagna francese: «Sono insetti voraci che devastano giornalmente la sussistenza dei coltivatori. Sono, per parlare fuor di metafora, truppe nemiche sparse sulla superficie del territorio, che ci vivono a loro discrezione come in un paese conquistato e che levano autentici tributi a titolo di elemosina»: essi costerebbero, ai contadini più poveri, più della taglia (13): un terzo almeno, là dove l'imposizione è più elevata (14). La maggior parte degli osservatori sostiene che la delinquenza aumenta: l'affermano, naturalmente, i partigiani di un maggior rigore; l'affermano anche quelli che pensano che una giustizia più misurata nelle sue violenze sarebbe più efficace, meno disposta a recedere da sola davanti alle sue proprie conseguenze' (15) l'affermano i magistrati, che pretendono di essere sovraccarichi di processi: «La miseria delle popolazioni e la corruzione dei costumi hanno moltiplicato crimini e colpevoli» (16), lo mostra in ogni caso la pratica effettiva dei tribunali. «E' di certo l'era rivoluzionaria e imperiale che già gli ultimi anni dell'"Ancien Régime" annunciano. Colpirà, nei processi del 1782-89, l'aumento dei pericoli. Severità verso i poveri, rifiuto deliberato di testimonianze, aumentare reciproco delle diffidenze, degli odi, delle paure» (17).
In effetti, lo spostamento da una criminalità di sangue ad una criminalità di frode fa parte di tutto un complesso meccanismo, in cui figurano lo sviluppo della produzione, l'aumento delle ricchezze, una valorizzazione giuridica e morale più intensa dei rapporti di proprietà, i metodi di sorveglianza più rigorosi, un più stretto controllo della popolazione, tecniche più avanzate di individuazione, di cattura, di informazione: lo spostarsi delle pratiche illegali è correlativo ad una estensione e ad un affinamento delle pratiche punitive.
Una trasformazione generale di atteggiamento, «un cambiamento che appartiene al dominio dello spirito e del subcosciente» (18)? Forse, ma più sicuramente e più immediatamente, uno sforzo per regolare i meccanismi di potere che inquadrano l'esistenza degli individui; un adattamento ed un affinamento dei meccanismi che prendono in carico e mettono sotto sorveglianza la loro condotta quotidiana, la loro identità, la loro attività, i loro gesti apparentemente senza importanza; un'altra politica nei confronti di quella molteplicità di corpi e di forze che costituisce una popolazione. Ciò che si disegna, è senza dubbio meno un nuovo rispetto per la umanità dei condannati - i supplizi sono ancora frequenti anche per delitti minori -, che non una tendenza verso una giustizia più sottile e più acuta, verso un più stretto controllo di polizia del corpo sociale. Secondo un processo circolare, la soglia di passaggio ai crimini violenti si innalza, l'intolleranza ai delitti economici aumenta, i controlli si fanno più pesanti, gli interventi penali più tempestivi e insieme più numerosi.
Ora, se confrontiamo questo processo al discorso critico dei riformatori, possiamo notare una notevole coincidenza strategica. Ciò che essi attaccano in effetti nella giustizia tradizionale, prima di stabilire i principi di una nuova penalità, è proprio l'eccesso dei castighi; ma un eccesso che è legato più ad una irregolarità, che ad un abuso del potere di punire. Il 24 marzo 1790, Thouret apre alla Costituente la discussione sulla nuova organizzazione giudiziaria del potere. Potere che, secondo lui, è «snaturato», in Francia, in tre modi. A motivo di una appropriazione privata: gli uffici dei giudici si vendono; si trasmettono in eredità; hanno un valore mercantile e la giustizia che viene resa è, da questo fatto medesimo, resa onerosa. A motivo di una confusione tra due tipi di potere: quello che rende giustizia e formula una sentenza applicando la legge, e quello che fa la legge stessa. A motivo infine della esistenza di tutta una serie di privilegi che rendono l'esercizio della giustizia incerto: esistono tribunali, procedure, convenuti, addirittura delitti, che sono «privilegiati» e cadono fuori dal diritto comune (19). Questa non è che una delle innumerevoli formulazioni critiche, vecchie almeno di mezzo secolo, che, tutte, denunciano in questa snaturazione la fonte di una giustizia irregolare. La giustizia penale è irregolare prima di tutto per la molteplicità delle istanze che sono incaricate di assicurarla, senza mai costituire una piramide unica e continua (20). Anche lasciando da parte le giurisdizioni religiose, bisogna tener conto di discontinuità, di scavalcamenti e di conflitti fra le differenti giustizie; quelle signorili, che sono ancora importanti per la repressione dei delitti minori; quelle reali che sono anch'esse numerose e malcoordinate (le corti sovrane sono in frequente conflitto con quelle dei balivi e soprattutto con quelle di presidio, da poco create come istanze intermediarie); quelle che, di diritto o di fatto, vengono assicurate da istanze amministrative (come gli intendenti) o di polizia (come le prevosture o le luogotenenze di polizia); a cui bisognerebbe aggiungere ancora il diritto che il re o i suoi rappresentanti possiedono di prendere decisioni di internamento o di esilio, al di fuori di ogni procedura regolare. Queste istanze multiple, per la loro stessa pletoricità, si neutralizzano e sono incapaci di ricoprire il corpo sociale in tutta la sua estensione. Il loro aggrovigliarsi rende la giustizia penale paradossalmente lacunosa. Lacunosa a motivo delle differenze di consuetudini e di procedure, malgrado la Ordinanza generale del 1670; lacunosa a motivo dei conflitti interni di competenza; lacunosa a motivo degli interessi particolari - politici o economici - che ogni istanza è portata a difendere; lacunosa infine a causa degli interventi del potere reale che può impedire, con le grazie, le commutazioni, le convocazioni in consiglio o le pressioni dirette sui magistrati, il corso regolare e austero della giustizia.
Piuttosto che di debolezza o di crudeltà, è di una cattiva economia del potere che si tratta nella critica dei riformatori. Troppo potere nelle giurisdizioni inferiori, che possono - favorite dall'ignoranza e dalla povertà dei condannati - trascurare gli appelli di diritto e far eseguire senza controllo sentenze arbitrarie; troppo potere da parte di un'accusa, cui sono dati, quasi senza limite, mezzi per perseguire, mentre l'accusato è disarmato di fronte ad essa, il che induce i giudici ad essere talvolta troppo severi, talaltra, per reazione, troppo indulgenti; troppo potere ai giudici che possono accontentarsi di prove futili, quando siano «legali» e che dispongono di una libertà piuttosto vasta nella scelta della pena; troppo potere accordato alla «gente del re» non solo nei riguardi degli accusati, ma anche degli altri magistrati; troppo potere infine esercitato dal re, che può sospendere il corso della giustizia, modificarne le decisioni, esautorare i magistrati, revocarli o esiliarli, sostituire loro dei giudici di designazione reale. La paralisi della giustizia è meno legata ad un indebolimento che non ad una mal regolata distribuzione del potere, alla sua concentrazione in un certo numero di punti, ed ai conflitti, alle discontinuità che ne derivano.
Ora questa disfunzione del potere rinvia ad un eccesso al centro: ciò che potremmo chiamare il «superpotere» monarchico, che identifica il diritto di punire col potere personale del sovrano. Identificazione teorica che fa del re la "fons justitiae", ma le cui conseguenze pratiche sono decifrabili persino in ciò che sembra opporglisi e limitare il suo assolutismo. E' perché, per ragioni di tesoreria, il re si attribuisce il diritto di vendere uffici di giustizia, che gli «appartengono», che si trova di fronte dei magistrati, proprietari delle cariche, non solo indocili, ma ignoranti, preda di interessi, pronti al compromesso. E' perché crea incessantemente nuovi uffici, che egli stesso moltiplica i conflitti di potere e di attribuzione. E' perché esercita un potere troppo diretto sulla sua «gente» e le conferisce un potere quasi discrezionale ch'egli intensifica i conflitti nella magistratura. E' perché ha messo la giustizia in concorrenza con troppe procedure frettolose (giurisdizioni delle prevosture o dei luogotenenti di polizia) o con misure amministrative, ch'egli paralizza la giustizia regolare, che la rende talvolta indulgente e incerta, ma talaltra precipitosa e severa (21).
Non sono tanto, o per lo meno non solamente, i privilegi della giustizia, l'arbitrio, l'arroganza arcaica, i diritti senza controllo ad essere criticati; ma piuttosto la mescolanza fra le sue debolezze ed i suoi eccessi, tra le sue esagerazioni e le sue lacune, e soprattutto il principio stesso di questa mescolanza, il superpotere monarchico. Il vero obiettivo della riforma, e già nelle formulazioni più generali, non è tanto fondare un nuovo diritto di punire partendo da principi più equi, quanto di stabilire una nuova «economia» del potere di castigare, di assicurarne una migliore distribuzione, di far sì ch'esso non sia troppo concentrato in alcuni punti privilegiati, né troppo diviso fra istanze che si oppongono; che sia ripartito in circuiti omogenei suscettibili di esercitarsi ovunque, in modo continuo e fino al germe più piccolo del corpo sociale (22). La riforma del diritto criminale deve essere letta come una strategia per il riassetto del potere di punire, secondo modalità che lo rendano più regolare, più efficace, più costante e meglio dettagliato nei suoi effetti; in breve che aumentino gli effetti, diminuendone il costo economico (ossia dissociandolo dal sistema della proprietà, degli acquisti., delle vendite, della venalità tanto degli uffici quanto delle stesse decisioni) ed il costo politico (dissociandolo dall'arbitrio del potere monarchico). La nuova teoria giuridica della scienza penale ricopre in effetti una nuova «economia politica» del potere di punire. Si intende allora perché questa «riforma»non abbia avuto un unico punto di origine. Non sono gli accusati (23) più illuminati, né i filosofi nemici del dispotismo e amici dell'umanità, e non sono neppure i gruppi sociali che si oppongono ai parlamentari, il punto di partenza della riforma. O piuttosto, non loro solamente; nel progetto globale di una nuova distribuzione del potere di punire e di una nuova ripartizione dei suoi effetti, vengono a collocarsi numerosi interessi diversi. La riforma non è stata preparata dall'esterno dell'apparato giudiziario e contro tutti i suoi rappresentanti, ma è stata preparata, e nell'essenziale, dall'interno, da parte di un grandissimo numero di magistrati, partendo sia da obiettivi comuni che dai conflitti di potere che li opponevano fra loro. Certo, i riformatori non erano la maggioranza, fra i magistrati; ma furono proprio uomini di legge a disegnarne i principi generali: un potere di giudicare sul quale non avrebbe pesato l'esercizio immediato della sovranità del principe; un potere affrancato dalla pretesa di legiferare; svincolato dai rapporti di proprietà; e che, non avendo altra funzione che il giudicare, ne avrebbe esercitato pienamente il potere. In una parola, far sì che il potere di giudicare non dipendesse più dai molteplici privilegi, discontinui, contraddittori talvolta, della sovranità, ma dagli effetti, distribuiti con continuità, del potere pubblico. Questo principio generale definisce una strategia d'insieme che albergò combattimenti ben diversi fra loro. Quelli di filosofi come Voltaire e di pubblicisti come Brissot o Marat; ma anche quelli di magistrati i cui interessi erano tuttavia molto diversi: Le Trosne, consigliere al tribunale di presidio di Orléans, e Lacretelle, avvocato generale del Parlamento; Target, che, coi parlamenti, si oppone alla riforma di Maupeou; ma anche J. N. Moreau. che sostiene il potere reale contro i parlamentari; Servan e Dupaty, magistrati entrambi, ma in conflitto coi loro colleghi, eccetera.
Lungo tutto il secolo Diciottesimo, all'interno e all'esterno dell'apparato giudiziario, nella pratica penale quotidiana come nella critica alle istituzioni, viene formandosi una nuova strategia per l'esercizio del potere di castigare. E la «riforma» propriamente detta, quale viene o formulata nelle teorie del diritto o schematizzata nei progetti, è la ripresa politica o filosofica di questa strategia, con i suoi obiettivi primari: fare della punizione e della repressione degli illegalismi una funzione regolare, suscettibile di estendersi a tutta la società; non punire meno, ma punire meglio; punire con una severità forse attenuata, ma per punire con maggior universalità e necessità; inserire nel corpo sociale, in profondità, il potere di punire.
La congiuntura che ha visto nascere la riforma, non è dunque quella di una nuova sensibilità, ma quella di un'altra politica nei confronti degl'illegalismi.
Possiamo dire schematicamente che, sotto l'"Ancien Régime", i diversi strati sociali avevano ciascuno il proprio margine di illegalismo tollerato: la non-applicazione della regola, l'inosservanza degli innumerevoli editti o ordinanze erano condizione del funzionamento politico ed economico della società. Tratto non peculiare all'"Ancien Régime"? Senza dubbio. Ma l'illegalismo era allora così profondamente radicato e così necessario alla vita di ogni strato sociale, da avere, in qualche modo, una propria coerenza ed una propria economia. Talvolta rivestiva una forma assolutamente statutaria - che ne faceva piuttosto che un illegalismo, una regolare esenzione: erano i privilegi accordati agli individui e alle comunità. Talvolta assumeva la forma di inosservanza massiccia e generale, per cui per decenni, per secoli talvolta, talune ordinanze potevano essere pubblicate e rinnovate incessantemente, senza venir mai applicate. Talaltra si trattava di desuetudine progressiva che faceva posto, in certi casi, ad improvvise riattivazioni, oppure di un tacito consenso del potere, di una negligenza o, semplicemente, dell'impossibilità effettiva d'imporre la legge e di reprimere le infrazioni. Gli strati più sfavoriti della popolazione non avevano, in linea di principio, alcun privilegio: ma beneficiavano, nei limiti di ciò che era imposto dalle leggi e dalle consuetudini, di uno spazio di tolleranza, conquistato con la forza o con l'ostinazione; e questo spazio era per loro una condizione talmente indispensabile di esistenza, che, spesso, essi erano pronti a sollevarsi per difenderlo. I tentativi periodicamente fatti per ridurlo, facendo valere vecchie norme o affinando i procedimenti di repressione, provocavano sempre agitazioni popolari, così come i tentativi per ridurre certi privilegi mettevano in agitazione la nobiltà, il clero, la borghesia.
Ora questo illegalismo necessario e di cui ogni strato sociale portava seco le forme specifiche, si trovava preso in una serie di paradossi. Nelle sue regioni inferiori, raggiungeva la criminalità da cui gli era difficile distinguersi, giuridicamente se non moralmente: dall'illegalismo fiscale a quello doganale, al contrabbando, al saccheggio, alla lotta armata contro i funzionari della finanza poi contro gli stessi soldati, alla rivolta infine, c'era una continuità, dove era difficile segnare delle frontiere; o ancora il vagabondaggio (severamente punito ai termini di ordinanze quasi mai applicate), con tutto ciò che comportava di rapine, furti qualificati, assassini talvolta - che serviva da "milieu" per accogliere i disoccupati, gli operai che avevano lasciato irregolarmente i padroni, i domestici che avevano qualche ragione per fuggire i signori, gli apprendisti maltrattati, i soldati disertori, tutti coloro che volevano sfuggire all'arruolamento forzato. In questo modo, la criminalità si fondava su un'illegalismo più vasto, cui gli strati popolari erano attaccati come a condizioni di esistenza; e inversamente questo illegalismo era un fattore perpetuo di aumento della criminalità. Di qui l'ambiguità degli atteggiamenti popolari: da una parte il criminale - soprattutto quando si trattava di un contrabbandiere o di un contadino cacciato dalle estorsioni di un padrone - beneficiava di una valorizzazione spontanea: nelle sue violenze veniva ritrovato il filo diretto di vecchie lotte; ma d'altra parte colui che, protetto da un illegalismo accettato dalla popolazione, commetteva dei delitti a spese di questa, il mendicante vagabondo, ad esempio, che rubava e assassinava, diveniva facilmente oggetto di un odio particolare: egli aveva voluto ritorcere contro i più sfavoriti un illegalismo che era integrato alle loro condizioni di esistenza. Così attorno ai crimini si annodavano la glorificazione e il biasimo; l'aiuto effettivo e la paura si alternavano nei confronti di questa popolazione fluida, di cui ci si sapeva tanto vicini, ma da cui, lo si sentiva chiaramente, poteva nascere il delitto. L'illegalismo popolare si avviluppava ad un nucleo di criminalità che ne era insieme la forma estrema ed il pericolo interno.
Tra questo illegalismo dei bassi ceti e quello delle altre caste sociali, non esisteva né una completa convergenza, né una opposizione di fondo. In linea generale, i differenti illegalismi propri a ciascun gruppo mantenevano fra loro rapporti che erano insieme di rivalità, di concorrenza, di conflitti d'interesse, di appoggio reciproco, di complicità: il rifiuto dei contadini di pagare certi canoni statuali o ecclesiastici non era necessariamente malvisto dai proprietari terrieri; la non-applicazione da parte degli artigiani dei regolamenti di fabbrica era incoraggiata spesso dai nuovi imprenditori; il contrabbando - la storia di Mandrin accolto da tutta la popolazione, ricevuto nei castelli e protetto dai parlamentari, lo prova - era largamente sostenuto. Al limite, nel secolo Sedicesimo, si erano visti i differenti rifiuti fiscali coalizzare in gravi rivolte strati di popolazione assai distanti gli uni dagli altri. In breve, il gioco reciproco degli illegalismi faceva parte della vita politica ed economica della società. Meglio ancora: un certo numero di trasformazioni (la desuetudine, ad esempio, dei decreti di Colbert, l'inosservanza delle pastoie doganali, nel regno, la dislocazione di regole corporative) si era operato nella breccia quotidianamente allargata dall'illegalismo popolare; e di queste trasformazioni la borghesia aveva avuto bisogno e su di esse aveva fondato una parte della crescita economica. La tolleranza diveniva allora incoraggiamento.
Ma nella seconda metà del secolo Diciottesimo, il processo tende ad invertirsi. Prima di tutto con l'aumento generale della ricchezza, ma anche a motivo della grande spinta demografica, il bersaglio principale dell'illegalismo popolare tendono ad essere, in prima linea, non più i diritti, ma i beni: le ruberie, i furti, tendono a sostituire il contrabbando e la lotta armata contro gli agenti della finanza. E in questa dimensione, contadini, fattori, artigiani si trovano spesso ad essere le vittime principali. Le Trosne non faceva che esagerare una situazione tuttavia reale, quando descriveva i contadini sofferenti per le esazioni dei vagabondi, ancor più che non un tempo per le esigenze dei feudatari: i ladri si sarebbero oggi abbattuti su di loro come una nube di insetti malefici, divorando i raccolti, annientando i granai (24). Possiamo dire che, nel secolo Diciottesimo si era progressivamente aperta una crisi dell'illegalismo popolare; e né i movimenti dell'inizio della Rivoluzione (circa il rifiuto dei diritti signorili) né quelli più tardivi, dove venivano a congiungersi la lotta contro i diritti dei proprietari, la protesta politica e religiosa, il rifiuto della coscrizione, l'hanno, in effetti, risaldata sotto la forma antica ed accogliente. In più, se buona parte della borghesia aveva accettato senza troppi problemi l'illegalismo dei diritti, lo sopportava invece male quando si trattava di quelli che essa considerava come suoi diritti di proprietà. Niente è più caratteristico a questo proposito del problema della delinquenza contadina alla fine del secolo Diciottesimo e soprattutto a partire dalla Rivoluzione (25). Il passaggio ad una agricoltura intensiva esercita sui diritti di uso, le tolleranze, i piccoli illegalismi accettati, una pressione sempre più rigida. In più, acquisita in parte dalla borghesia, spogliata dai carichi feudali, la proprietà terriera è divenuta una proprietà assoluta: tutte le tolleranze che i contadini avevano acquisite o conservate (abbandono di antichi obblighi o consolidamento di pratiche irregolari: diritto di pascolo dopo la prima fienagione, raccolta di legna, eccetera) sono ora perseguiti dai nuovi proprietari che attribuiscono loro lo "status" di infrazione pura e semplice (generando così nella popolazione una serie di reazioni a catena, sempre più illegali o, se vogliamo, sempre più delittuose: abbattimento di recinti, furto o massacro di animali, incendi, violenze, assassini) (26). L'illegalismo dei diritti che assicurava spesso la sopravvivenza dei più poveri, tende, col nuovo "status" della proprietà, a divenire un illegalismo di beni. Bisognerà allora punirlo.
E questo illegalismo, se è mal sopportato dalla borghesia nei riguardi della proprietà fondiaria, diviene intollerabile nei riguardi della proprietà commerciale e industriale: lo sviluppo dei porti, l'apparizione dei grandi depositi dove si accumulano le merci, l'organizzazione di laboratori di vaste dimensioni (con una massa considerevole di materie prime, di utensili, di oggetti manufatti, che appartengono all'imprenditore e che sono difficili da sorvegliare) necessitano anch'essi una repressione rigorosa dell'illegalismo. Il modo in cui tende ad essere investita la ricchezza, secondo scale quantitative del tutto nuove, in merci ed in macchinari, presuppone una repressione sistematica e armata all'illegalismo. Il fenomeno è evidentemente molto sensibile là dove lo sviluppo economico è più intenso. Dell'urgenza di reprimere le innumerevoli pratiche illecite, Colquhoun aveva iniziato a dare, per la sola città di Londra, le prove in cifre: secondo le stime degli imprenditori e degli assicuratori, il furto di prodotti importati dall'America e depositati sulle rive del Tamigi si elevava, un anno per l'altro, a 250000 sterline; in totale, si rubava press'a poco per 500000 sterline ogni anno, nel solo porto di Londra (e senza tener conto degli arsenali), cui bisognava aggiungere 700000 sterline per la città. In questo saccheggio permanente, tre fenomeni, secondo Colquhoun, sarebbero da prendere in considerazione: la complicità e spesso la partecipazione attiva di impiegati, sorveglianti, capireparto e operai: «tutte le volte che una grande quantità di operai sarà riunita nello stesso luogo, vi si troveranno necessariamente molti cattivi soggetti»; l'esistenza di tutta un'organizzazione del commercio illecito, che inizia nei depositi o sui docks, passa attraverso i ricettatori - ricettatori in grande, specializzati in certi tipi di merce e ricettatori al dettaglio, le cui mostre offrono solo «una miserabile accozzaglia di ferri vecchi, stracci, brutti abiti», mentre il retrobottega nasconde «munizioni navali del più alto valore, bulloni e chiodi di rame, lingotti di ghisa e di metalli preziosi di produzione delle Indie occidentali, mobili e vestiti comperati da operai di ogni specie» - poi ai rivenditori che distribuiscono, nelle campagne, il prodotto dei furti (27); infine la fabbricazione di moneta falsa (ci sarebbero state, disseminate in tutta l'Inghilterra, da quaranta a cinquanta fabbriche di moneta falsa che lavoravano in permanenza). Ora, ciò che facilita questa immensa impresa di depredazione e di concorrenza insieme, è tutto un complesso di tolleranze: le une valgono come una sorta di diritti acquisiti (diritto, ad esempio, di raccogliere intorno alle navi i pezzi di ferro o di cordami o di rivendere le scope di canna da zucchero); altre sono dell'ordine dell'accettazione morale: l'analogia che, nello spirito dei suoi autori, questo saccheggio ha col contrabbando li «familiarizza con questa specie di delitti di cui non avvertono minimamente l'enormità» (28).
E' dunque necessario controllare e ricodificare tutte queste pratiche illecite. E' necessario che le infrazioni siano ben definite e sicuramente punite, che in questa massa di irregolarità tollerate e sanzionate in modo discontinuo, con risonanza sproporzionata, vengano determinate quelle che sono infrazioni non tollerabili, e che queste subiscano un castigo cui sia impossibile sfuggire. Con le nuove forme di accumulazione del capitale, di rapporti di produzione, di stato giuridico della proprietà, tutte le pratiche popolari che si rifacevano sia sotto forma tacita, quotidiana, tollerata, sia sotto forma violenta all'illegalismo dei diritti, vengono riversate di forza sull'illegalismo dei beni. Il furto tende a divenire la prima grande scappatoia alla legalità, in questo moto che fa passare da una società del prelevamento giuridico-politico ad una società dell'appropriazione dei mezzi e dei prodotti del lavoro. Possiamo dire le cose in altro modo: l'economia dell'illegalismo si è ristrutturata con lo sviluppo della società capitalistica. L'illegalismo dei beni viene separato da quello dei diritti. Divisione che ricopre un'opposizione di classe, poiché, da una parte l'illegalismo più accessibile alle classi popolari sarà quello dei beni - trasferimento violento delle proprietà; mentre dall'altro la borghesia riserverà, per sé, l'illegalismo dei diritti: la possibilità di giocare i propri regolamenti e le proprie leggi; di far assicurare tutto un immenso settore della circolazione economica da un gioco che si svolge ai margini della legislazione - margini previsti dai suoi silenzi o allargati da una tolleranza di fatto. E questa grande ridistribuzione dell'illegalismo si tradurrà in una specializzazione dei circuiti giudiziari: per l'illegalismo di beni - per il furto -, tribunali ordinari e castighi; per l'illegalismo di diritti - frodi, evasioni fiscali, operazioni commerciali irregolari - giurisdizioni speciali con transazioni, accomodamenti, ammende attenuate, eccetera. La borghesia si è riservata il dominio fecondo dell'illegalismo dei diritti. E nello stesso tempo in cui si opera questa spartizione, si afferma la necessità di un controllo costante che riguardi essenzialmente questo illegalismo dei beni. Si afferma la necessità di congedare l'antica economia del potere di punire che aveva come principi la molteplicità confusa e lacunosa delle istanze, una ripartizione ed una concentrazione di potenza correlative ad un'inerzia di fatto e ad una inevitabile tolleranza, castighi clamorosi nelle loro manifestazioni e rischiosi nella loro applicazione. Si afferma la necessità di definire una strategia e delle tecniche di punizione in cui un'economia della continuità e della permanenza sostituirà quella dello sperpero e dell'eccesso. Insomma, la riforma penale è nata nel punto di giunzione tra la lotta contro il superpotere del sovrano e quella contro l'infrapotere degl'illegalismi conquistati e tollerati. E se è stata cosa diversa dal risultato provvisorio di un incontro di pura circostanza, è perché tra quel superpotere e quell'infrapotere si era annodata tutta una rete di rapporti. La forma della sovranità monarchica, pur ponendo dalla parte del sovrano il sovraccarico di un potere splendente, illimitato, personale, irregolare e discontinuo, lasciava, dalla parte dei sudditi, il posto libero ad un costante illegalismo, che era come il correlativo di quel tipo di potere. Così che attaccare le diverse prerogative del sovrano, era attaccare nel medesimo tempo il funzionamento degli illegalismi: i due obiettivi non avevano soluzione di continuità. E secondo le circostanze o le tattiche particolari, i riformatori facevano passare l'uno avanti all'altro. Le Trosne, questo fisiocrate che fu consigliere al tribunale di presidio di Orléans, può servirci d'esempio. Nel 1764, egli pubblica una memoria sul vagabondaggio: vivaio di ladri e di assassini «che vivono in mezzo alla società senza esserne membri», che «conducono un'autentica guerra a tutti i cittadini» e che sono in mezzo a noi «in quello stato che si suppone aver avuto luogo prima dello stabilirsi della società civile». Contro di essi, chiede le pene più severe (in modo assai caratteristico, si meraviglia che si sia più indulgenti verso di loro che non verso i contrabbandieri); vuole che la polizia sia rinforzata, che la polizia a cavallo (29) li persegua con l'aiuto della popolazione che soffre per i loro furti; chiede che queste persone inutili e pericolose «siano acquisite allo Stato e gli appartengano come schiavi ai loro padroni»; e, in caso di necessità, si organizzino battute collettive nei boschi per snidarli, e chiunque faccia una cattura riceva un salario: «Si dà pure una ricompensa di 10 lire per ogni testa di lupo. Un vagabondo è infinitamente più pericoloso per la società» (30). Nel 1777, nelle "Vues sur la justice criminelle", lo stesso Le Trosne chiede che siano ridotte le prerogative della parte pubblica, che gli accusati siano considerati innocenti fino all'eventuale condanna, che il giudice sia un giusto arbitro fra loro e la società, che le leggi siano «fisse, costanti, determinate nella maniera più precisa», in modo che i sudditi sappiano «a cosa si espongono» ed i magistrati non siano niente di più che «organi della legge» (31). In Le Trosne, come in tanti altri dello stesso periodo, la lotta per la delimitazione del potere di punire si articola direttamente sull'esigenza di sottomettere l'illegalismo popolare ad un controllo più stretto e più costante. Si capisce come la critica dei supplizi abbia avuto una tale importanza nella riforma penale: era infatti la figura dove venivano a congiungersi, in modo visibile, il potere illimitato del sovrano e l'illegalismo sempre vigile del popolo. L'umanità delle pene è la regola che vien data ad un regime di punizioni che deve fissare i rispettivi limiti. L'«uomo» che si vuole far rispettare nella pena, è la forma giuridica e morale data a questa duplice delimitazione.
Ma se è vero che la riforma, come teoria penale e come strategia del potere di punire, è stata disegnata nel punto di coincidenza di questi due obiettivi, la sua stabilità fu dovuta al fatto che il secondo prese, e a lungo, un rango prioritario. E' perché la pressione sugl'illegalismi popolari divenne all'epoca della Rivoluzione, poi sotto l'Impero e infine durante tutto il secolo Diciannovesimo un imperativo essenziale, che la riforma poté passare dallo stato di progetto a quello di istituzione e di meccanismo pratico. Ciò vuol dire che se, in apparenza, la nuova legislazione criminale si caratterizza per un alleggerimento delle pene, una codificazione più netta, una notevole diminuzione dell'arbitrarietà, un consenso più fondato al potere di punire (in mancanza di una divisione più reale del suo esercizio), essa è sottesa da un rovesciamento nell'economia tradizionale degl'illegalismi e da una rigorosa costrizione per mantenere il loro nuovo assetto. Bisogna concepire un sistema penale come un meccanismo per gestire gl'illegalismi in modo differenziato e non per sopprimerli tutti.
Spostare l'obiettivo e cambiarne la scala. Definire nuove tattiche per raggiungere un bersaglio che è ora più ristretto ma assai più largamente diffuso nel corpo sociale. Trovare nuove tecniche per applicarvi le punizioni ed adattarvi gli effetti. Porre nuovi principi per regolarizzare affinare universalizzare l'arte di castigare. Omogeneizzare il suo esercizio. Diminuire il suo costo economico e politico aumentandone l'efficacia e moltiplicandone i circuiti. In breve, costituire una nuova economia ed una nuova tecnologia del potere di punire: sono queste senza dubbio le ragioni d'essere essenziali della riforma penale del secolo Diciottesimo.
A livello di principi, questa nuova strategia si può facilmente formulare nella teoria generale del contratto. Si presume che il cittadino abbia accettato una volta per tutte, insieme alle leggi della società, anche quella stessa che rischia di punirlo. Il criminale appare allora come un essere giuridicamente paradossale: egli ha rotto il patto, dunque è nemico dell'intera società, e tuttavia partecipa alla punizione che subisce. Il minimo delitto attacca tutta la società; e tutta la società - ivi compreso il criminale - è presente anche nella minima punizione. Il castigo penale è dunque una funzione generalizzata, coestensiva al corpo sociale e a tutti i suoi elementi. Si pone allora il problema della «misura» e dell'economia del potere di punire.
In effetti, l'infrazione oppone un individuo all'intero corpo sociale. Lotta ineguale: da una sola parte tutte le forze, tutta la potenza, tutti i diritti. Ed è necessario sia proprio così, ne va della sicurezza di ciascuno. Si costituisce allora un formidabile diritto di punire, poiché colui che commette un'infrazione diviene il nemico comune. Peggio di un nemico, perfino, poiché è dall'interno della società che egli porta i suoi colpi - un traditore: un «mostro». Su di lui, come non avrebbe la società un diritto assoluto? Come potrebbe non chiederne la soppressione pura e semplice? E se è vero che il principio dei castighi deve essere sottoscritto nel patto, non è forse necessario, in piena logica, che tutti i cittadini accettino la pena estrema per quelli fra loro che li attaccano? «Ogni malfattore che attacca il diritto sociale, diviene, con i suoi misfatti, ribelle e traditore della patria; allora la conservazione dello Stato è incompatibile con la sua; bisogna che uno dei due perisca, e quando si fa perire il colpevole è meno come cittadino che non come nemico» (32). Il diritto di punire è stato spostato dalla vendetta del sovrano alla difesa della società. Ma si trova allora composto da elementi così forti, da divenire più temibile. Si è strappato il malfattore ad una minaccia, per natura, eccessiva, ma lo si espone ad una pena di cui non si vede alcun possibile limite. Ritorno di un superpotere terribile. Necessità, allora, di porre alla potenza del castigo un principio di moderazione.
«Chi non ha brividi d'orrore vedendo nella storia tanti tormenti spaventosi ed inutili, inventati ed impiegati freddamente da mostri che si dànno il nome di saggi?» (33). O ancora: «Le leggi mi chiamano al castigo del più grande fra i crimini. Io ci vado con tutti i furori che esso mi ha ispirato? Ma che cosa accade? Esse lo sorpassano ancora... Dio che hai impresso nei nostri cuori l'avversione al dolore nostro e dei nostri simili, sono dunque questi esseri, che tu hai creato così deboli e sensibili, ad aver inventato supplizi così barbari e raffinati?» (34). Il principio della moderazione delle pene, anche quando si tratta di castigare il nemico del corpo sociale, si articola prima di tutto come un discorso di cuore. Meglio, esso sgorga come un grido del corpo che si rivolta alla vista o alla immaginazione di troppe crudeltà. La formulazione del principio che la pena deve restare «umana» vien fatto dai riformatori in prima persona, come se si esprimesse immediatamente la sensibilità di colui che parla; come se il corpo del filosofo e del teorico venisse ad affermare, tra l'accanimento del boia ed il suppliziato, la sua propria legge e ad imporla finalmente a tutta l'economia delle pene. Lirismo che manifesta l'impotenza a trovare il fondamento razionale di un calcolo penale? Tra il principio contrattuale che respinge il criminale fuori della società e l'immagine del mostro «vomitato» dalla natura, dove trovare un limite se non in una natura umana che si manifesta - non nel rigore della legge, non nella ferocia del delinquente - ma nella sensibilità dell'uomo ragionevole che fa la legge e non commette crimini?
Questo ricorso alla «sensibilità» non traduce tuttavia una impossibilità teorica. In realtà esso comporta un principio di calcolo. Il corpo, l'immaginazione, la sofferenza, il cuore da rispettare, non sono in effetti quelli del criminale da punire, ma quelli degli uomini che, avendo sottoscritto il patto, hanno il diritto di esercitare contro di lui il potere di unirsi. Le sofferenze che l'addolcimento delle pene deve escludere, sono quelle dei giudici e degli spettatori, con tutto ciò che possono portare con sé di indurimento, di ferocia indotta dalla abitudine, o, al contrario, di pietà non dovuta, di indulgenza poco fondata: «Grazia per queste anime dolci e sensibili sulle quali questi orribili supplizi esercitano una specie di tortura» (35). Ciò che è necessario regolare e calcolare sono gli effetti di ritorno del castigo sull'istanza che punisce e sul potere che pretende di esercitare.
Qui, si radica il principio che non bisogna mai applicare altro che punizioni «umane», sia pure ad un criminale che può essere un traditore ed un mostro. Se la legge deve trattare «umanamente» colui che è «fuori natura» (mentre la giustizia d'altri tempi trattava in modo inumano il «fuorilegge»), la ragione non si trova in una umanità profonda che il criminale nasconderebbe in se stesso, ma nella necessaria regolazione degli effetti del potere. E' questa razionalità «economica» che deve misurare la pena e prescriverne le tecniche adeguate. «Umanità» è il rispettoso nome dato a questa economia ed ai suoi calcoli minuziosi. «In fatto di pena, il minimo è ordinato dall'umanità e consigliato dalla politica».
Per comprendere questa tecno-politica della punizione, sia il caso limite, l'ultimo dei crimini: un misfatto enorme, che violasse tutte insieme le più rispettate fra le leggi. Si sarebbe prodotto in circostanze così straordinarie, in un segreto così profondo, con una tale dismisura, e come al limite così estremo di ogni possibilità, da non poter essere che il solo e in ogni caso l'ultimo della sua specie: nessuno potrebbe mai imitarlo; nessuno potrebbe prenderlo ad esempio; e neppure scandalizzarsi che sia stato commesso: esso sarebbe votato a scomparire senza lasciare traccia. Questo apologo (37) della «estremità del crimine» è un po', nella nuova penalità, quello che era il peccato originale nell'antica: la forma pura dove appare la ragione delle pene.
Un tale crimine, dovrebbe essere punito? Secondo quale misura? Di quale utilità potrebbe essere la sua punizione nell'economia del potere di punire? Sarà utile nella misura in cui potrebbe riparare al «male fatto alla società» (38). Ora se mettiamo da parte il danno propriamente materiale - che, anche irreparabile come in un assassinio, è di poco peso a scala di un'intera società - il torto che il crimine fa al corpo sociale è il disordine che vi introduce: lo scandalo che suscita, l'esempio che dà, l'incitamento a ricominciare se non viene punito, la possibilità di generalizzazione che porta in sé. Per essere utile il castigo deve avere come obiettivo le conseguenze del delitto, intese come la serie di disordini che è capace di aprire. «La proporzione tra la pena e la qualità del delitto è determinata dall'influenza che ha sull'ordine sociale il patto che viene violato» (39). Ora, l'influenza di un crimine non è forzatamente in proporzione diretta alla sua atrocità; un crimine che spaventa la coscienza ha spesso minor effetto di un misfatto che tutti tollerano e si sentono pronti ad imitare a loro volta. Rarità dei grandi crimini; pericolo, in cambio, di piccoli misfatti famigliari che si moltiplicano. Non si deve cercare, di conseguenza, una relazione qualitativa tra il delitto e la sua punizione, un'equivalenza di orrore: «Le grida di un disgraziato nei tormenti, possono richiamare, dal seno del passato che non ritorna più, un'azione già commessa?» (40). Calcolare una pena in funzione non del crimine, ma della sua possibile ripetizione. Non mirare all'offesa passata, ma al disordine futuro. Fare sì che il malfattore non possa avere né la voglia di ricominciare, né la possibilità di avere imitatori (41).
Punire sarà dunque un'arte degli effetti; piuttosto che opporre l'enormità della pena all'enormità dell'errore, bisogna adattare l'una all'altra le due serie che seguono il delitto: gli effetti propri e quelli della pena. Un delitto senza dinastia non richiede alcun castigo. Non più - secondo un'altra versione del medesimo apologo - di quanto, alla vigilia di dissolversi e di sparire, una società abbia il diritto di innalzare patiboli. L'ultimo dei crimini non può che restare impunito.
Vecchia concezione: non era necessario attendere la riforma del secolo Diciottesimo per evidenziare questa funzione esemplare del castigo. Che la punizione riguardi l'avvenire e che una almeno delle sue funzioni principali sia prevenire, era, da secoli, una giustificazione corrente del diritto di punire. Ma la differenza è che la prevenzione che ci si attendeva come effetto del castigo e della sua risonanza - dunque della sua dismisura -, tende a divenire ora il principio della sua economia e la misura delle sue giuste proporzioni. Bisogna punire esattamente abbastanza per impedire. Spostamento dunque nella meccanica dell'esempio: in una penalità di supplizio, l'esempio era la replica del crimine; doveva, per una sorta di manifestazione gemellata, mostrarlo e mostrare nel medesimo tempo il potere sovrano che lo dominava; in una penalità calcolata a misura dei suoi effetti, l'esempio deve rinviare al delitto, ma nel modo più discreto possibile, indicare l'intervento del potere ma con la maggiore economia e, nel caso ideale, impedire ogni ulteriore riapparizione dell'una e dell'altro. L'esempio non è più un rituale che manifesta, è un segno che ostacola. Attraverso questa tecnica dei segni punitivi, che tende ad invertire tutto il campo temporale della azione penale, i riformatori pensano di dare al potere di punire uno strumento economico, efficace, generalizzabile attraverso tutto il corpo sociale, suscettibile di codificare tutti i comportamenti e, di conseguenza, di ridurre tutto il diffuso dominio delle illegalità. La semio-tecnica di cui si cerca di armare il potere di punire riposa su cinque o sei regole principali.
"Regola della quantità minimale". Un delitto viene commesso perché procura dei vantaggi. Se legassimo all'idea del delitto l'idea di uno svantaggio un po' più grande, esso cesserebbe di essere desiderabile. «Perché il castigo produca l'effetto che ci si deve attendere basta che il male che esso produce sorpassi il bene che il colpevole ha ricavato dal delitto» (42). Si può, si deve, ammettere un nesso fra pena e delitto, ma non più sotto la forma antica, in cui il supplizio doveva equivalere al crimine in intensità, con un supplemento che segnava il «più di potere» del sovrano che compiva la sua legittima vendetta. C'è una quasi-equivalenza a livello degli interessi: un piccolo più di interesse ad evitare la pena che a rischiare il delitto.
"Regola dell'idealizzazione sufficiente". Se il motivo di un delitto è il vantaggio che ci si rappresenta, l'efficacia della pena è nello svantaggio che ci si attende. Ciò che fa della «pena» il cuore della punizione non è la sensazione di sofferenza, ma l'idea di un dolore, di un dispiacere, di un inconveniente - la «pena» dell'idea della «pena». Dunque la punizione non deve porre in opera il corpo, ma la rappresentazione. O piuttosto, se deve porre in opera il corpo, è nella misura in cui esso è meno il soggetto di una sofferenza che non l'oggetto di una rappresentazione: il ricordo di un dolore può impedire la recidiva, come lo spettacolo, sia pure artificiale, di una pena fisica, può prevenire il contagio di un delitto. Non sarà il dolore in se stesso, lo strumento della tecnica punitiva. Dunque, quanto più è possibile, e salvo il caso in cui si tratti di suscitare una rappresentazione efficace, inutile dispiegare la grande panoplia dei patiboli. Elisione del corpo come soggetto della pena, ma non forzatamente come elemento in uno spettacolo. Il rifiuto dei supplizi che, all'inizio della teoria, aveva trovato solo una formulazione lirica, incontra qui la possibilità di articolarsi razionalmente: ciò che deve essere massimalizzato è la rappresentazione della pena, non la sua realtà corporale.
"Regola degli effetti laterali". La pena deve produrre gli effetti più intensi presso coloro che non hanno commesso l'errore; al limite, quando si potesse essere certi che il colpevole non possa ricominciare, sarebbe sufficiente far credere agli altri che è stato punito. Intensificazione centrifuga degli effetti che conduce al paradosso per cui, nel calcolo delle pene, l'elemento meno interessante è ancora il colpevole (salvo quando sia suscettibile di recidiva). Questo paradosso, Beccaria l'ha illustrato nel castigo che proponeva in sostituzione della pena di morte: schiavitù perpetua. Pena fisicamente più crudele della morte? Per nulla, egli diceva, perché il dolore della schiavitù è per il condannato diviso in altrettante particelle quanti sono gli istanti che gli restano da vivere; pena indefinitamente divisibile, pena eleatica, assai meno severa del castigo capitale che d'un colpo raggiunge il supplizio. In cambio, per coloro che vedono o si rappresentano questi schiavi, le sofferenze da sopportare sono riunite in una sola idea; tutti gli istanti della schiavitù si concentrano in una rappresentazione che diviene allora più spaventevole della idea della morte. E' la pena economicamente ideale: è minimale per colui che la subisce (e che, ridotto in schiavitù, non può recidivare) e massimale per colui che se la rappresenta. «Tra le pene e il modo di applicarle in proporzione ai delitti, bisogna scegliere i mezzi che faranno sullo spirito del popolo l'impressione più efficace e più durevole, e nello stesso tempo la meno crudele sul corpo del condannato» (43).
"Regola della certezza perfetta". Bisogna che all'idea di ogni delitto e dei vantaggi che ci si attendono, sia associata l'idea di un determinato castigo, con gli inconvenienti precisi che ne risultano; bisogna che dall'uno all'altro il legame sia considerato come necessario e che niente lo possa rompere. Questo elemento generale della certezza, che deve conferire al sistema punitivo la sua efficacia, implica un certo numero di misure precise. Che le leggi che definiscono i delitti e prescrivono le pene siano perfettamente chiare, «affinché ogni membro della società possa distinguere le azioni criminali dalle azioni virtuose» (44). Che le leggi siano pubblicate e ciascuno possa averne l'accesso; finite le tradizioni orali e le consuetudini, ma una legislazione scritta, che sia «il monumento stabile del patto sociale», testi stampati, portati a conoscenza di tutti: «Solo la stampa può rendere tutti, e non solo alcuni pochi, depositari del codice sacro delle leggi» (45). Che il monarca rinunci al suo dritto di grazia, perché la forza che è presente nell'idea della pena non sia attenuata dalla speranza di questo intervento: «Se si lascia vedere agli uomini che il delitto può essere perdonato e che il castigo non ne è il necessario seguito, si nutre in essi la speranza dell'impunità... che le leggi siano inesorabili, gli esecutori inflessibili»(46). E soprattutto che nessun delitto commesso sfugga allo sguardo di coloro che devono rendere giustizia; niente rende più fragile l'apparato delle leggi che la speranza dell'impunità; come si potrebbe stabilire nello spirito dei rei potenziali uno stretto legame tra un misfatto e una pena, se un certo coefficiente di improbabilità venisse a lederlo? Non bisognerebbe allora rendere la pena tanto più temibile per la sua violenza, quanto essa è meno da temere per la sua scarsa certezza? Piuttosto che imitare così l'antico sistema ed essere «più severi, bisogna essere più vigilanti» (47). Da qui l'idea che l'apparato della giustizia deve essere affiancato da un organo di sorveglianza, direttamente coordinato, che permetta sia di impedire i delitti, sia, quando vengano commessi, di arrestarne gli autori; polizia e giustizia devono camminare insieme come le due azioni complementari di un medesimo processo - assicurando la polizia «l'azione della società su ogni individuo», la giustizia «i diritti degli individui di contro alla società» (48); così ogni delitto apparirà alla luce del giorno e sarà punito in piena certezza. Ma è anche necessario che le procedure non restino segrete, che le ragioni per le quali un accusato è stato condannato o assolto siano conosciute da tutti, e che ciascuno possa individuare le ragioni del punire: «Che il magistrato pronunci il suo parere ad alta voce, che sia obbligato a riportare nel suo giudizio il testo della legge che condanna il colpevole... che le procedure, ora seppellite misteriosamente nell'oscurità delle cancellerie, siano aperte a tutti i cittadini che si interessano alla sorte dei condannati» (49).
"Regola della verità comune". Sotto questo principio molto banale si cela una trasformazione importante. L'antico sistema delle prove legali, l'uso della tortura, l'estorsione della confessione, l'utilizzazione del supplizio, del corpo e dello spettacolo per la riproduzione della verità, avevano a lungo isolata la pratica penale dalle comuni forme di dimostrazione: mezze-prove facevano mezze-verità e mezzi colpevoli, frasi strappate con la sofferenza avevano valore di autentificazione; una presunzione generava un grado di pena. Sistema di cui l'eterogeneità rispetto al regime ordinario della prova ha costituito veramente uno scandalo solo dal giorno in cui il potere di punire ha avuto bisogno, per la sua propria economia, di un clima di certezza irrefutabile. Come legare in modo assoluto nello spirito degli uomini l'idea del delitto e quella del castigo, se la realtà del castigo non segue, in ogni caso, la realtà del misfatto? Stabilire questa in tutta evidenza e secondo mezzi valevoli per tutti diviene compito primario. La verifica del delitto deve obbedire ai criteri generali di ogni verità. Il giudizio della giustizia, negli argomenti che impiega, e nelle prove che apporta, deve essere omogeneo al giudizio puro e semplice. Dunque, abbandono delle prove legali; rifiuto della tortura, necessità di una dimostrazione completa per ottenere una verità giusta, annullamento di ogni correlazione tra i gradi del sospetto e quelli della pena. Come una verità matematica, la verità del delitto potrà essere ammessa solo quando interamente provata. Ne segue che, fino alla dimostrazione finale del suo delitto, l'accusato deve essere considerato innocente; e che per fare una dimostrazione, il giudice deve utilizzare non forme rituali, ma strumenti comuni, quella ragione di tutti, che è anche quella dei filosofi e dei sapienti: «In teoria, io considero il magistrato come un filosofo che si propone di scoprire una verità interessante... La sua sagacia gli farà cogliere tutte le circostanze e tutti i rapporti, avvicinare o separare ciò che deve esserlo per giudicare sanamente» (50). L'inchiesta, esercizio della ragione comune, si spoglia dell'antico modello inquisitoriale, per accogliere quello assai più duttile (e doppiamente convalidato dalla scienza e dal senso comune) della ricerca empirica. Il giudice sarà come un «pilota che naviga fra le rocce»: «Quali saranno le prove o di quali indizi ci si potrà accontentare? E' ciò che né io né alcun altro ha ancora osato determinare in generale; le circostanze essendo soggette a variare all'infinito, le prove e gli indizi dovendo dedursi da quelle circostanze, bisogna necessariamente che gli indizi e le prove, le più chiare, varino in proporzione» (51). Ormai la pratica penale si trova ad essere sottomessa al regime comune della verità, o piuttosto ad un regime complesso in cui si concatenano, per formare l'«intimo convincimento» del giudice, elementi eterogenei di dimostrazione scientifica, di evidenza sensibile, e di senso comune. La giustizia penale, se mantiene forme che ne garantiscono l'equità, può aprirsi ora a verità di ogni provenienza, purché siano evidenti, ben stabilite, accettabili per tutti. Il giudizio penale non è più, in se stesso, generatore di una verità a parte: viene posto di nuovo nel campo di riferimento delle prove comuni. Si intreccia allora, con la molteplicità dei discorsi scientifici, un rapporto difficile e infinito, che la giustizia penale non è pronta a controllare. Chi governa la giustizia non governa più la sua verità.
"Regola della specificazione ottimale". Perché la semeiotica penale ricopra efficacemente l'intero campo degli illegalismi che si vogliono dominare, è necessario che tutte le infrazioni siano qualificate, classificate, riunite in specie, senza lasciarne sfuggire alcuna. Un codice è dunque necessario, e dev'essere sufficientemente preciso perché ogni tipo di infrazione possa esservi presente in modo chiaro. Nel silenzio della legge, non bisogna possa sedimentare la speranza dell'impunità. E' necessario un codice esaustivo ed esplicito, che definisca i delitti, fissando le pene (52). Ma l'imperativo stesso di ricoprire integralmente con gli effetti-segno la punizione, obbliga ad andare più lontano. L'idea di un medesimo castigo non ha la medesima forza per tutti; l'ammenda non è temibile per il ricco, né l'infamia a chi vi è già stato esposto. La nocività di un delitto e il suo valore di induzione non sono gli stessi, in rapporto allo "status" di chi commette l'infrazione: il delitto di un nobile è più nocivo per la società di quello di un uomo del popolo (53). Infine, poiché il castigo deve impedire la recidiva, bisogna pur che tenga conto di quello che è nella sua natura profonda il criminale, il grado presumibile della sua cattiveria, la qualità intrinseca della sua volontà: «Di due uomini che hanno commesso lo stesso furto, quanto colui che aveva appena il necessario è meno colpevole di quello che rigurgitava del superfluo? Tra due spergiuri, quanto colui sul quale si lavorò fin dall'infanzia ad imprimere sentimenti di onore è più criminale di colui che, abbandonato alla natura, non ricevette mai educazione?» (54). Vediamo sorgere, insieme alla necessità di una classificazione parallela dei delitti e dei castighi, la necessità di una individualizzazione delle pene, conforme ai caratteri peculiari di ogni criminale. Individualizzazione che, radicandosi in questa nuova necessità, graverà pesantemente su tutta la storia del diritto penale moderno. Senza dubbio, in termini di teoria del diritto e secondo le esigenze della pratica quotidiana, essa è in opposizione radicale col principio della codificazione, ma dal punto di vista di una economia del potere di punire e delle tecniche per cui si vogliono mettere in circolazione, in tutto il corpo sociale, segni di punizione esattamente centrati, senza eccessi né lacune, senza inutile «spesa» del potere ma senza timidezza, si vede bene come la codificazione del sistema delitti-castighi e la modulazione della coppia criminale-punizione vadano di pari passo e si chiamino l'un l'altra. L'individualizzazione appare come l'ultimo scopo di un codice esattamente calibrato.
Tale individualizzazione è assai differente, nella sua natura, dalle modulazioni della pena che si trovavano nella giurisprudenza antica. Questa - in ciò conforme alla pratica penitenziaria cristiana - utilizzava, per centrare il castigo, due serie di variabili, quella della «circostanza» e quella dell'«intenzione». Ossia elementi che permettono di qualificare l'atto in se stesso. La modulazione della pena derivava dalla «casistica» in senso lato (55); mentre ciò che ora comincia a disegnarsi, è una modulazione che si riferisce al soggetto che commette l'infrazione, alla sua natura, al suo modo di vivere e di pensare, al suo passato, alla «qualità» e non più all'intenzione della sua volontà. Si scorge, ma come un posto lasciato ancor vuoto, il luogo in cui, nella pratica penale, il sapere psicologico darà il cambio alla giurisprudenza casistica, anche se, in questo scorcio del secolo Diciottesimo, siamo ancora ben lontani da questo momento. Il legame codice-individualizzazione viene ricercato nei modelli scientifici dell'epoca. La storia naturale offriva senza dubbio lo schema più adeguato: la tassinomia delle specie secondo una graduazione ininterrotta. Si cerca di costituire un Linneo dei delitti e delle pene, in modo che ogni infrazione particolare, ed ogni individuo punibile, possano cadere, senza alcun arbitrio, sotto il dominio di una legge generale. «Bisogna comporre una tavola di tutti i generi di delitti che si rinvengono nei diversi paesi. Dalla numerazione dei delitti, bisognerà ricavare una divisione in specie. La regola migliore per questa divisione è, mi sembra, il separare i delitti secondo le differenze dei loro oggetti. Questa divisione deve essere tale che ogni specie sia ben distinta dall'altra e che ogni delitto particolare, considerato in tutti i suoi rapporti, sia posto tra quello che lo deve precedere e quello che lo deve seguire, e nella più giusta gradazione; bisogna infine che questa tavola sia tale da poter essere avvicinata ad un'altra tavola che verrà fatta per le pene in modo che possano corrispondere esattamente l'una all'altra» (56). In teoria, o piuttosto come utopia, la doppia tassinomia dei castighi e dei delitti può risolvere il problema: come applicare leggi fisse a singoli individui?
Ma, in quella stessa epoca, lontano da questo modello speculativo, nuove forme di individualizzazione antropologica, andavano costituendosi, sia pure in modo ancora molto grossolano. Prima di tutto con la nozione di recidiva. Non certamente sconosciuta alle antiche leggi criminali (57), tende ora a divenire una qualificazione del delinquente stesso, suscettibile di modificare la pena inflitta: secondo la legislazione del 1791, i recidivi erano passibili, in quasi tutti i casi, di un raddoppio della pena; secondo la legge di Floreale anno decimo, dovevano essere marchiati con una R; mentre il codice penale del 1810 infliggeva loro sia il massimo della pena, sia la pena immediatamente superiore. Ora, attraverso la recidiva, ciò che si prende di mira non è l'autore di un atto definito dalla legge, è il soggetto delinquente, è una certa volontà che manifesta il suo carattere intrinsecamente criminale. Poco a poco, man mano che la criminalità diviene, al posto del crimine, l'oggetto dell'intervento penale, l'opposizione tra incensurato e recidivo tenderà a divenire più importante. E, a partire da questa opposizione, e rinforzandola in molti punti, vediamo, nella stessa epoca, formarsi la nozione di delitto «passionale» - crimine involontario, irriflesso, legato a circostanze straordinarie, che non ha certo la giustificazione della pazzia, ma che promette di non essere mai un delitto abituale. Già Le Peletier faceva notare, nel 1791, che la sottile graduazione delle pene che egli presentava alla Costituente poteva distogliere dal crimine «il malvagio che, a sangue freddo, medita una cattiva azione» e che può essere trattenuto dal timore della pena; ch'essa è invece impotente contro i crimini dovuti alle «violente passioni che non calcolano», ma che questo ha scarsa importanza, poiché tali delitti non tradiscono presso i loro autori «alcuna cattiveria ragionata» (58).
Sotto all'umanizzazione delle pene, troviamo tutte quelle regole che autorizzano, meglio, esigono, la «dolcezza» come economia calcolata del potere di punire. Ma esse richiedono anche uno spostamento nel punto di applicazione di questo potere: non più il corpo, col gioco rituale delle sofferenze eccessive e dei segni risplendenti nel rituale dei supplizi; lo spirito, invece, o piuttosto un gioco di rappresentazioni e di segni circolanti, con discrezione ma con necessità ed evidenza, nello spirito di tutti. Non più il corpo, ma l'anima, diceva Mably. Ed è chiaro cosa dobbiamo intendere con questo termine: il correlativo di una tecnica del potere. Si congedano le vecchie «anatomie» punitive. Ma siamo con ciò entrati, e realmente, nell'età dei castighi incorporei?
Come punto di partenza, possiamo dunque porre il progetto politico di classificare esattamente gli illegalismi, di generalizzare la funzione punitiva e delimitare, per controllarlo, il potere di punire. Ora, di qui si dipartono due linee di oggettivazione del crimine e del criminale. Da un lato il criminale, designato come il nemico di tutti, che tutti hanno interesse a perseguire, cade fuori dal patto, si squalifica come cittadino e, pertanto, insorge in lui quasi un selvaggio frammento di natura; egli appare come lo scellerato, il mostro, forse il pazzo, il malato e, ben presto, l'«anormale». E a questo titolo, egli rientrerà un giorno nel campo di un'oggettivazione scientifica e del «trattamento» correlativo. D'altra parte, la necessità di misurare dall'interno gli effetti del potere punitivo prescrive tattiche d'intervento su tutti i criminali, attuali o eventuali: l'organizzazione di un campo di prevenzione, il calcolo degli interessi, la circolazione di rappresentazioni e di segni, la costituzione di un orizzonte di certezza e di verità, l'aggiustamento delle pene a variabili sempre più sottili: tutto ciò, conduce di nuovo ad una oggettivazione dei criminali e dei crimini. In entrambi i casi, il rapporto di potere che sottende all'esercizio della punizione, comincia ad accompagnarsi ad una relazione di oggetto in cui si trovano presi non solo il delitto come fatto da stabilire secondo norme comuni, ma il criminale come individuo da conoscere secondo criteri specifici. Inoltre questa relazione d'oggetto non viene a sovrapporsi dall'esterno alla pratica punitiva, come invece farebbe un'interdizione posta alla furia dei supplizi dai limiti della sensibilità, o un'interrogazione razionale o «scientifica» su cosa sia quest'uomo che viene punito. I processi di oggettivazione nascono nelle tattiche stesse del potere e nell'ordinamento del suo esercizio.
Tuttavia questi due tipi di oggettivazione che si delineano coi progetti di riforma penale sono assai differenti l'uno dall'altro: per la loro cronologia e per i loro effetti. L'oggettivazione del criminale fuori-legge, uomo della natura, è ancora solo virtuale, una linea di fuga dove si incrociano i temi della critica politica e le figure dell'immaginario. Bisognerà attendere a lungo perché l'"homo criminalis" divenga un oggetto definito in un campo di conoscenza. L'altra ha avuto, al contrario, effetti assai più rapidi e decisivi, nella misura in cui era stata più direttamente legata alla riorganizzazione del potere di punire: codificazione, definizione dei delitti, taratura delle pene, regole di procedura, definizione del ruolo dei magistrati. Ed anche perché si appoggiava sul discorso, già strutturato, degli Ideologi. Questo discorso, con la teoria degli interessi, delle rappresentazioni e dei segni, con le serie e le genesi che ricostruiva, dava una sorta di ricetta generale per l'esercizio del potere sugli uomini: lo «spirito» come superficie su cui inscrivere il potere, con la semiologia come strumento; la sottomissione del corpo per mezzo del controllo delle idee; l'analisi delle rappresentazioni come principio di una politica dei corpi ben più efficace dell'anatomia rituale dei supplizi. Il pensiero degli ideologi non è stato solamente una teoria dell'individuo e della società; esso si è sviluppato come una teoria di poteri sottili, efficaci ed economici, in opposizione alle dispendiose prodigalità del potere dei sovrani. Ascoltiamo ancora una volta Servan: bisogna che le idee di delitto e di castigo siano legate fortemente e «si succedano senza intervallo... Quando avrete formata in questo modo la catena delle idee nella testa dei vostri cittadini, potrete allora vantarvi di guidarli e di essere i loro padroni. Un despota imbecille può costringere gli schiavi con catene di ferro; ma un vero politico li lega assai più fortemente con la catena delle proprie idee; è al piano fisso della ragione che egli ne attacca il primo capo; legame tanto più forte perché ne ignoriamo la tessitura e lo crediamo opera nostra. La disperazione e il tempo corrodono i legami di ferro e di acciaio, ma nulla vale contro l'unione abituale delle idee, non fanno che rinserrarsi sempre più; sulle molli fibre del cervello è fondata la base incrollabile dei più saldi imperi» (59).
E' questa semio-tecnica delle punizioni, questo «potere ideologico» che, in parte almeno, resterà in sospeso e il cambio sarà dato da una nuova anatomia politica, in cui il corpo, di nuovo, ma sotto una forma inedita, sarà il personaggio principale. E questa nuova anatomia politica permetterà di riincrociare le due linee di oggettivazione divergenti che vediamo formarsi nel secolo Diciottesimo: quella che respinge il criminale dall'altra parte - dalla parte di una natura contro natura -, e quella che cerca di controllare la delinquenza con una calcolata economia di punizioni. Un colpo d'occhio sulla nuova arte di punire mostra chiaramente la sostituzione, della semio-tecnica punitiva con una nuova politica del corpo.