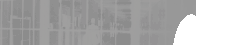In uno dei capitoli precedenti ho mostrato come la vita sia sempre un compromesso fra tendenze opposte, mentre la «vita buona» consiste in una felice concordanza di queste contrastanti energie. Così è, infatti, indipendentemente dal nome che la moda o la consuetudine assegnano a tale concordanza: in quest'opera le espressioni da me scelte sono state «autonomia personale» e «integrazione».
Se uno Stato «totale» esercita il suo potere con una forza tale da non lasciare nemmeno un margine minimo per i necessari compromessi con i bisogni fondamentali dell'individuo, questi non può sopravvivere che distruggendo (o cambiando) la società in cui vive, come abbiamo detto alla fine del capitolo precedente. Ne deriva come corollario che, se lo Stato arriva a esercitare un dominio totale sull'individuo, il raggiungimento completo dei suoi scopi comporta la distruzione dell'individuo medesimo. Se lo Stato di Hitler non distrusse tutti i suoi membri, ma soltanto diversi milioni di essi, ciò dipende unicamente dal fatto che non riuscì a raggiungere il suo vero scopo. Continuò a esistere soltanto perché fu costretto a fare temporaneamente dei compromessi con la maggioranza dei propri sudditi. Ma i compromessi non potevano essere che temporanei, non essendo essi parte integrante del sistema, bensì contrari ai suoi princìpi generali fondamentali.
Persino molti dei suoi seguaci più fanatici con i quali lo Stato avrebbe potuto più facilmente venire a compromesso furono distrutti come persone, secondo il significato da noi dato a questa espressione, come mostrano le storie di Roehm (vedi nota 1 capitolo 7) e di Hoess, il comandante di Auschwitz. A causa del dominio totale che lo Stato esercitava su di lui, e al quale, da vero nazista qual era, egli intendeva sottomettersi incondizionatamente, Hoess distrusse la propria esistenza personale in modo così radicale che finì con l'essere un puro e semplice esecutore di direttive ufficiali. Anche se la morte fisica lo raggiunse solo più tardi, in realtà egli era diventato un cadavere vivente fin dal momento in cui aveva assunto il comando di Auschwitz. Se non diventò mai un «musulmano» fu solo perché continuò a essere ben nutrito e ben vestito. Ma dovette rinunciare totalmente al proprio rispetto di sé, ai propri sentimenti, alla propria personalità, tanto che, in pratica, egli era poco più di una macchina che funzionava soltanto quando i suoi superiori premevano i bottoni di comando.
Il "Führerprinzip", il principio su cui quel tipo di Stato «totale» era basato, permetteva a una sola persona di esser viva, di prendere decisioni: questa era il "Führer". Poiché, specialmente all'inizio, erano necessari dei collaboratori docili e ben disposti, questo principio non poté essere applicato con tutto il rigore che richiedeva, né tutto in una volta. Ma ciò non può mascherare la sua natura. Quanto più in alto un uomo si trovava nella gerarchia del potere, tanto minore (e non maggiore) era l'influenza che egli esercitava nel determinare le decisioni da prendere, e tanto più intimamente viveva della volontà del capo. L'alto comando di Hitler era composto di burattini. Molti dei suoi seguaci accettarono lo Stato «totale» in modo così completo che vivevano soltanto attraverso il capo. Il risultato finale fu che essi non seppero più vivere, ma solo morire.
Lo Stato nazista dominava milioni di Tedeschi la cui personalità si era formata in una società completamente diversa. Ciò che la gerarchia nazista considerava il maggior ostacolo a una completa affermazione dello Stato nazionalsocialista fu in realtà l'elemento che permise a questo Stato di arrivare dove arrivò. Contro la logica stessa del sistema, quei «piccoli» Tedeschi si ostinavano a pretendere per se stessi un certo margine di compromessi, che erano necessari fino a quando non fosse cresciuta una nuova generazione educata dal nuovo sistema. Solo allora, si pensava, si sarebbe attuato il vero Stato «totale», che non sarebbe stato più ostacolato dal bisogno di concedere piccoli compromessi anche ai suoi sudditi leali.
Io credo, al contrario, che soltanto il gran numero di persone con cui il sistema doveva venire a compromesso gli permise di restare in vita. Uno Stato «totale» i cui sudditi si siano tutti completamente sottomessi al "Führerprinzip" risulterà composto soltanto di cadaveri, cadaveri ben nutriti, ben vestiti e perfettamente funzionanti che sanno solo morire, ma non vivere. A questo punto, però, tutto crolla, tanto lo Stato quanto i suoi sudditi.
Lo scopo di quel sistema era la depersonalizzazione, e la politica di sterminio non era che una delle sue conseguenze logiche. Questa politica era, al tempo stesso, il suo aspetto più abominevole e la sua espressione più vera. Sulla base dei documenti trovati dopo la guerra è possibile seguire il processo di disumanizzazione che culminò nei campi della morte; poiché la maggior parte di questa storia è ormai nota, io mi limiterò a commentarne alcuni aspetti particolari.
Alcuni tra i princìpi razziali ed eugenetici propri dell'ideologia hitleriana fecero la loro comparsa nei campi già fin dal 1937. A quell'epoca furono sterilizzati non più di una dozzina di prigionieri, in maggioranza maniaci sessuali o omosessuali. Poi si cominciò, a poco a poco, ad affiancare alle sterilizzazioni intese a migliorare la razza lo sterminio delle persone ritenute portatrici di geni indesiderabili.
Queste pratiche, cominciate su piccola scala, ebbero modo di svilupparsi ampiamente perché mancarono reazioni contrarie sia all'interno della Germania sia all'estero, e questo incoraggiò a procedere più apertamente. Col passare del tempo, e diventando il regime sempre più stabile, l'ideologia che ne era alla base non fu più frenata da alcuna forma di pubblica opinione liberamente formatasi. Lo Stato «totale» poté allora procedere alla realizzazione dei suoi princìpi attraverso una serie illimitata di pratiche disumanizzanti.
Nei campi di concentramento, dove i vari aspetti dello Stato «totale» assumevano un rilievo particolare, di anno in anno diventarono sempre più chiare le conseguenze di una concezione che negava l'individuo. Nelle tirannidi del passato si presupponeva che la tortura di un individuo fosse inflitta proprio a lui, inteso come persona determinata. Nei campi di concentramento anche la tortura e la morte cessarono di avere un qualsiasi rapporto causale con le vicende personali degli internati o con determinati eventi concreti.
Una volta, per esempio, un prigioniero che doveva essere fustigato venne liberato prima che la punizione fosse stata eseguita. Un nuovo arrivato ricevette il numero di identificazione dell'altro, e pochi giorni dopo gli venne somministrata la punizione che avrebbe dovuto toccare a quello, poiché tutta la faccenda era stata registrata sotto il numero che ora egli portava.
Chi puniva non aveva alcun interesse a sapere perché venisse inflitta la punizione o a chi. La persona che veniva battuta era «un prigioniero». Le punizioni come tali avevano certamente uno scopo preciso: aumentare il rendimento, umiliare i prigionieri accrescere il senso di sottomissione alla Gestapo, intimidire i detenuti e la popolazione in generale. Ma per questi fini un prigioniero valeva l'altro, e perciò nemmeno il suo sacrificio supremo aveva niente a che fare con l'individuo come tale. Egli moriva perché gli Ebrei erano diventati superflui, perché c'erano troppi Polacchi o perché i civili fuori del campo dovevano ricevere una lezione.
Non era facile per i prigionieri capire tutte le implicazioni di questo processo di disumanizzazione, e perfino alle S.S. ci volle un certo tempo perché potessero rendersene conto. Durante il mio internamento nei campi, per esempio, mi sono spesso chiesto il perché di un certo comportamento delle guardie che mi era sempre sembrato particolarmente stupido. Quasi ogni giorno questa o quella guardia, gingillandosi col fucile, diceva a un prigioniero che lo avrebbe ucciso volentieri se una pallottola non fosse costata tre "Pfennig", un prezzo troppo alto perché valesse la pena di sprecarla per lui.
Questa affermazione, sempre identica, era ripetuta troppo spesso, da troppe guardie appartenenti a diverse unità perché la si potesse considerare priva di senso o di scopo. Quando la sentivo pronunciare mi domandavo perché le guardie pensassero che io dovessi sentirmene particolarmente umiliato. Soltanto più tardi nacque in me l'idea che essa, come altre osservazioni del genere e altri comportamenti apparentemente ingiustificati, volesse sì fare impressione sul prigioniero, ma che il suo vero scopo dovesse essere individuato nella speciale educazione ricevuta dalle guardie.
Esse ripetevano questa affermazione così spesso, perché gli era stata detta altrettanto spesso durante il periodo di indottrinamento, e doveva averli colpiti per la sua stranezza. Dato che era un po' dura da mandar giù facilmente, credevano che avrebbe fatto sui prigionieri la stessa profonda impressione che aveva fatto su di loro; invece, in generale, i prigionieri la trovavano soltanto sciocca. Non era certo facile per la maggior parte delle S.S. accettare di ridurre il valore di un essere umano al prezzo insignificante di una pallottola. Esse erano rimaste molto colpite dall'idea che i loro superiori avessero potuto fissare il valore di un essere umano al di sotto di questo prezzo. Stupite e incredule, dovevano fare sforzi continui per convincersene.
Prima che le guardie arrivassero a credere ciecamente cose simili erano stati necessari molti sforzi di questo tipo; contemporaneamente, esse stesse dovevano essere non poco impressionate davanti al potere di uno Stato che eliminava gli esseri umani con tanta facilità. Soltanto dopo che ebbero assorbito completamente questo atteggiamento verso la persona umana - e sempre con una certa esitazione, a eccezione dei pochi «assassini di professione» - riuscirono a non dare alcuna importanza alla persona del prigioniero; soltanto allora riuscirono a trattare i prigionieri come numeri e non come individui.
A difesa dell'uomo si deve dire che alcune di loro non ci riuscirono mai. Kautsky (1) lo capì osservando barlumi di umanità in alcune S.S. Egli riferisce di un'S.S. che non fece mai un'osservazione antisemita, non batté mai i prigionieri, non fece mai rapporto perché uno di essi venisse punito. Ve ne furono altre che rischiarono la vita facendo passare lettere per i prigionieri, senza prendere alcun compenso. Certamente si trattava solo di una piccola minoranza. Ma altrettanto pochi erano i detenuti rimasti onesti. Per lo più le S.S. non perdevano un minuto del loro tempo libero a maltrattare i prigionieri. E questo non è il comportamento del sadico che, sempre, gode nel maltrattare gli altri.
- Decisioni funzionali.
Con la guerra contro la Russia ogni residuo interesse delle autorità per l'essere umano scomparve, e si spalancò la porta allo sterminio di milioni di persone. A causa dell'urgente necessità di mano d'opera per far fronte a una guerra totale, si profilò un cambiamento di politica verso quelle persone che, dentro e fuori dei campi, furono giudicate prive di valore per lo Stato. Tutti gli indesiderabili abili al lavoro dovevano lavorare fino a morirne, (2) mentre gli altri dovevano puramente e semplicemente essere uccisi. Ne risultò la decisione di uccidere sia tutti gli Ebrei d'Europa sia tutti coloro che fossero inabili al lavoro, come gli storpi, i malati di mente e così via.
Gli ultimi anni dei campi di concentramento (dal 1942 fino alla liberazione) furono caratterizzati dal controllo totale dello Stato su una massa di lavoratori forzati che ammontava a milioni di individui, e che, in teoria, avrebbe dovuto comprendere tutti i cittadini, a eccezione di una piccola casta dominante. Era questa l'apoteosi finale dello Stato di massa, costituito da un numero limitato di dirigenti depersonalizzati e da milioni di schiavi disumanizzati, ubbidienti tutti alla volontà di un capo carismatico, che restava la sola «persona», la sola persona viva.
Indubbiamente, l'uso dei prigionieri per il lavoro forzato aveva più senso, da un punto di vista rigidamente «funzionale», che non i continui maltrattamenti che venivano loro inflitti senza alcun vantaggio economico. Per la stessa ragione tale uso costituì un grosso passo in avanti verso la disumanizzazione. Fin quando lo Stato di Hitler si limitò a modificare la personalità dei prigionieri per conseguire i propri scopi, si dava ancora una limitatissima importanza ai detenuti nella loro individualità, considerandoli degni di essere «risparmiati». Teoricamente, fino ad allora i prigionieri che dovevano essere uccisi erano soltanto quelli non «educabili».
Con la nuova impostazione data al lavoro forzato e alla politica di sterminio, lo Stato mise da parte ogni considerazione per il valore della vita umana, anche dal punto di vista di una società fondata sulla schiavitù. Nelle società primitive di carattere analogo gli schiavi raramente erano considerati meno di un investimento. Indubbiamente il loro lavoro era sfruttato senza troppa preoccupazione per il fatto che essi fossero esseri umani, ma nello Stato di Hitler gli schiavi persero anche questo loro valore di investimento. Era questa la grande differenza fra lo sfruttamento da parte di capitalisti privati e lo sfruttamento da parte di uno Stato responsabile soltanto davanti a se stesso. (3)
Il primo gruppo selezionato per uno sterminio totale fu quello degli zingari. Tutti gli zingari internati a Buchenwald furono uccisi con iniezioni nel 1941. (4) A quel tempo, tuttavia, l'assassinio in massa non era ancora centralizzato, pianificato ed eseguito su scala «industriale», secondo le direttive di un piano economico generale. Quest'ultimo passo venne fatto quando, nel 1942, furono creati i campi di sterminio, quando cioè un gran numero di Russi e di Polacchi fu iscritto sulle liste della morte.
- L'uomo come merce.
Tanto i campi di concentramento quanto i campi di sterminio (con tutto ciò che in essi accadeva) erano un'applicazione oltre i limiti della ragione dell'idea del lavoro come mera utilità. Nei campi, infatti, non soltanto il lavoro, ma la personalità stessa degli internati veniva considerata alla stregua di un semplice bene di consumo. Le persone venivano «consegnate» come se fossero oggetti di una transazione. Erano usate e scambiate a seconda dei desideri del cliente, in questo caso lo Stato. Quando non erano più utilizzabili venivano scartate, ma avendo cura di non sperperare niente di ciò che poteva essere risparmiato. Per arrivare a questo si seguivano procedimenti simili ai più moderni metodi industriali, elaborati appositamente per questo scopo.
Eppure il concetto di uomo come prodotto utilizzabile era presente nell'ideologia dello Stato di massa tedesco già da molto tempo: basti considerare la terminologia delle S.S. Se le guardie uccidevano i prigionieri, o si preparavano a farlo, usavano l'espressione "fertig machen", che solo raramente significava «finire» (ovvero «liquidare»); di solito significava, invece, «approntare» ovvero «preparare». D'altro canto, "fertig machen" è un'espressione usata frequentemente nel gergo industriale per indicare il processo finale prima che il prodotto finito venga consegnato al cliente. Né la lingua tedesca né il gergo usano comunemente questa espressione nel significato di uccidere una persona.
Il paragone con i metodi industriali può essere portato molto più avanti. Quando fu decisa la politica di sterminio in massa e fu nominata la persona incaricata di attuarla, questa si mise al lavoro seguendo i criteri propri di un uomo d'affari. Come ogni dirigente industriale competente, prima di creare nuovi stabilimenti, egli fece un giro di ispezione in tutti gli stabilimenti esistenti per decidere quali fossero i metodi di lavorazione più aggiornati e le attrezzature più adatte.
Fino al 1940, ogni campo di concentramento era più o meno un'«industria» unica e organica, la quale riceveva le sue materie prime, i prigionieri, le distribuiva, si serviva delle loro prestazioni, e le eliminava o con la morte o restituendo loro la libertà. Più tardi fu introdotta la specializzazione. Per ciascuno stadio del processo produttivo furono creati «impianti» distinti. Ci furono campi di raccolta e di distribuzione nel quali i prigionieri venivano selezionati e inviati o ai campi di lavoro o ai campi di sterminio. La produzione si articolava così su almeno tre unità separate: i campi di raccolta, i campi di lavoro, i campi di sterminio. Come tutte le industrie moderne, ciascuno di essi aveva il proprio «ufficio studi» che faceva ricerche di vario tipo. E' significativo che tutti avessero una cosa in comune: ogni tipo di «materiale di ricerca» era considerato come un prodotto di massa le cui unità erano tutte liberamente interscambiabili.
Poiché lo Stato nazista considerava gli esseri umani come meri oggetti, era spesso molto più pratico correggere gli errori sulle persone che negli schedari. Se erano stati fatti errori di conteggio in occasione dei nuovi arresti, si preferiva aumentare il numero degli arrestati o eliminarli fino a quando le partite non tornassero in pareggio. Gli errori di contabilità venivano così corretti sugli oggetti della transazione amministrativa e non sui libri contabili.
Nemmeno l'involucro di questi oggetti era trascurato. I prigionieri, che non dovevano differenziarsi in alcun modo, avevano tutti la stessa uniforme a strisce e la testa rapata. Alle uniformi venivano attaccati dei distintivi, usando colori diversi per ciascun gruppo e sottogruppo. Si rendevano uguali gli individui, mentre si differenziavano i gruppi. Ciascun prigioniero aveva poi un numero, e quando doveva parlare agli ufficiali del campo egli non dava mai il proprio nome, ma il numero, il gruppo e il sottogruppo al quale apparteneva.
Insita in qualsiasi tipo di Stato di massa è la tendenza a organizzare e riorganizzare il materiale umano fino a quando ciascun membro non sia collocato esattamente nella sua categoria. Se poi si tratta di uno Stato classista, si vuole garantire che ogni persona venga fissata nella sua classe il più stabilmente possibile, perché non minacci la classe dominante cercando di avanzare di grado. Le S.S. avrebbero voluto classificare i prigionieri per l'eternità; il primo passo verso questo fine furono i distintivi multicolori e i numeri. Dopo un certo tempo, la categoria cui il prigioniero apparteneva fu iscritta sul suo corpo con inchiostro indelebile. Alla fine, nei campi di sterminio essa fu tatuata sulla pelle: le unità che componevano lo Stato erano ormai marchiate per sempre.
Anche sotto questo aspetto i campi di concentramento non erano che il punto di arrivo di una tendenza intrinseca allo Stato di massa tedesco. L'ideale nazista era che ogni cittadino fosse classificato secondo la propria condizione. L'"élite" si fregiava delle insegne delle S.S., i membri del partito dell'emblema del partito stesso, gli Ebrei portavano la stella gialla. Si tentò di far portare dei distintivi anche ai lavoratori civili stranieri, ma essi vi si opposero e il tentativo fu abbandonato. Nondimeno, una Germania vittoriosa avrebbe potuto benissimo costringere ognuno a portare il simbolo del proprio gruppo, come già si era fatto nei campi di concentramento.
Caratteristica era la circostanza che a molte S.S., comprese quelle che amministravano i campi, non piacesse il lavoro che svolgevano, e che esse lo accettassero per senso del dovere. Hoess, comandante del più grande campo di sterminio, era stato in passato membro della semi-mistica associazione "Artamanen", che predicava il ritorno alla terra come mezzo per salvare i giovani tedeschi dalla «corruzione» delle città e delle fabbriche, auspicando per loro una vita semplice in campagna, a contatto con la terra e con la natura. Ma, una volta entrato nelle S.S., egli abbandonò ogni convinzione e inclinazione personale, si costrinse a non essere più un uomo e diventò un ingranaggio dello Stato «totale».
Quando gli venne affidato l'incarico di dirigere Auschwitz, egli volle farlo con efficienza, volle amministrare un'industria pulita e funzionante: si dava il caso che la sua funzione fosse di distruggere esseri umani. La sola cosa che interessava Hoess era che la gestione della fabbrica fosse perfetta: che essa «trattasse» esseri umani e non acciaio o alluminio non lo interessava affatto. Un giornalista alleato che lo osservò al tribunale di Norimberga lo ha descritto così:
«Senza batter ciglio, Hoess riferì concisamente e concretamente sul suo 'trattamento' di due o tre milioni di Ebrei e di altre vittime mediante le camere a gas, i forni crematori e i campi di concentramento. Il modo di presentarsi e le maniere di Hoess erano quelli di un uomo che, dovunque, sarebbe stato considerato straordinariamente competente e degno di fiducia, anche se non dotato di molta fantasia. Il testimone, così penosamente corretto, non pronunciò mai una parola che potesse suonare offensiva; egli parlava in termini tecnici di uccisioni in massa, senza riferire particolari raccapriccianti, senza l'eloquenza di un moralista o di un sadico... Da uomo che credeva fanaticamente nel lavoro forzato, nell'efficienza, nell'ordine, nella disciplina e nella pulizia, Hoess non cessava di irritarsi per l'inefficienza del Terzo Reich a provvedere adeguati trasporti, cibi, medicamenti, installazioni sanitarie, e personale per controllare le sue vittime... Assillava continuamente i suoi superiori per avere maggiori rifornimenti, un personale meno corrotto e brutale, e soprattutto perché venisse rallentato il flusso degli arrivi, sì da poter assicurare un meccanismo produttivo più efficiente: camere a gas e forni crematori per i prigionieri inutilizzabili, divertimenti per coloro che potevano essere ancora utilizzati nei suoi campi di lavoro». (5)
Anche la corrispondenza commerciale di Auschwitz è simile a quella di qualsiasi altra industria, come mostra il seguente esempio tratto dalla corrispondenza tra Auschwitz e il gruppo chimico della I. G. Farben.
? «In previsione di ulteriori esperimenti con una nuova droga soporifera, vi saremmo grati se ci poteste procurare un certo numero di donne».
? «Abbiamo ricevuto la vostra risposta, ma consideriamo che il prezzo di 220 marchi per donna sia eccessivo. Vi proponiamo un prezzo non superiore a 170 marchi a testa. Se siete d'accordo sulla cifra, prenderemo possesso delle donne. Ce ne abbisognano circa 150».
? «Accusiamo ricevuta dell'accordo. Preparateci 150 donne nelle migliori condizioni di salute: appena pronte le prenderemo a nostro carico».
? «Ricevuta l'ordinazione di 150 donne. Nonostante l'aspetto emaciato, sono state giudicate soddisfacenti. A giro di posta vi terremo al corrente dei risultati dell'esperimento».
? «Gli esperimenti sono stati eseguiti. Tutti i soggetti sono morti. Ci metteremo presto in contatto con voi per una nuova ordinazione». (6)
- Il comportamento nei campi di sterminio.
L'analisi del comportamento degli internati nei campi di sterminio, anche se più tremenda, offre un interesse psicologico minore, perché ivi i prigionieri non avevano tempo o modo di modificare molto la loro personalità.
Il solo fenomeno psicologico che ci sembra interessante dal nostro punto di vista è che questi prigionieri, pur sapendo di dover morire, non abbiano quasi mai tentato di rivoltarsi. Dato che le eccezioni interessano una piccolissima minoranza di prigionieri (pochi casi isolati di fronte a milioni di casi contrari) non intendiamo per ora prenderle in considerazione.
In certe occasioni, soltanto una guardia o due scortavano verso i campi di sterminio e su strade solitarie fino a quattrocento prigionieri. Con tutta probabilità questi quattrocento prigionieri sarebbero riusciti ad avere la meglio sulle guardie armate. (7) Anche se alcuni di loro fossero rimasti uccisi, la maggioranza si sarebbe liberata per poi unirsi ai partigiani. Quanto meno, essi avrebbero potuto godere di una temporanea vendetta, senza avere nulla da perdere, dato che erano destinati a morire in ogni caso.
Un'analisi non psicologica del comportamento di questi prigionieri non sembra adeguata per spiegare la ragione di una tale docilità. Per comprendere il fenomeno di uomini che non reagivano ribellandosi, benché fossero certi di andare incontro alla morte, (8) dobbiamo ricordarci che gli individui più attivi che molto tempo prima avevano tentato di combattere contro il nazionalsocialismo o erano morti o erano stati stroncati. I Polacchi e gli Ebrei che formavano la maggioranza degli internati nei campi di sterminio erano per lo più persone che, per una ragione o per l'altra, non erano riuscite a scappare e che non avevano affatto la tempra dei combattenti.
Questa condizione di impotenza non implica che non nutrissero una forte ostilità contro gli oppressori. La debolezza e la sottomissione hanno spesso una maggior carica di ostilità che non un'aggressività aperta. Nel contrattacco, come avveniva per esempio nei partigiani o nei membri dei movimenti di resistenza, gli oppositori al fascismo tedesco trovavano uno sfogo alla propria ostilità. Ma nelle persone che, oppresse, non si ribellavano, tutti questi sentimenti ostili, che non riuscivano a trovare sfogo nell'azione, si accumulavano. Esse non si permettevano nemmeno il modesto sollievo di un'aggressione verbale, perché si rendevano conto che ciò sarebbe bastato per portarli alla distruzione.
Quanto maggiore era l'ostilità accumulata, tanto più terrorizzato era il prigioniero al pensiero che essa potesse erompere in un atto esplosivo che avrebbe significato la sua distruzione. Per impedire una simile eventualità, egli si sentiva costretto a non dimenticare mai, nemmeno per un istante, l'estrema pericolosità dell'aggressore; in questo modo il suo stesso terrore lo avrebbe costretto a controllarsi con maggiore intensità. Così, per proteggersi, egli attribuiva alle S.S. tutte le qualità che lo terrorizzavano di più, e queste, a loro volta, aumentavano la sua angoscia, la sua frustrazione e la sua ostilità. (9)
I due processi paralleli di reprimere ogni ostilità e di ingigantire la terribile immagine delle S.S. divoravano completamente la sua energia emotiva. E ammesso che gliene restasse un poco, egli la spendeva subito nella lotta contro la depressione causatagli dalla perdita della sua condizione sociale, dalla separazione dalla famiglia, dall'esaurimento dovuto alla malnutrizione e alle malattie, e dalla spaventosa disperazione che lo divorava.
Nei campi di concentramento si poteva sfogare parte della propria ostilità nella lotta di fazioni tra i prigionieri. Mentre durava la lotta restava accesa la speranza che il proprio partito prevalesse e che perciò le proprie condizioni migliorassero. I «musulmani», naturalmente, non combattevano più; non facevano parte di alcuna fazione, non sfogavano la loro ostilità se non volgendola contro se stessi, esattamente come facevano i prigionieri dei campi di sterminio. E come loro, essi morivano. Nei campi di sterminio i prigionieri erano privati di ogni risorsa che potesse ridare loro un po' di dignità o la volontà di vivere, mentre l'ostilità repressa cresceva continuamente.
Tutto questo può spiegare la docilità degli internati che si avviavano verso le camere a gas o che si scavavano la fossa, ci si allineavano davanti per poi ricaderci dentro quando venivano fucilati. Si può ben dire che in quel momento la maggior parte dei prigionieri erano dei suicidi. Incamminarsi verso la camera a gas significava suicidarsi in un modo che non richiedeva nemmeno quell'energia che è di solito necessaria per decidere e organizzare la propria morte. Parlando da un punto di vista psicologico, la maggior parte dei prigionieri dei campi di sterminio, quando subiva la morte senza opporre alcuna resistenza, si suicidava.
Se questa illazione è esatta, si può dire che nei campi di sterminio gli scopi delle S.S. furono pienamente raggiunti. Mediante l'uso del terrore esse riuscirono a costringere i loro oppositori a fare spontaneamente quello che i persecutori volevano. Milioni di persone accettarono di essere sterminate perché i metodi delle S.S. li avevano costretti a considerare la morte non come una via d'uscita, ma come l'unica via per porre fine a condizioni nelle quali essi non potevano più vivere come esseri umani.
Poiché queste considerazioni possono sembrare forzate, aggiungerò che il processo finora descritto è simile a quello che si può osservare in alcuni psicopatici. L'affermazione che nei prigionieri si sviluppavano condizioni mentali simili a quelle osservabili nei malati di mente trova conferma nel comportamento degli ex prigionieri dei campi di sterminio dopo la loro liberazione. I sintomi che presentavano dipendevano naturalmente dalle risorse originarie della loro personalità e dalle esperienze fatte immediatamente dopo la liberazione. In alcune persone i sintomi apparivano più gravi, in altre meno; in alcune essi si dimostrarono reversibili, in altre no.
Immediatamente dopo la liberazione quasi tutti i prigionieri assunsero atteggiamenti asociali che si potevano spiegare soltanto con la profonda disintegrazione subita dalla loro struttura psicologica. Si sono fatti studi su alcuni ex internati nei campi di sterminio. La loro presa sulla realtà era estremamente debole. Alcuni soffrivano ancora di deliri di persecuzione, altri invece di deliri di grandezza. Quest'ultimo stato d'animo era la contropartita del senso di colpa che essi provavano per essersi salvati, mentre i loro genitori o i loro fratelli erano periti tutti. Cercavano di giustificare la propria sopravvivenza esagerando attraverso il delirio l'importanza della propria persona. Ciò era anche una compensazione per il gravissimo danno che le esperienze subite avevano inflitto al loro narcisismo.
- Fare come se niente fosse.
Alcune parole sulla reazione del mondo ai campi di concentramento: dalla maggior parte delle persone civili gli orrori ivi commessi furono giudicati strani e incomprensibili. Venire a sapere che popolazioni ritenute civili potessero degradarsi al punto di commettere atti così inumani scosse profondamente il loro orgoglio. Il fatto che l'uomo moderno abbia sulla propria crudeltà un controllo così inadeguato fu sentito come una minaccia. Questa sensazione mise in moto tre meccanismi psicologici diversi: 1) si negò che il fenomeno dei campi di concentramento potesse essere imputato all'uomo in generale, asserendo (contrariamente a tutti i dati che l'esperienza aveva reso disponibili) che gli atti di tortura erano stati commessi da una minoranza di persone pazze o perverse; 2) si negò la veridicità delle notizie, attribuendole a una propaganda interessata; questa versione era accreditata dal governo tedesco che definiva trucida propaganda ("Greuelpropaganda") ogni notizia sugli orrori dei campi; 3) si credette a ciò che veniva riferito, ma la conoscenza di quei terribili fatti fu rimossa il più in fretta possibile.
Tutti e tre questi meccanismi furono visti all'opera dopo la liberazione. Immediatamente dopo la «scoperta» dei campi, un'ondata di estrema indignazione si levò nelle nazioni alleate. Essa fu presto seguìta da una rimozione generale della scoperta. Può darsi che questa reazione del pubblico fosse dovuta a qualcosa di più che allo shock inflitto al proprio narcisismo dalla constatazione che tanta crudeltà esista ancora nell'animo umano. Può anche darsi che il pensiero delle torture venisse rimosso perché rendersi conto che lo Stato moderno possiede i mezzi idonei per trasformare la personalità umana è qualcosa di troppo inquietante. Dovere ammettere che la nostra personalità può essere trasformata contro la nostra stessa volontà è la minaccia più grande al nostro rispetto di noi stessi. Tale minaccia dobbiamo dunque fronteggiarla o con l'azione o con la rimozione.
Il successo universale del "Diario di Anna Frank" ci dà un'idea di quanto grande sia ancora in noi la tendenza a negare, mentre la vicenda narrata nel libro dimostra che questa specie di negazione può affrettare la nostra distruzione. E' certo un compito ingrato criticare una storia così gentile e commovente che tanta pietà suscita in noi per la povera e gentile Anna Frank. Ma io credo che il favore che quel libro ha incontrato in tutto il mondo non possa essere compreso se in esso non ravvisiamo il nostro desiderio di dimenticare le camere a gas e di esaltare l'attaccamento alla vita privata, la fedeltà alle abitudini quotidiane, anche nell'olocausto. Si esaltano i Frank proprio per il fatto che essi continuarono a vivere la loro solita vita, mentre fu proprio questo che li portò alla distruzione; così possiamo trascurare il fatto essenziale, cioè quanto sia distruttivo un tale comportamento in circostanze sociali straordinarie ed estreme.
Mentre i Frank facevano i preparativi per andare a nascondersi, migliaia di altri Ebrei, in Olanda e in tutta quanta l'Europa, cercavano di fuggire nel mondo libero, per sopravvivere o per essere in grado di lottare contro gli oppressori. Altri che non poterono farlo si dettero alla macchia, non per nascondersi dalle S.S. aspettando passivamente e senza prepararsi alla lotta il giorno in cui sarebbero stati presi, ma per combattere contro i Tedeschi, per l'umanità. I Frank volevano solo tirare avanti, conducendo una vita non troppo diversa da quella alla quale erano abituati.
Anche la piccola Anna non pretendeva che di vivere come al solito, e certo nessuno può biasimarla per questo. Ma il suo non fu certo un destino inevitabile e tanto meno eroico: fu solo un destino senza senso. Come fecero molti Ebrei olandesi, anche i Frank potevano cercare di affrontare la situazione e sopravvivere. Probabilmente Anna aveva buone possibilità di salvarsi, come avvenne per molti altri bambini olandesi. Ma per salvarsi avrebbe dovuto separarsi dai genitori e andare a vivere in una famiglia olandese come fosse una di loro.
Chi aveva occhi per vedere sapeva che la maniera più difficile per nascondersi era quella di farlo come famiglia: se una famiglia si nascondeva tutta insieme, ciò rendeva assai probabile la sua scoperta da parte delle S.S. Con le loro ottime conoscenze tra le famiglie olandesi non ebree i Frank avrebbero avuto una vita più facile nascondendosi ciascuno in una famiglia diversa. Ma, invece di pensare a questo, essi aspiravano, in sostanza, a continuare il più a lungo possibile quel tipo di vita familiare al quale erano tanto attaccati. Ogni altra soluzione avrebbe comportato non solo di dover rinunciare alla prediletta vita familiare, ma anche di accettare come cosa reale la crudeltà degli uomini. Più di ogni altra cosa, ciò li avrebbe costretti ad ammettere che il condurre la stessa vita di sempre non era un valore assoluto, ma poteva anzi essere il più distruttivo dei comportamenti.
Senza dubbio i Frank, che si erano mostrati capaci di procurarsi tante cose, avrebbero potuto facilmente procacciarsi un fucile o due. Avrebbero potuto così uccidere almeno una o due di quelle «guardie verdi» che erano venute ad arrestarli. Di queste guardie non ce n'erano poi così tante. La perdita di una S.S. per ogni ebreo arrestato avrebbe notevolmente intralciato l'attività della polizia di Stato. Il destino della famiglia Frank non sarebbe certo cambiato, perché essi morirono tutti egualmente, tranne il padre di Anna, il quale, indubbiamente, non avrebbe voluto pagare la propria sopravvivenza con lo sterminio dell'intera famiglia. Essi avrebbero potuto però vender cara la pelle, invece di avviarsi alla morte senza resistere.
C'erano ottime ragioni perché un dramma come questo, che ha avuto tanto successo, finisse con le parole di Anna che asseriscono la sua fede nella bontà di tutti gli uomini. Con ciò viene negata la realtà delle camere a gas che, di conseguenza, non potranno più esistere. Se tutti gli uomini sono fondamentalmente buoni, e se continuare a vivere come al solito in seno alla propria famiglia, accada quel che accada, è cosa degna della massima ammirazione, allora anche noi possiamo continuare a vivere la nostra vita di sempre e dimenticare Auschwitz. Sennonché, Anna Frank morì proprio perché i suoi genitori non seppero credere nell'esistenza di Auschwitz. E la sua storia ha incontrato tanto favore perché, anche a nostro vantaggio, essa nega implicitamente che Auschwitz sia mai esistito. Se tutti gli uomini sono buoni, Auschwitz non è mai esistito.
- Era tempo.
Nel corso di quest'opera ho più volte detto che sottomettersi allo Stato «totale» porta alla disintegrazione della personalità anche in individui che in passato sembravano bene integrati, e per di più a comportamenti di tipo infantile. A questo punto possono forse essere utili alcune considerazioni di carattere teorico. Anni fa, Freud postulò l'esistenza in ciascuno di noi di due tendenze opposte: la pulsione della vita, che egli chiamò eros o sesso, e le tendenze distruttive, che egli chiamò pulsione di morte. Quanto più una persona diventa matura, tanto più sarà capace di «fondere» queste due opposte tendenze; l'Io che ne risulta sarà altrettanta energia utilizzabile per affrontare e plasmare la realtà.
Quanto più immatura è la persona, tanto più libere sono queste tendenze di spingere la personalità globale ora in una direzione ora in un'altra. Si spiega così la cosiddetta infantile cordialità di alcuni popoli primitivi, cui improvvisamente fa seguito una estrema e «sconsiderata» crudeltà. Ma la disintegrazione, o meglio sarebbe dire la «disgregazione», delle energie dell'Io in condizioni di estrema gravità - con la prevalenza in un dato momento delle tendenze puramente distruttive («purché finisca, non importa come»), e, immediatamente dopo, di irrazionali tendenze alla vita («voglio mangiare qualcosa ora, anche se ciò significa la morte fra poco») (10) - era soltanto un aspetto del ritorno a una condizione primitiva in chi era costretto a vivere in uno Stato «totale». Un altro aspetto era l'abbandono a una serie di processi psicologici infantili, come il credere che ciò che si sperava fosse vero soltanto perché si desiderava che lo fosse, invece di applicarsi a una più matura valutazione della realtà, e a una negligenza anch'essa infantile per la possibilità di dover morire. Molti pensavano, infatti, che soltanto loro fra tutti gli altri sarebbero stati risparmiati e sarebbero sopravvissuti; e molti altri si rifiutavano semplicemente di credere nella possibilità di morire. Non credendo di morire, non facevano nulla per prepararsi alla morte, non curandosi, poi, di vender cara la pelle quando la morte fosse diventata inevitabile. Difendersi prima di quel momento poteva significare il suicidio, e perciò fino ad allora il fatto di subire passivamente le persecuzioni del nemico proteggeva loro la vita. Ma dopo questo momento, ciò poteva distruggere sia la propria sia l'altrui vita, che invece si sarebbe potuta salvare se si fosse stati disposti a rischiare la propria. Il fatto è che quanto più a lungo uno subisce passivamente tanto più probabile è l'eventualità che egli non abbia più la forza di resistere quando la morte diventa imminente, specie se a questo abbandonarsi al nemico si accompagna non un rafforzamento interiore della personalità (come sarebbe necessario), ma la sua disintegrazione. (11)
Coloro che non negarono né rimossero l'eventualità della morte, che non si abbarbicarono a una fiducia infantile nella propria indistruttibilità, furono quelli che poi ebbero modo di prepararvisi tempestivamente quando essa si fece vicina. Ciò significava rischiare la vita per uno scopo che ci si era scelti, e con ciò salvarla, o salvare quella di altri, o entrambe. Quando in Germania gli Ebrei furono costretti a non uscire di casa, coloro che non permisero all'inerzia di prendere il sopravvento considerarono l'imposizione di tali restrizioni come la prima avvisaglia che era venuto il momento di darsi alla macchia, di unirsi ai movimenti della Resistenza, di procurarsi, se non lo avevano già fatto, dei documenti falsi, eccetera, eccetera. La maggior parte di loro sopravvisse.
Un esempio tratto dalla vita di alcuni miei lontani parenti può dare un'idea precisa di tutto questo. Fin dall'inizio della guerra un mio giovane cugino, che viveva in una piccola città ungherese, formò un gruppo insieme con alcuni altri giovani ebrei allo scopo di prepararsi per quando i Tedeschi avrebbero occupato il paese. Appena i nazisti imposero il coprifuoco agli Ebrei, il gruppo partì per Budapest, perché una grande città offre sempre maggiori possibilità di sfuggire alla cattura. Là, gruppi simili venuti a Budapest da altre città si unirono a loro. Fra questi essi scelsero alcuni uomini che all'aspetto sembravano «ariani tipici», dettero loro documenti falsi e li fecero entrare immediatamente nelle file delle S.S. ungheresi perché potessero dare l'allarme quando fossero state imminenti azioni punitive, quando un certo distretto sarebbe stato rastrellato, eccetera.
L'iniziativa ebbe successo e la maggior parte dei gruppi sopravvisse senza subire perdite. Ma essi erano stati dotati anche di armi leggere, per dare battaglia nel caso in cui fossero stati scoperti, permettendo così alla maggioranza di mettersi in salvo: mentre alcuni di loro sarebbero morti per guadagnare tempo gli altri sarebbero potuti fuggire. (12) Alcuni di quegli Ebrei che erano entrati a far parte delle S.S. vennero scoperti e fucilati immediatamente, una morte certo preferibile a quella nelle camere a gas. Ma anche fra costoro la maggior parte riuscì a scamparla, rimanendo nascosta tra le S.S. fino all'ultimo.
Quel mio parente non riuscì a convincere alcuni membri della sua famiglia ad andare con lui quando egli partì. Affrontando rischi tremendi per la propria vita, egli tornò indietro tre volte, prima per avvertirli che la persecuzione contro gli Ebrei stava diventando sempre più feroce, e poi per dir loro che erano partiti i primi trasporti diretti alle camere a gas. Eppure, non riuscì a convincerli a lasciare le loro case e i loro beni. A ogni visita egli li implorava con crescente disperazione e a ogni visita li trovò meno disposti a dargli ascolto, a prendere una decisione. Era come se, ogni volta, i suoi familiari si avvicinassero di un passo ai forni crematori, dove infatti poi morirono tutti.
A ogni sua visita i membri di quella famiglia si attaccavano con disperata tenacia alle vecchie abitudini, alle cose che avevano accumulato nel corso della loro esistenza. Era come se in loro si sviluppassero due processi paralleli, per cui da un lato le loro energie vitali venivano ad esaurirsi, dall'altro sembrava che i beni dessero loro una pseudo-sicurezza che prendeva il posto della sicurezza reale, ora che non potevano più fare progetti per il futuro. Nonostante ciò, non diversamente dai bambini, essi preferivano attaccarsi con la forza della disperazione ad alcuni oggetti, che essi avevano investito di tutto il significato che non potevano più trovare nella loro vita presente. Quando ebbero abbandonato la lotta per la sopravvivenza, quegli oggetti inerti cominciarono a succhiar loro ogni energia vitale, e le persone morivano in essi pezzo dopo pezzo, oggetto dopo oggetto.
A Buchenwald io parlai con centinaia di Ebrei tedeschi che erano stati trasportati là nell'autunno del 1938. Chiesi loro perché non avessero lasciato la Germania quando là la vita era diventata tanto umiliante. La loro risposta era: «Come facevamo a partire? Avremmo dovuto rinunciare alle nostre case, alle nostre occupazioni, al nostro lavoro». I loro beni terreni si erano impossessati così totalmente di loro che essi non potevano più muoversi: invece di servirsene, ne erano dominati. (13)
La maniera in cui questo trasferimento delle proprie energie vitali nei beni posseduti uccise a poco a poco le persone che li possedevano risulta anche dall'evoluzione dell'atteggiamento dei nazisti verso gli Ebrei. Al tempo del primo boicottaggio dei negozi degli Ebrei, il solo scopo manifesto dei nazisti era di appropriarsi dei loro beni. Purché gli Ebrei abbandonassero il paese lasciandosi dietro il grosso dei propri beni, le S.S. permettevano perfino che ne portassero via una parte. Per un certo tempo lo scopo dei nazisti e delle leggi discriminatorie fu di costringere le minoranze indesiderabili, come gli Ebrei, a emigrare. Soltanto quando questa politica non ebbe successo fu adottata la politica di sterminio, anche se essa era una logica conseguenza dell'ideologia nazista in materia razziale. Ma non possiamo fare a meno di chiederci se l'idea che milioni di Ebrei (e, più tardi, di cittadini stranieri) si sarebbero rassegnati allo sterminio non sia stata rafforzata anche dallo spettacolo di tutte le umiliazioni che, senza reagire, essi avevano sopportato. La persecuzione degli Ebrei aumentò lentamente, passo dopo passo, senza che essi opponessero la minima resistenza. Può anche essere stata questa accettazione passiva delle discriminazioni più offensive e delle umiliazioni più dure a dare alle S.S. l'idea che gli Ebrei potevano giungere al punto di avviarsi da sé alle camere a gas.
La maggior parte degli Ebrei polacchi che non ritennero più possibile, in quelle circostanze, continuare a vivere come se niente fosse, sopravvisse alla seconda guerra mondiale. All'avvicinarsi dei Tedeschi essi abbandonarono tutti i propri beni e fuggirono in Russia, anche se nessuno di loro aveva fiducia nel sistema sovietico. Ma là, almeno, essi sarebbero stati considerati come esseri umani, anche se forse cittadini di secondo rango. Coloro invece che continuarono a vivere come al solito andarono incontro alla distruzione e perirono tutti. Pertanto, nel suo significato più profondo, la strada verso la camera a gas non fu che l'estrema conseguenza di un atteggiamento consistente nel continuare a vivere facendo i propri affari come se nulla fosse accaduto, il punto di arrivo della rinuncia a combattere la pulsione di morte; si può anche parlare di un «principio d'inerzia». Perché il primo passo verso il campo della morte fu fatto molto tempo prima che uno vi entrasse.
Questo comportamento suicida ha, è vero, anche un altro significato, cioè che un uomo può essere spinto fino a un certo punto e non oltre: oltre questo limite, fra la morte e un'esistenza disumana egli sceglie la morte. Ma il punto di partenza verso questa terribile alternativa è stata l'inerzia.
Coloro che si abbandonano all'inerzia, che dal mondo in cui vivono non traggono più alcuna energia vitale, non possono più prendere iniziative e agire, e sono anzi minacciati dalle iniziative degli altri. Non possono più accettare la realtà per quella che è; nel loro persistente infantilismo vedono la realtà soltanto nella prospettiva di chi nega ciecamente tutto ciò che è spiacevole, sorretto da una fede altrettanto cieca nella sua personale immortalità. Ne è un drammatico esempio l'esperienza che ebbe a subire la Lengyel. (14)
Ella racconta che, pur vivendo insieme con altri prigionieri a qualche centinaio di metri dai forni crematori e dalle camere a gas, e pur sapendo tutti, non meno di lei, a che cosa essi servissero, tuttavia, dopo mesi, la maggior parte dei suoi compagni si rifiutava di prenderne atto. (15) Se avessero preso coscienza della loro situazione reale, avrebbero potuto forse salvare una vita che erano destinati a perdere, o almeno quella di altre persone. Ma non potevano affrontare il rischio di questa presa di coscienza. Quando con la Lengyel molti altri prigionieri furono selezionati per le camere a gas, questi non tentarono di mettersi in salvo, come invece fece lei con successo. Peggio ancora, la prima volta che ci si provò, alcuni dei suoi compagni selezionati insieme con lei per la camera a gas chiamarono i guardiani per avvertirli che lei stava cercando di scappare. La Lengyel si chiede disperatamente: «Come era possibile che quelle persone negassero l'esistenza delle camere a gas, quando per tutto il giorno vedevano bruciare i forni e sentivano l'odore della carne bruciata? Come era potuto accadere che preferissero non credere allo sterminio solo per impedirsi di combattere per la propria stessa vita?». L'unica spiegazione che ella ci dà è che essi invidiavano chiunque riuscisse a sottrarsi al destino comune, perché a loro mancava il coraggio di farlo. Io credo invece che avessero perso ogni volontà di vivere, essendosi lasciati sopraffare dalla pulsione di morte. Ne risultava che si identificavano con le S.S., votate alla loro opera di distruzione, piuttosto che con quei compagni di prigionia che, ancora attaccati alla vita, cercavano di sfuggire alla morte.
- Abilità professionale, ma per che cosa?
Quando i prigionieri cominciavano a servire i propri persecutori aiutandoli ad affrettare la morte dei loro simili, le cose erano già andate oltre la semplice inerzia. Ad essa si era aggiunta, con violenza dirompente, la pulsione di morte. Coloro che si prestavano a servire i persecutori con il contributo della propria capacità professionale precedentemente acquisita non facevano che continuare a svolgere il proprio lavoro, o almeno a condurre la propria vita di sempre; ma accettando di farlo spalancarono la porta alla morte.
Quello che la Lengyel dice del dottor Mengele, medico S.S. ad Auschwitz, è tipico di uno che fa «il proprio lavoro come al solito», cosa questa che permetteva ad alcuni prigionieri, e certamente alle S.S., di conservare quel poco di equilibrio di cui avevano bisogno, nonostante quello che stavano facendo. La Lengyel ci descrive come, durante un parto, il dottor Mengele prendesse tutte le precauzioni prescritte, osservasse rigorosamente tutti i princìpi antisettici, eccetera; soltanto che mezz'ora dopo egli mandava sia la madre sia il bambino ai forni crematori. (16)
Pure, una volta fatta la scelta, il dottor Mengele e gli altri simili a lui dovevano, dopo tutto, illudersi qualche volta di saper vivere al livello della propria professione. Su questo argomento ho potuto consultare un solo documento personale, il diario del dottor Nyiszli, un prigioniero che serviva come «medico addetto alle ricerche» ad Auschwitz. (17) Come il dottor Nyiszli ingannasse se stesso si può desumere, ad esempio, dai ripetuti riferimenti alla sua qualità di medico, mentre invece non faceva che da assistente a un criminale. Egli parla dell'Istituto per le ricerche biologiche e antropologiche sulla razza come di «uno dei più qualificati centri medici del Terzo Reich» benché esso fosse stato creato per dimostrare delle falsità. Che il Nyiszli fosse un medico non cambia nulla: resta il fatto che egli, come qualsiasi altro prigioniero che serviva le S.S. addirittura meglio di quanto alcune S.S. fossero disposte a fare, era un collaboratore, un complice dei loro crimini. Come poteva, dunque, far questo e sopravvivere?
La risposta era: inorgogliendosi della propria abilità professionale, senza occuparsi dello scopo per il quale essa era usata. Questo orgoglio per la propria abilità professionale permea il racconto delle sue sofferenze e di quelle degli altri prigionieri. Ciò che qui importa è che il dottor Nyiszli, il dottor Mengele e centinaia di altri medici ancor più eminenti, tutte persone che si erano formate molto prima dell'avvento al potere di Hitler, partecipassero a quegli esperimenti umani e a quelle ricerche pseudo-scientifiche. E ciò che è tanto pericoloso è precisamente questo orgoglio per la propria abilità professionale e per il proprio sapere senza che si tenga conto delle conseguenze morali dell'attività svolta. Nella nostra società moderna, nella quale si dà tanta importanza alla competenza tecnica, è questa una caratteristica assai diffusa fra noi, anche se i campi di concentramento e i forni crematori non esistono più. Auschwitz è scomparso, ma fino a quando questo atteggiamento rimarrà in mezzo a noi, non saremo mai al sicuro dal pericolo costituito da questa indifferenza per l'essenza stessa della vita.
E' facile vedere che il raggiungimento di un delicato equilibrio fra gli estremi può creare un sistema di vita ideale: è più difficile accettare questa verità anche nell'olocausto. Tuttavia, anche in condizioni estreme, abbandonarsi e seguire soltanto il proprio cuore o la propria mente non è un buon metodo né per vivere né per sopravvivere. Tutto l'amore del signor Frank, il quale non viveva che per mantenere intatta la propria famiglia, non riuscì a salvare la vita dei suoi familiari, come invece avrebbe potuto fare un cuore più vigile.
Il dottor Nyiszli, sviato da un apprezzamento eccessivo per l'alto livello delle proprie cognizioni di patologo, e contro le indicazioni del cuore, si prestò a una tale degradazione di ciò che costituiva il suo massimo orgoglio, la sua scienza medica, che non possiamo fare a meno di chiederci che cosa veramente sia potuto sopravvivere di lui oltre il suo corpo.
Ho avuto occasione di incontrare parecchi antinazisti, sia ebrei sia non ebrei, sopravvissuti in Germania e nelle nazioni occupate dai Tedeschi, come il gruppo di Ungheresi che ho sopra descritto. Erano tutte persone che si erano rese perfettamente conto del fatto che, quando un mondo va in pezzi, quando la disumanità domina incontrastata, un uomo non può continuare il suo trantran quotidiano, come se niente fosse. In situazioni come questa si deve rimettere in causa tutto, si devono valutare sotto una luce radicalmente diversa tutte le nostre azioni, le nostre credenze, le nostre convinzioni. In altre parole, si deve prendere posizione nella nuova realtà, una posizione ben ferma, e non ritirarsi sempre più nel proprio guscio e nella propria vita privata.
Se oggi in Africa i neri marciano contro i fucili di una polizia creata per difendere "L'apartheid", questa marcia, questa lotta assicureranno loro prima o poi una possibilità di libertà e di uguaglianza, anche se centinaia di loro saranno uccisi e decine di migliaia rinchiusi in campi di concentramento. Quei milioni di Ebrei europei che non fuggirono, oppure non lo fecero in tempo, o non riuscirono a darsi alla macchia come fecero invece altre migliaia di loro, avrebbero almeno potuto marciare come uomini liberi contro le S.S., piuttosto che strisciare davanti a loro per poi aspettare di essere rinchiusi in un campo prima di venir sterminati e, alla fine, incamminarsi docilmente verso le camere a gas.
Eppure la storia dei campi di sterminio mostra che, perfino in un ambiente così oppressivo, alcune forme di difesa offrono un certo grado di protezione: la difesa più importante è capire quello che sta accadendo in noi stessi e perché. Sviluppando un certo grado di comprensione l'individuo non ingannerà se stesso con la convinzione che qualunque tipo di adattamento all'ambiente avrà la virtù di proteggerlo. Al contrario, sarà in grado di riconoscere che molti di quei comportamenti che superficialmente sembrano idonei a proteggerlo sono in realtà distruttivi. Ne abbiamo un esempio estremo in quei prigionieri che volontariamente si offrirono di lavorare per le camere a gas nella speranza che questo loro atto li avrebbe in qualche modo salvati. Dopo qualche tempo venivano tutti uccisi molti di loro, anzi, morivano anche prima degli altri; dopo settimane di una vita ancora più orribile di quella che sarebbe stata se non si fossero offerti per quel lavoro.
- Reagire contrattaccando.
Nessuno di quei miseri condannati a morte reagì contrattaccando? Nessuno di loro scelse di morire affermando la propria personalità, attaccando le S.S. in vece di lasciarsi andare? Soltanto pochissimi lo fecero, e fra questi un gruppo: il dodicesimo "Sonderkommando", formato da internati che lavoravano alle camere a gas. (19) Tutti questi "Kommando" conoscevano perfettamente quello che li aspettava, dato che il primo compito di ogni nuovo "Sonderkommando" era di cremare i cadaveri dei membri del "Kommando" che li aveva preceduti e che era stato sterminato poche ore prima.
In quest'unico caso di rivolta del dodicesimo "Sonderkommando" vennero uccise settanta S.S., compreso un ufficiale e diciassette sottufficiali; fu poi totalmente distrutto uno dei forni crematori e seriamente danneggiato un secondo. Naturalmente tutti gli ottocentocinquantatré prigionieri del "Kommando" morirono. Ma il loro tentativo dimostrò che un posto nei "Sonderkommando" dava ai prigionieri la possibilità di uccidere una S.S. ogni dieci di loro all'incirca, percentuale assai più alta che nei comuni posti nel campo.
I membri dell'unico "Sonderkommando" che si rivoltò facendola pagare così cara al nemico non morirono molto diversamente da tutti quelli degli altri "Sonderkommando". Perché allora - e questa è la domanda che angoscia tutti coloro che studiano i campi di sterminio -, perché allora milioni di persone si avviarono quietamente e senza far resistenza verso la morte, quando proprio davanti agli occhi avevano l'esempio di questo "Kommando" che era riuscito a distruggere in parte e in parte danneggiare le loro camere della morte e a uccidere un numero di S.S. pari al dieci per cento dei propri membri? Perché fra quei milioni di prigionieri così pochi morirono da uomini? Perché gli altri "Kommando" non si rivoltarono anch'essi invece di marciare docilmente verso la morte? Perché quella fu un'eccezione?
Un altro di questi rari esempi di suprema affermazione di sé può forse far luce sulla questione. Un giorno, un gruppo di prigionieri nudi stavano in fila davanti alla camera a gas pronti ad entrarci. Non si sa come, uno degli ufficiali delle S.S. di servizio venne a sapere che una delle prigioniere era stata una ballerina. Egli le ordinò di danzare per lui; lei obbedì, e danzando gli si avvicinò, gli prese il fucile e gli sparò, uccidendolo. Anche lei fu immediatamente uccisa. (20)
Non può forse darsi che, nonostante il tremendo palcoscenico sul quale danzava, la danza abbia di nuovo fatto di lei una persona? Quando le fu ordinato di danzare, di esplicare quella che un tempo era stata la sua vocazione liberamente accettata, lei si differenziò dagli altri, ritornò un individuo; non era più un numero, una prigioniera senza nome e senza personalità, ma la ballerina di un tempo. Trasformata, anche se per pochi attimi, reagì come avrebbe reagito il suo vecchio io, distruggendo il nemico che stava per distruggerla, anche se ciò l'avrebbe condotta alla morte.
Nonostante le centinaia di migliaia di morti viventi che quietamente si incamminavano verso la fossa, questo solo esempio (e ce ne furono alcuni altri simili) indica che, appena decidiamo spontaneamente di non essere più una semplice unità di un sistema, possiamo riacquistare di colpo l'antica personalità e annullare l'opera distruttiva da essa subita. Fruendo dell'ultima libertà che le era rimasta e che nemmeno il campo di concentramento aveva potuto sottrarle - cioè di scegliere il proprio modo di pensare e di sentire nei confronti delle condizioni in cui viveva - quella ballerina evase dalla sua vera prigione, e poté farlo perché accettò di rischiare la vita per raggiungere ancora una volta la propria autonomia. Se faremo come lei, potremo almeno morire virilmente, se virilmente non possiamo vivere.
NOTE al capitolo 6.
Nota 1: B. Kautsky, op. cit., pagine 119-21.
Nota 2: "Nazi Conspiracy and Aggression". vol. 1, pag. 949.
Nota 3: Anche i prigionieri di guerra ateniesi furono costretti a lavorare fino alla morte per esaurimento nelle cave di Siracusa. Ma anche in questo caso era lo Stato che sfruttava il loro lavoro, e non capitalisti privati. Questa analogia tra le cave di Siracusa e quelle di Mauthausen, più di 2000 anni dopo, è comunque spaventosa.
Nota 4: B. Kautsky, op. cit., pag. 118.
Nota 5: E. Roditi, "The Criminal as Public Servant", in «Commentary», 28, novembre 1959, pagine 431 sgg. Per contrasto, riporterò dall'autobiografia di Hoess (R. Hoess, "Kommandant in Auschwitz", Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1958, pag. 71 [trad. it. Torino, 1960]) un brano che mostra in lui un barlume di umanità, quando non era ancora arrivato all'ultimo stadio del processo di disumanizzazione: «Un caso mi turbò profondamente. Un sergente delle S.S., col quale avevo frequenti rapporti perché aveva il compito di accompagnare nel mio ufficio i prigionieri importanti e di trasmettermi certi rapporti segreti, mi fu improvvisamente portato davanti una notte perché fosse giustiziato seduta stante. Proprio il giorno prima avevamo passato un po' di tempo insieme nella sala della mensa parlando a lungo delle recenti esecuzioni. Ora era il suo turno, e io dovevo obbedire agli ordini. Questo era troppo anche per il mio Comando. Dopo l'esecuzione facemmo una lunga passeggiata in silenzio per riprenderci. Dalle guardie che lo avevano accompagnato venimmo a sapere che quel sergente aveva ricevuto l'ordine di arrestare un ex membro del partito comunista e di portarlo nel campo. Avendolo dovuto sorvegliare a lungo (quando era un civile) aveva avuto occasione di conoscere bene l'individuo che ora doveva arrestare, il quale fra l'altro si era sempre comportato bene, obbedendo a tutte le norme e a tutti gli ordinamenti. Perciò, per pura gentilezza, gli permise di fermarsi a casa sua per cambiarsi d'abito e salutare la moglie. Mentre il sergente e un altro poliziotto parlavano con la moglie di costui nella stanza di soggiorno, l'individuo che doveva essere arrestato fuggì. Quando il sergente fece il suo rapporto sulla fuga, fu messo immediatamente agli arresti e, entro lo spazio di un'ora, una corte marziale lo condannò a morte. Il poliziotto che lo aveva accompagnato (e che pure non era stato incaricato dell'arresto) fu condannato a diversi anni di prigione... Il sergente delle S.S. che giustiziammo quella notte era sempre stato un buon cittadino, aveva circa trentacinque anni ed era sposato con tre bambini; era sempre stato estremamente coscienzioso e ligio al dovere, e ora aveva pagato con la vita un gesto di gentilezza e una prova di fiducia. Egli affrontò la morte con dignità». La morale di questa storia è abbastanza chiara: il caso aveva «turbato profondamente» Hoess, probabilmente perché esso costituiva un nuovo avvertimento: permettersi un qualsiasi sentimento di umanità poteva portare solo alla morte.
Nota 6: «Time», L. 21, 24 novembre 1947, pag. 33.
Nota 7: Perfino Hoess nelle sue memorie si chiede come mai i prigionieri non si ribellassero, dato che per l'ampiezza del loro numero avrebbero potuto farlo agevolmente.
Nota 8: La certezza di morire rendeva il loro caso diverso da quello dei prigionieri, che potevano ancora sperare di essere liberati.
Nota 9: Questo meccanismo differisce solo nel grado dall'uso diffuso della proiezione come difesa psicologica nei campi di concentramento «ordinari».
Nota 10: Per esempio, quei prigionieri che mangiavano la loro intera razione subito dopo averla ricevuta non avevano poi niente per sostenere le loro vacillanti energie verso la fine della giornata di lavoro. Coloro invece che ne mettevano in serbo una parte per quando l'esaurimento fisico fosse stato eccessivo, si nutrivano più intelligentemente.
Nota 11: Anche nella storia dei Frank possiamo trovare questo particolare: essi non facevano che bisticciarsi per delle sciocchezze, invece di sostenersi a vicenda per meglio resistere all'influsso demoralizzante delle condizioni in cui erano costretti a vivere.
Nota 12: E' da sottolineare quanto diverso fosse questo comportamento da quello dei Frank: essi scelsero un nascondiglio che in fondo era soltanto una trappola; durante tutti quei mesi non si preoccuparono nemmeno di approntare un'uscita di sicurezza, attraverso la quale alcuni membri del gruppo avrebbero potuto cercare di scappare, mentre uno o due degli uomini della famiglia bloccava o difendeva una delle entrate. E' anche interessante notare che il signor Frank insegnava ai ragazzi argomenti tipicamente accademici e scolastici, invece di insegnar loro come aprirsi un passaggio: altro esempio, questo, della sua incapacità di affrontare la possibilità di morire.
Nota 13: Anche i Frank rimandarono continuamente il momento di nascondersi, perché desideravano innanzitutto trasferire nel loro nascondiglio la maggiore quantità di beni possibile. Rimandarono tanto che per la sorella di Anna fu già troppo tardi: infatti, era già stata convocata dalla Gestapo.
Nota 14: O. Lengyel, "Five Chimneys. The Story of auschwitz", Ziff Davis, Chicago, 1947, pagine 54-55-
Nota 15: Anche i cittadini tedeschi non ebrei che vivevano fuori dei campi negavano l'esistenza delle camere a gas, ma per loro questa negazione aveva un altro significato. A quel tempo, i civili che affrontavano la realtà e si ribellavano non facevano che attirarsi la morte, mentre i prigionieri ad Auschwitz erano già condannati.
Nota 16: Op. cit., pag. 147.
Nota 17: M. Nyiszli, "Auschwitz: a Doctor's Eyewitness Account", Frederick Fell Inc., New York, 1960.
Nota 18: Fra i medici primari di cliniche o direttori di istituti che parteciparono coscientemente agli esperimenti erano i professori Sauerbruch dell'Università di Monaco ed Eppinger dell'Università di Vienna, i quali avevano insegnato a intere generazioni di medici prima dell'avvento di Hitler al potere. Anche il dottor Gebhardt, presidente della Croce Rossa tedesca, era uno di loro. (Confronta A. Mitscherlich e F. Mielke, "Doctors of Infamy", Henry Schuman Inc., New York, 1949).
Nota 19: M. Nyiszli, op. cit. Di sporadiche rivolte nei campi di sterminio (Treblinka, eccetera) è fatta menzione qua e là nei vari libri sui campi, anche se non ho avuto modo di consultare rapporti redatti da testimoni oculari. Rivolte di civili cominciarono ad aversi soltanto quando l'andamento della guerra si fece avverso alla Germania, ma, come nel caso dell'insurrezione di Varsavia, era ormai troppo tardi per i milioni di persone già morte.
Nota 20: E. Kogon, op. cit., pag. 132.