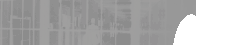LA PRIGIONE: UN'ISTITUZIONE HORS LA LOI.
(Compendio di un'intervista apparsa su «R de Reel», 3, aprile 2000).
DOMANDA - In "Parola d'ordine: tolleranza zero" viene sostenuta la
tesi secondo cui esisterebbe uno stretto legame fra l'ascesa del neoliberalismo
e l'incremento delle politiche sicuritarie, prima negli Stati Uniti e quindi
in Europa. Un simile sviluppo viene riassunto in un'espressione lapidaria: «Declino
dello stato economico, diminuzione dello stato sociale e glorificazione dello
stato penale».
RISPOSTA - La formula intende in primo luogo sottolineare l'impossibilità
di comprendere le politiche poliziesche e penitenziarie delle attuali società
avanzate prescindendo da un'attenta considerazione delle profonde trasformazioni
dello stato, legate alle mutazioni intervenute nel mondo del lavoro e alla modifica
dei rapporti di classe. In tale contesto, il padronato e le frazioni «modernizzatrici»
della borghesia e dei boiardi di stato, schierati sotto le insegne del neoliberalismo,
hanno avuto la meglio, impegnandosi in una vasta campagna di attacco nei confronti
dell'intervento pubblico. Deregulation sociale, incremento della precarietà
salariale (sulla base della disoccupazione di massa in Europa e della «miseria
laboriosa» negli Stati uniti) e ripresa dello stato punitivo vanno di
pari passo: la «mano invisibile» del mercato del lavoro precarizzato
trova il proprio complemento istituzionale nel «pugno di ferro»
dello stato che riformula la propria operatività per "stroncare
i disordini generati dalla diffusione dell'incertezza sociale".
Alla regolazione delle classi subalterne attraverso quella che Pierre Bourdieu
definisce «la mano sinistra dello stato», emblematizzata dall'educazione,
la sanità, l'assistenza o l'edilizia popolare, si "sostituisce"
- negli Stati uniti - e si "aggiunge" - in Europa - la regolazione
attraverso «la mano destra», ossia polizia, giustizia e carcere,
sempre più attiva e intrusiva nelle zone inferiori dello spazio sociale.
La riaffermazione ossessiva del «diritto alla sicurezza», correlativa
alla derelizione del «diritto al lavoro» nelle sue forme tradizionali
(quindi a tempo pieno, con garanzie sociali, a tempo indeterminato e con un
salario dignitoso), e la crescita di interesse e mezzi accordata alle funzioni
di mantenimento dell'ordine pubblico colmano così il vuoto di legittimità
che grava sul personale politico impegnato nel promuovere la dismissione, da
parte dello stato, delle funzioni economiche e sociali.
In sintesi, la svolta sicuritaria attuata dal governo di Jospin nel 1997, o
da quelli di Massimo D'Alema e Tony Blair l'anno seguente, non ha particolari
legami con la presunta «esplosione della delinquenza giovanile»,
che le statistiche mostrano essere un fenomeno di limitate dimensioni, o con
le famigerate «violenze urbane» (termine che rappresenta un vero
e proprio "non sense" statistico e sociologico) care ai media. Diversamente,
ha molto a che fare con la generalizzazione della condizione salariale priva
di garanzie sociali e con l'instaurazione del regime politico in grado di supportarla.
Si tratta di un regime che definirei «liberal-paternalistico», "liberale"
in alto, nei confronti delle imprese e delle categorie privilegiate, e "paternalista"
e punitivo in basso, verso coloro che si trovano presi nella morsa fatta di
ristrutturazione del lavoro e di declino delle protezioni sociali, o della loro
riconversione in strumenti di sorveglianza. Per rendersi conto di tutto ciò
è sufficiente uscire dalla problematica egemone del «delitto e
castigo» (particolarmente radicata presso i criminologi, rappresentando
in qualche modo l'assioma fondativo della loro disciplina), riproposta "ad
nauseam" da politici e giornalisti proprio per il fatto che appare ovvia
e nessuno avverte l'esigenza di sottoporla ad analisi critica.
D - Il libro segue la crescita dello stato carcerario negli Stati Uniti, paese in cui la deregulation dell'economia e lo smantellamento dello stato sociale si è accompagnato a un enorme sviluppo del sistema carcerario, in una fase, peraltro, in cui il tasso di criminalità da prima ristagna per poi iniziare a decrescere. A fronte di ciò, come hanno fatto i poteri pubblici a giustificare il radicale mutamento di indirizzi?
R - In seguito alla svolta politica e razziale intervenuta lungo gli anni settanta, che ha portato Ronald Reagan alla Casa bianca, gli Stati Uniti hanno provveduto a sostituire il loro (semi)stato sociale con uno stato poliziesco e penitenziario all'interno del quale la "criminalizzazione della povertà" e la reclusione delle categorie più diseredate svolge la funzione di politica sociale nei confronti delle fasce più demunite. L'avvento dello stato penale negli Stati Uniti può essere riassunto in cinque punti.
1) Crescita ipertrofica della popolazione carceraria, quadruplicata negli ultimi vent'anni e giunta oggi a due milioni di effettivi, la metà dei quali condannati per reati non violenti. Il tasso di carcerazione si attesta a 740 detenuti ogni 100 mila abitanti, otto volte più alto di quello di Francia, Italia e Germania - nel 1960 era solo il doppio - e due volte quello del Sudafrica al culmine della lotta contro l'apartheid.
2) Estensione continua della tutela giudiziaria, esercitata attraverso le condanne con la condizionale o la libertà su cauzione, che grava oggi su quasi sei milioni dl americani, ossia un maschio adulto su venti e un giovane di colore su tre, alimentando inoltre la proliferazione di banche dati riguardanti la criminalità, alcune delle quali liberamente consultabili tramite Internet, e la schedatura genetica. (Una nuova era del panottismo si è aperta nel 1994 con l'approvazione da parte del Congresso del D.N.A. Identification Act che ha predisposto l'istituzione, sotto l'egida dell'F.B.I., di una banca nazionale dei dati genetici, entrata in servizio nel 1998 e che, in temi brevi, dovrebbe contenere le «impronte del D.N.A.» di tutti i condannati in sede penale, se non addirittura di ogni persona arrestata dalla polizia.)
3) Decuplicazione dei mezzi a disposizione delle amministrazioni penitenziarie, divenute il terzo datore di lavoro del paese con più di 600 mila addetti, subito dopo la prima azienda al mondo per cifra d'affari, ossia la General Motors, e il gigante della distribuzione Wal Mart. Nello stesso periodo, i budget a disposizione dei servizi sociali sanitari ed educativi hanno subito tagli draconiani: durante gli anni ottanta, a un decremento del 41 percento dei fondi destinati all'assistenza sociale ha corrisposto un aumento del 95 percento di quelli indirizzati alle prigioni.
4) Il ridimensionamento dei finanziamenti allocato ai servizi sociali, tuttavia, non sarebbe stato in grado di garantire la «grande reclusione» di poveri e precari senza il concorso del settore privato: la carcerazione a scopo di lucro ha in tal modo fatto la sua ricomparsa a partire dal 1983, accaparrandosi rapidamente un dodicesimo del mercato, ossia 150 mila detenuti, tre volte la popolazione penitenziaria della Francia. Le imprese del settore, quotate in borsa sul listino Nasdaq, manifestano tassi record di profitto e crescita, tanto da divenire il fiore all'occhiello di Wall Street. La new economy statunitense non è quindi fatta solo di Internet e tecnologie dell'informazione, ma anche di industria della punizione! A titolo indicativo, è interessante notare come le prigioni di stato della California impieghino il doppio di salariati rispetto a Microsoft...
5) L'ultima tendenza su cui soffermiamo l'attenzione non appare meno degna di nota. Si tratta del progressivo «innerimento» dei reclusi: nel 1989, per la prima volta, gli afroamericani, che rappresentano il 7 percento della popolazione del paese, forniscono la maggioranza dei carcerati. La prigione diviene così un prolungamento-sostituto del ghetto, entrato in crisi in seguito all'ondata di rivolte urbane degli anni sessanta (1).
La politica sicuritaria del cosiddetto «Law and Order», che si
sviluppa a partire dagli anni settanta alimentando l'inflazione carceraria,
si presenta in primo luogo come una risposta ai movimenti sociali degli anni
sessanta, in particolare alle conquiste del movimento nero. (Le politiche sicuritarie
devono buona parte della loro attrattiva al fatto che esse permettono di esprimere
in un idioma apparentemente civico - garantire la pace e la tranquillità
dei cittadini - il rigetto nei confronti della domanda nera di eguaglianza o,
specialmente in Europa, il rifiuto xenofobo dei migranti provenienti dal Terzo
mondo.) La destra americana si impegna allora in un vasto programma di riarmo
intellettuale, perseguito attraverso la creazione di think tank, istituti di
consulenza nell'ambito delle politiche pubbliche, volti a svolgere il ruolo
di rampe di lancio per una guerra ideologica contro lo stato sociale indissociabile
dall'opposizione all'integrazione degli afroamericani. Dopo aver vinto la battaglia
contro il settore assistenziale dello stato, gli istituti neoconservatori si
impegnano nella promozione del settore repressivo: al «meno stato»
sociale ed economico succede il tema del «più stato» poliziesco
e penale, che ne rappresenta il pendant in materia di «giustizia».
A New York, per esempio, il Manhattan Institute riesuma e promuove la teoria
del «vetro rotto» (nonostante sia scientificamente discreditata)
per legittimare la «tolleranza zero» proposta da Rudolph Giuliani.
La politica inaugurata dal sindaco di New York si traduce in una vera e propria
«pulizia di classe» dello spazio pubblico, perseguita attraverso
la cacciata da strade, parchi, treni eccetera dei poveri, percepiti come minacciosi.
Per applicarla, il capo della polizia cittadina ha trasformato la sua amministrazione
in un'autentica «impresa di sicurezza», con obiettivi prestabiliti
di abbassamento della criminalità da conseguire mensilmente, costi quel
che costi, grazie all'apporto di 12 mila agenti supplementari, che portano il
totale degli effettivi delle forze di polizia a 48 mila, una cifra che è
istruttivo paragonare a quella dei 13 mila dipendenti rimasti ai servizi sociali,
dopo la riduzione del 30 percento del personale intervenuta nel corso degli
ultimi cinque anni. La «tolleranza zero», all'atto pratico, si traduce
nella molestia permanente ai danni dei giovani neri o degli immigrati in strada,
in arresti massicci e spesso abusivi nei quartieri poveri, nell'intasamento
dei tribunali, nella continua crescita della popolazione sotto chiave e in un
clima di aperta sfiducia e ostilità fra la polizia e i newyorkesi neri
o latinos. In seguito alla morte di Amadou Diallo, Malcolm Ferguson e Patrick
Desmond, tre giovani di colore uccisi senza alcuna ragione nel corso di un anno
da agenti dal grilletto facile, incidenti assai rivelatori del livello di diffusione
delle violenze poliziesche, questa aggressiva politica di mantenimento dell'ordine
è divenuta oggetto di pesanti critiche anche a New York e presso i suoi
maggiori beneficiari, ossia la classe media bianca. Ciò non impedisce,
tuttavia, alla «tolleranza zero» di esercitare il proprio fascino
in Europa.
D - Colbert, nel 1662, indirizzandosi ai parlamentari si esprimeva nei seguenti termini: «Sua Maestà, desiderando ristabilire il corpo delle galere e rafforzare in tutti i modi la ciurma, auspica che il vostro corpo invii il maggior numero possibile di condannati alle galere, trasformando anche la condanna a morte in una simile pena». I galeotti rappresentavano così per il potere una fonte gratuita di mano d 'opera. In "Sorvegliare e punire", Michel Foucault nota che la prigione è, ancora più della galera, funzionale al potere economico. In questa fase, siamo forse ritornati a una situazione del genere?
R - Risponderei sì e no. Lo sfruttamento economico dei prigionieri non
rappresenta certo la causa o la ragione dell'enorme aumento della popolazione
carceraria negli Stati uniti e, su scala ridotta, in Europa. Ciò avviene
senza dubbio nella fase inaugurale dell'imprigionamento penale: nel sedicesimo
secolo, il Bridwell di Londra, la Zuchthaus di Amsterdam e l'Hôpital di
Parigi sono chiamati a svolgere tre funzioni fra loro indissociabili: confinare,
riformare e mettere al lavoro. George Rusche e Otto Kirchheimer, in "Pena
e struttura sociale", mostrano che allora l'imprigionamento aveva lo scopo
di «rendere socialmente utile la forza lavoro di coloro che rifiutano
di lavorare» inculcando coattivamente la sottomissione al lavoro, in modo
che i prigionieri, al momento della liberazione, contribuissero spontaneamente
«a ingrossare le fila di chi era alla ricerca di un impiego» (2).
Tutto ciò non è più vero già dalla fine del diciottesimo
secolo, il periodo preso in considerazione da Foucault, e per il ventesimo secolo
sembra valere l'esatto contrario. Oggi, le prigioni sempre più spesso
operano come luogo di deposito degli scarti del mercato del lavoro, delle "frazioni
deproletarizzate e sovrannumerarie" della classe operaia, piuttosto che
dell'esercito industriale di riserva. Negli Stati uniti, solo un detenuto su
otto svolge un lavoro, in Europa la percentuale è ancora più bassa.
Qualunque cosa pensino i critici del cosiddetto «complesso carcerario-industriale»,
la detenzione, per i suoi costi stratosferici (25 mila dollari all'anno per
un ospite dei penitenziari di stato californiani, che divengono 70 mila a New
York), non rappresenta per la società un'impresa redditizia.
Sarebbe errato individuare un legame "diretto" fra carcerazione e
profitto economico. Ciò non significa affatto negare alla reclusione
di massa una funzione economica "indiretta", consistente nel disciplinare
le frazioni più recalcitranti del nuovo proletariato dei servizi, elevando
i costi delle strategie di attesa o di fuga nell'economia informale o illecita
di strada. Inoltre, l'ascesa del liberal-paternalismo non deve essere pensata
solo in termini di sfruttamento e repressione. Diversamente, esso deve essere
concepito, come suggeriva Michel Foucault a proposito della sessualità,
nel segno della "produzione" (3). La transizione dallo stato assistenziale
allo stato punitivo è infatti eminentemente produttiva, di nuove categorie,
per esempio, come quelle riguardanti i «quartieri a rischio» abitati
da «popolazioni problematiche» predisposte alle «violenze
urbane», o di stupidi slogan del tipo «tolleranza zero», che
secondo alcuni dovrebbero essere applicati in tutti i casi in cui si devono
riaffermare gerarchie discreditate (strada, scuola, famiglia, impresa). Ma produttrice
anche di nuovi discorsi, come quello sciorinato in Francia dalla «sinistra
plurale» a proposito della «sicurezza» (intesa nel senso di
mera sicurezza fisica delle persone e dei beni, a prescindere da qualsiasi considerazione
sociale o economica) che, attraverso un paradossale rovesciamento, presenta
la tutela poliziesca e penale dei quartieri popolari come una conquista sociale
di cui i residenti sarebbero i principali beneficiari. Produttiva infine di
nuove istituzioni e nuovi agenti, come le imprese di «consulenza in sicurezza»
e gli «ausiliari di sicurezza», o di dispositivi giuridici quali
il rito abbreviato e la composizione penale che, con il pretesto dell'efficienza
burocratica, instaurano una giustizia differenziata in base alle origini etniche
e di classe.
In sintesi, il trattamento penale della precarietà crea «realtà»,
e una realtà tagliata su misura per legittimare, in conformità
al principio della profezia che si autoavvera, l'ascesa dello stato penale.
Un esempio: trasformando qualsiasi caso di indisciplina scolastica in un atto
di delinquenza sistematicamente segnalato al tribunale, si produce artificialmente
un'epidemia di «violenze urbane» che, con l'aiuto dei media, risulta
utile per giustificare la «partnership scuola-polizia» che ha generato
quella stessa epidemia.
D - In Francia periodicamente emergono ondate di sdegno nei confronti delle condizioni di vita nelle prigioni: sovraffollamento, strutture fatiscenti, miseria, violenza, abusi sessuali eccetera. Negli ultimi tempi, il libro del medico del carcere parigino di la Santé, Véronique Vasseur, ha suscitato una ridda di servizi giornalistici, seguiti dalla costituzione di una commissione d'inchiesta e da sollecite dichiarazioni da parte di diversi parlamentari (4). Che cosa pensa di questa vicenda?
R - Sarebbe bello pensare che sia sempre meglio parlare delle prigioni che
non parlarne affatto, se non altro per spezzare l'omertà che circonda
l'istituzione. Tuttavia esistono dei modi di parlarne che possono rivelarsi
controproducenti, dando l'illusione di affrontare il problema mentre altro non
fanno che evitarlo.
Per esempio, nonostante la logorrea scatenata dal racconto delle «scene
di vita quotidiana» di la Santé, che non hanno affatto sorpreso
coloro che hanno un minimo di conoscenza della realtà della reclusione,
è sconcertante notare come né i giornalisti (che in realtà
dibattono solo fra di loro) né i politici abbiano ritenuto opportuno
leggere le più recenti ricerche in proposito: ne esistono di notevoli,
basate su indagini sul campo estremamente dettagliate e metodiche e non su osservazioni
estemporanee e superficiali (5). Viene da chiedersi per quale motivo lo stato
paghi i sociologi. Sono inoltre rimasto sorpreso dal "tono moralistico"
del dibattito. Si finge di scoprire, scandalizzandosi, che le prigioni della
Francia non sono «degne della patria dei diritti dell'uomo», quando
proprio in forza della legge l'istituzione penitenziaria opera ai margini del
diritto, in assenza di ogni controllo democratico, nell'arbitrio amministrativo
e nell'indifferenza generale (penso a quella diffusa manifestazione del dispotismo
burocratico rappresentata dal "prétoire", il tribunale interno
del carcere in cui l'amministrazione decide della vita di esseri umani senza
alcun controllo o possibilità di ricorso, con la sola preoccupazione
di mantenere l'ordine all'interno dell'istituto). La prigione, che dovrebbe
far rispettare la legge, si presenta infatti, per la sua stessa organizzazione,
come un'istituzione "hors la loi". Considerata un rimedio all'insicurezza
e alla precarietà, altro non fa che rafforzare le tendenze che dovrebbe
combattere, ma con il vantaggio di renderle "invisibili". In fondo
è tutto ciò che le viene chiesto.
Coloro che sono veramente interessati alle condizioni dei detenuti non hanno
dovuto attendere la pubblicazione del diario della dottoressa Vasseur. In tal
senso, era sufficiente sfogliare uno studio del ministero della Giustizia datato
1997 - o quelli precedenti, di cui curiosamente il ministro Elisabeth Guigou
afferma di non avere alcuna conoscenza - per apprendere che un carcerato su
quattro vive in condizioni «estremamente difficili, se non addirittura
allarmanti», rinchiuso ventidue ore al giorno in una cella di nove metri
quadrati condivisa con altre due o tre persone. Per quanto riguarda il trattamento
brutale dei detenuti, gli atteggiamenti razzisti, le umiliazioni subite da familiari
e visitatori, la miseria materiale e le violenze quotidiane, tutto era da tempo
noto e ampiamente documentato.
Il dibattito suscitato dal libro di Véronique Vasseur, inoltre, ha eluso
la vera questione di fondo, ossia: a che cosa serve la prigione nel ventunesimo
secolo? Porla avrebbe significato realizzare che nessuno ha le idee chiare sul
motivo per cui "si ricorre alla reclusione delle persone". Solitamente
viene invocata la filosofia terapeutica, si finge di credere che lo scopo della
prigione consisterebbe nel «rieducare» e «reinserire»
i suoi ospiti, mentre tutto, dall'architettura all'organizzazione del lavoro
di sorveglianza, passando per l'indigenza delle risorse istituzionali (per il
lavoro, la formazione, la scolarità e la sanità), i sempre maggiori
ostacoli alla concessione della libertà condizionale e l'assenza di concreti
aiuti al momento dell'uscita dal carcere, contraddice patentemente un simile
proposito. La frase di un agente carcerario si rivela, in proposito, particolarmente
eloquente: «Il reinserimento serve per tranquillizzare la coscienza di
qualcuno. Non della gente come me, ma dei politici. In prigione accade lo stesso.
Quante volte mi sono sentito dire 'capo, non preoccuparti, non ci ricasco più!',
e sei mesi dopo, paf... "Il reinserimento non può essere fatto in
prigione. E' troppo tardi". Bisogna "inserire" le persone dando
del "lavoro", e le stesse opportunità "all'inizio, a scuola".
Bisogna promuovere una politica di inserimento» (6). Ma se si è
incapaci di «inserire» i giovani disoccupati, pensate quale può
essere la sorte degli ex detenuti!
Negli Stati uniti le cose appaiono a un primo sguardo più chiare: gli
ideali di riabilitazione sono stati deliberatamente gettati alle ortiche a favore
dell'obiettivo di «neutralizzare» i criminali violenti. Ma allora
come si giustifica la reclusione di un milione di piccoli delinquenti che non
rappresentano un pericolo per nessuno? E visto che la dissuasione si rivela
patentemente inefficace, si è passati alla retribuzione: «Fare
in modo che il detenuto si senta detenuto», ecco il nuovo slogan penitenziario
americano. Umiliare e recludere per fare male, punire per punire. Ma l'opinione
pubblica, quando si accorge dei costi umani e finanziari di questo «teatro
della sofferenza» penale, comincia a rivelarsi meno entusiasta. In realtà,
ci troviamo all'interno di quella che il sociologo scozzese David Garland definisce
«crisi del modernismo penale» (7), dalla quale non si uscirà
senza l'impegno in una riflessione di fondo, "politica" nel senso
alto del termine e spregiudicata, sul senso della pena e della carcerazione.
La vera sfida, in questo caso, consiste non tanto nel tentare di migliorare
le condizioni di detenzione (compito tuttavia assolutamente urgente), quanto
nel promuovere una "rapida diminuzione della popolazione reclusa",
promuovendo un'attiva politica di "decarcerizzazione" attraverso lo
sviluppo di pene alternative alla privazione della libertà. Se infatti
non si conoscono i motivi per i quali si ricorre alla reclusione, ben noti sono
gli effetti distruttivi e destrutturanti che il passaggio attraverso il carcere
produce non solo sui detenuti ma anche sulle persone a essi legate. Per fare
un esempio, la Francia, riattivando la condizionale, limitando il ricorso alla
carcerazione preventiva e agendo intelligentemente su condoni e amnistie, potrebbe
passare in soli due anni da 54 mila a 24 mila detenuti, senza alcun danno per
la sicurezza dei cittadini.
D - Quale può essere il ruolo degli intellettuali nel suscitare un simile dibattito? Non sarebbe opportuno intensificare gli interventi e le prese di posizione sulla stampa al fine di raggiungere un settore più ampio di opinione pubblica?
R - Devo confessare che la domanda rivela una certa ingenuità a proposito
dei media. Oltre al fatto che i lettori dei grandi quotidiani non rappresentano
da soli «l'opinione pubblica», è necessario sottolineare
come la qualità scientifica e la forza delle idee non costituiscano certo
un viatico per accedere alle pagine dei giornali. Un'elementare sociologia della
professione mostra come i giornalisti apprezzino e celebrino in primo luogo
chi la pensa come loro, secondo schemi giornalistici improntati al senso comune
politico e sociale del momento. Non si tratta di un limite individuale, ma di
un vincolo strutturale (8). Ciò che rompe con il tranquillo scorrere
della politologia flaccida che rappresenta il loro strumento di apprensione
della società ha ottime probabilità di essere percepito come un'aggressione,
o di passare del tutto inosservato (chiedete alla redazione di «Libération»
perché un quotidiano che si vorrebbe progressista e critico, pur dedicando
in pratica almeno un articolo al giorno ai problemi della giustizia, non ha
ritenuto opportuno scrivere nemmeno una riga sul mio libro, nonostante esso
sia stato tradotto in otto lingue e abbia conosciuto una notevole diffusione
fra i militanti e i detenuti).
Oggi i grandi media, oltre a non essere uno strumento di dibattito democratico,
rappresentano un ostacolo allo sviluppo di un reale dibattito. Ciò conduce
a sottolineare l'esigenza di ricorrere ad altre forme di comunicazione, riviste,
newsletter, fanzine, forum, ricercando sostegno presso sindacati, coordinamenti
e collettivi impegnati in diversi ambiti di lotta sociale. I ricercatori, da
parte loro, proprio per il loro modo di porre le questioni in maniera critica
possono svolgere un ruolo fondamentale, riformulando in termini audaci e realistici
la problematica della pena e impegnandosi, con avvocati, militanti, prigionieri
e familiari, per fare finalmente entrare la prigione all'interno della città.
NOTE.
N. 1. Su questo aspetto controverso della carcerazione di massa statunitense:
L. Wacquant, "The New «Peculiar Institution»: On Prison as
Surrogate Ghetto", in «Theoretical Criminology», numero speciale,
2000.
N. 2. G. Rusche, O. Kirchheimer, "Pena e struttura sociale", cit.
N. 3. M. Foucault, "La volontà di sapere", Feltrinelli, Milano
1978.
N. 4. V. Vasseur, "Médecin-chef à la Santé",
Le Cherche-Midi, Paris 2000.
N. 5. Fra esse possono essere citate: P. Combessie, "Prisons des villes
et des champs", Editions de l'Atelier, Paris 1996; D. Welzer-Lang, L. Mathieu,
M. Fauré, "Sexualités et vtolences en prison", Aléas,
Lyon 1996; A.-M. Marchetti, "Pauvretés en prison", cit.; C.
Rostaing, "La relation carcérale. Identités et rapports sociaux
dans les prisons de femmes", Puf, Paris 1997; C. Faugeron, A. Chauvenet,
P. Combessie, a cura di, "Approches de la prison", cit.; M. Herzog-Evans,
"La gestion du comportement du détenu. Essai de droit pénitenhaire",
L'Harmattan, Paris 1998.
N. 6. Citata in A. Chauvenet, F. Orlic, G. Benguigui, "Le monde des surveillants
de prison", Puf, Paris 1994, p. 36 (sottolineatura di L. W.).
N. 7. D. Garland, "The Culture of Crime Control", The University of
Chicago Press, Chicago 2000.
N. 8. In proposito, si rimanda ai contributi su "Le journalisme et l'économie",
raccolti in «Actes de la recherche en sciences sociales», 131-132,
marzo 2000.