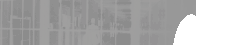PREFAZIONE.
Questo libro non ha bisogno di presentazione. L'insolita documentazione che esso raccoglie sulle condizioni delle carceri in Italia è già di per se stessa eloquente. Ha bisogno di essere letto. Di essere letto con discernimento – ogni testimonianza deve essere collocata nella particolare situazione da cui è nata –, ma senza pregiudizi. Bisogna avere il coraggio, per leggerlo, di andare incontro, non indifesi, ma neppure diffidenti per partito preso o per pigrizia mentale, alla verità sconvolgente che ne scaturisce: una verità tanto più sconvolgente quanto più è di solito, interessatamente, taciuta, nascosta, contraffatta, falsificata.
Si può non essere d'accordo sull'interpretazione dei fatti, degli episodi, delle situazioni descritte, compiuta da chi ha raccolto i documenti qui pubblicati, e con le conclusioni politiche che l'ispirano e ne vengono tratte. Ci si può sentire persino urtati da un linguaggio che per voler essere immediatamente efficace rischia continuamente di cadere nell'approssimazione o nella forzatura. O per un modo di argomentare che tende a giungere subito, senza trapassi intermedi, all'affermazione generale che non dovrebbe soffrire eccezioni, alla tesi perentoria che non ammette di essere rimessa in discussione, al giudizio senza appello. Si può non credere che la società di oggi sia più perversa di quella di ieri e di quella di domani, come credono (e hanno ragione di farlo) coloro che ne sono le vittime, e ribadiscono i loro interpreti. Non si può infine non riconoscere che per dare un giudizio su un problema rovente, e non da oggi, com'è quello delle carceri, non basta ascoltare soltanto coloro che stanno da una parte.
Eppure dopo aver letto questo libro non si può continuare a far finta di ignorare che cosa avviene nel mondo separato (ma quanto vicino!) delle prigioni di stato, quali sentimenti vi si agitano, quali inutili e disumane sofferenze vi si consumano, quali soprusi vi si commettono, quali abusi di un potere, che pur essendo per sua natura straordinario è pur sempre regolato da norme giuridiche, vi si compiono, quale universo di violenza continuata vi si è costruito, tale da non lasciare alla sottomissione inerte e sentita come vile altra alternativa, come in ogni società dispotica, che la rivolta (generalmente domata con un soprappiù di violenza). Soprattutto non si può continuare a ignorare – e in ciò sta l'aspetto nuovo e provocante delle testimonianze – la consapevolezza che gli assoggettati abituali a questo universo separato vanno acquistando della continuità tra la vita di fuori e la vita di dentro, tra l'emarginazione nella società e l'esclusione dalla società, tra la privazione dei beni materiali e la privazione della libertà, tra la miseria (non il delitto) e il castigo, tra il ghetto come predestinazione alla galera e la galera come ghetto deliberato, autorizzato, consacrato dalle pubbliche leggi.
Certo, un libro scandaloso. Il giudizio sul sistema carcerario dato non da studiosi illuminati, non da provvidi amministratori, non da magistrati competenti, non da benefattori umanitari. Qui sono i “delinquenti”, i “criminali”, i “bruti”, che parlano di se stessi e della loro vita di tutti i giorni: che invece di accettare rassegnatamente la condanna, accusano, invece di starsene sottomessi per “espiare” o “emendarsi”, si ribellano, invece di ubbidire agli ordini, li discutono, invece di fare il loro dovere, reclamano i loro diritti, come un qualsiasi cittadino non ignaro della costituzione – di una costituzione che ha avuto la temerarietà di proclamare che le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato” –, e delle leggi del suo paese, e quando possono, cioè quando riescono a raggiungere nel fuoco di una protesta un minimo di coesione, si rivoltano come si sono sempre rivoltati nella storia i popoli, le classi, le nazioni oppresse. Ma anche istruttivo e salutare, perché serve ad insinuare qualche dubbio in chi crede arrogantemente di sapere con esattezza, al riparo e con il conforto delle leggi stabilite, che non si discutono, quale sia il confine tra il giusto e l'ingiusto, tra il lecito e l'illecito, tra i buoni e i cattivi, tra i “regna” e i “magna latrocinia”.
Non pretendiamo che un libro come questo sia accettato così com'è con tutta la carica di violenza che esso contiene (ma è inutile ripetere che la violenza chiama la violenza, e chiunque abbia speso qualche ora nel riflettere sul problema della violenza sa che l'unico modo che la violenza ha di giustificarsi è di farsi accettare come una risposta, anzi come l'unica possibile risposta in una situazione data, alla violenza dell'altro). Chiediamo sia discusso. Sappiamo anche che l'opinione pubblica, o meglio il giudizio della gente, che continuiamo a chiamare falsamente “opinione pubblica”, è prevenuto. Ma sarebbe strano che non lo fosse, indotti come siamo ogni giorno a guardare con orrore soltanto a una faccia della medaglia. È bene che qualcuno cominci a guardare, se pure all'inizio con lo stesso orrore o con sgomento o con sospettosa incredulità, all'altra faccia.
La forza, la novità, il significato critico e polemico del libro consistono nello spingerci ad andare, anche contro voglia, anche riluttanti, alle radici del problema. Che è il problema della violenza legittima, o, come si suol dire, delle istituzioni. Che le istituzioni politiche siano fondate in ultima istanza sulla violenza è, almeno sino ad ora, un fatto che nessuno ha mai messo in dubbio. Ma la violenza per essere legittima deve essere prima di tutto necessaria, e come tale deve essere impiegata soltanto come “extrema ratio”. Ciò vuol dire che la violenza delle istituzioni per contrapporsi giustificatamente alla violenza individuale deve essere autorizzata, regolata, controllata, e continuamente rimessa in discussione. Altrimenti non differisce dalla violenza individuale. Anche chi è convinto della malvagità essenziale, irrecuperabile, del delinquente, non può credere che la risposta giusta alla malvagità individuale e occasionale sia la malvagità collettiva e istituzionalizzata, perché questa sarebbe la continuazione, anzi la sublimazione, dello stato di violenza, l'instaurazione del regno del terrore, che non è necessario essere utopisti sociali per condannare come la perversione dello stato, cioè del potere che pretende di porsi ad esclusione di tutti gli altri come l'unico potere legittimo.
Seguendo sino alle estreme conseguenze la logica di quella concezione per cui la soluzione ultima del problema dello stato non è il suo perfezionamento (il problema classico dell'ottimo stato) ma la sua estinzione, il libro sembra suggerire la tesi che l'unico modo di risolvere il problema del carcere sia non già di migliorarlo ma di eliminarlo, non sia già questa o quella escogitazione dell'ottimo carcere, o del carcere modello, cui si sono rivolti in ogni tempo i riformatori, ma la sua distruzione. Quello che oggi ci è dato sapere con una certa approssimazione alla verità è che nel corso della storia sono state inventate e praticate le pene più diverse, di cui la limitazione della libertà non è che un esempio, una più efferata dell'altra, una più inutile dell'altra, e che l'ottimo carcere, il carcere modello, non esiste, perché i due fini della reclusione, l'intimidazione e l'emenda, sono incompatibili. Un carcere tanto più adempie alla sua funzione deterrente quanto più è duro. Ma quanto più è duro, tanto meno è atto a correggere, a trasformare un delinquente in un buon cittadino. Anzi, come è a tutti noto, inasprisce, distrugge la personalità, fa di un delinquente occasionale un delinquente incallito. Se un carcere sempre meno rigido costituisce un freno troppo debole alle spinte eversive che nascono da ogni società (sinora esistita) fondata sulla diseguaglianza, un carcere troppo rigido diventa, come tutti sanno e ripetono, la più efficace scuola del delitto, riproduce, non elimina, moltiplica, non riduce, il delinquente. Come un ospedale in cui ci si facesse ricoverare non per guarire ma per ammalarsi maggiormente o per morire (cosa che pur accade; ma non per questo si può ritenere sia lo scopo per cui sono stati istituiti gli ospedali e che comunque li distingue istituzionalmente dai lazzaretti). Poiché il problema dell'ottimo carcere è un problema insolubile (insolubile perché contraddittorio), e nessuno oggi può credere seriamente che il problema della delinquenza possa essere risolto all'interno delle istituzioni penali, siamo costretti dalle cose stesse a porci ben altri problemi, se non vogliamo chiudere gli occhi di fronte a una realtà che è insieme drammatica e atroce: di chi va in carcere, per quali ragioni e in quali condizioni di esistenza, di come vi entra, di come vi esce, di chi sono i suoi educatori (o giustizieri). Sono appunto i problemi che questo libro sottopone con crudezza alla nostra attenzione.
Non da oggi il problema penale è un problema sociale nel senso più ampio e più preciso della parola; la delinquenza è lo specchio fedele di una società in quanto ne riproduce, anzi ne esalta, i valori essenziali (quelli veramente praticati, non quelli predicati a fior di labbra), al cui raggiungimento tende con altri mezzi (considerati illeciti). Nessuno può protestare, indipendentemente da quel che leggerà in questo libro, di non saperlo. A quello che già sappiamo, o dovremmo sapere, questo libro si limita ad aggiungere una serie di testimonianze immediate, dirette, efficacissime, da parte di coloro che forse non lo sapevano o che, pur sapendolo, non sono mai stati in condizione di dirlo.
NORBERTO BOBBIO