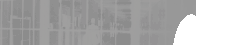I CRIMINI DEGLI DEI.
La volontà di cancellare le rappresentazioni della violenza governa l'evoluzione della mitologia. Per rendersene ben conto è necessario seguire questo processo al di là della tappa che ho appena definita. In questa prima tappa è in gioco soltanto la violenza "collettiva"; ogni volta che scompare, lo abbiamo visto, le viene sostituita una violenza "individuale". C'è poi una seconda tappa, in particolare nell'universo greco e romano, che consiste nel sopprimere persino la violenza individuale; ogni forma di violenza appare ormai insopportabile nella mitologia. Coloro che valicano questa tappa, lo sappiano o no - e nella maggior parte dei casi, sembra proprio che non lo sappiano - perseguono tutti un solo e identico scopo: l'eliminazione delle ultime tracce dell'assassinio collettivo, l'eliminazione di ogni traccia di queste tracce, se così possiamo esprimerci.
L'atteggiamento di Platone è particolarmente rilevante per la chiarificazione di questo punto. In un passo della "Repubblica" questa volontà di cancellare la violenza mitologica è molto esplicita; si esercita, in modo peculiare, sul personaggio di Crono in un passo che si riallaccia direttamente all'analisi che ho appena conclusa:
«'Quanto agli atti [...] di Crono e a quel che egli subì da parte del figlio, neanche se fosse la verità si dovrebbe, a parer mio, narrarli con una simile leggerezza a persone ingenue e sprovviste di giudizio, ma piuttosto tacerli del tutto; e se esistesse comunque un qualche obbligo di parlarne, bisognerebbe farlo usando le formule segrete dei Misteri, per un uditorio il più ristretto possibile, e dopo aver sacrificato non un porco ma qualche vittima immensa e difficilmente procurabile, di modo che al minor numero di persone accadesse di udire queste cose!'. 'Lo credo anch'io,' disse [Adimanto] 'simili racconti, questi almeno, sono molto scabrosi'» (1).
A scandalizzare Platone non è più l'assassinio collettivo, già scomparso, bensì la violenza individuale che costituisce il segno spostato di questa scomparsa.
Questa volontà di eliminazione, per il fatto stesso che è esplicita, assume le forme di una vera censura, di un'amputazione deliberata del testo mitologico. Essa non ha più la forza di una riorganizzazione strutturale né la coerenza straordinaria che possedeva nello stadio precedente. Proprio per questo fallisce nel modificare il testo mitologico. E proprio perché ne prevede il fallimento, Platone propone una sorta di compromesso accompagnato da precauzioni religiose di grande interesse. La raccomandazione di sacrificare una vittima molto grande e preziosa non è motivata semplicemente dalla preoccupazione di ridurre al minimo il numero degli iniziati ai misfatti di Crono e di Zeus. Nel contesto di una religione ancora sacrificale essa corrisponde a ciò che ci si può aspettare da uno spirito sinceramente religioso che si confronti con una violenza di cui teme la potenza contaminatrice; per controbilanciare questa violenza, è necessaria una violenza paragonabile, ma legittima e santa, vale a dire l'immolazione di una vittima che sia la più grande possibile. Nel testo di Platone, insomma, si chiude sotto i nostri occhi, in modo quasi esplicito, il cerchio della violenza e del sacro.
La censura richiesta da Platone non si è mai imposta nella forma da lui immaginata; ma si è comunque imposta e si impone tuttora sotto altre forme ancor più efficaci, ad esempio quella rappresentata dalla disciplina etnologica. La tappa platonica, contrariamente alla precedente, non giunge a una vera e propria rielaborazione del mito ma ha comunque un carattere fondatore: viene fondata un'altra cultura, non più propriamente mitologica ma 'razionale' e 'filosofica', è il testo stesso della filosofia.
La condanna della mitologia si ritrova in numerosi autori antichi, generalmente in forme banalizzanti derivate da Platone stesso, ma che illuminano in modo mirabile la vera natura dello scandalo. Varrone, ad esempio, distingue una «teologia dei poeti» che gli sembra particolarmente infelice perché propone all'ammirazione dei fedeli «dèi ladri, dèi adulteri, dèi schiavi al servizio di un uomo; per farla breve, si attribuiscono agli dèi tutti i disordini nei quali cade l'uomo, persino l'uomo più spregevole» (2).
Ciò che Varrone, dopo Platone, chiama teologia dei poeti, è il sacro veramente primitivo, ossia il sacro duplice che unisce il maledetto e il benedetto. Tutti i passi di Omero criticati da Platone documentano gli aspetti sia malefici sia benefici della divinità. La volontà differenziatrice di Platone non tollera questa ambiguità morale del divino. Oggi è esattamente lo stesso con Levi-Strauss e lo strutturalismo, con la sola differenza che la grandezza morale di Platone non c'è più e al suo posto si ritrova una preoccupazione puramente logica e linguistica, una filosofia del miscuglio impossibile in quanto non conforme alle «leggi del linguaggio e del pensiero»... La possibilità che gli uomini non pensino sempre esattamente allo stesso modo non viene presa neanche in considerazione.
Anche Dionigi di Alicarnasso si rammarica per quei miti che rappresentano gli dèi come «cattivi, malfattori, indecenti, in una condizione indegna non soltanto di esseri divini ma anche semplicemente di gente onesta...». In verità, tutti questi autori antichi hanno la sensazione che i loro dèi potrebbero non essere altro che vittime disprezzate e calpestate da tutti gli uomini. Ed è proprio quello che non vogliono. Scartano con orrore una simile possibilità perché, a differenza dei profeti ebrei e più tardi dei Vangeli, non riescono a concepire che una vittima trattata così possa essere innocente.
Platone tenta esplicitamente di censurare la mitologia, di farla deviare dai suoi temi tradizionali. Vediamo affiorare nel suo testo il tipo di motivi che poco fa ci è stato necessario postulare per spiegare la scomparsa dell'assassinio collettivo nel mito dei Cureti. Le prime trasformazioni risalgono a uno stadio anteriore a quello della filosofia e si effettuano su miti ancora intatti. L'unica testimonianza di cui disponiamo al riguardo sono i miti stessi, i miti già trasformati, perché essi diventano spettacolarmente intelligibili non appena scorgiamo il risultato della trasformazione. I decreti del filosofo non sono dunque la conseguenza di un capriccio individuale; essi illuminano retrospettivamente l'evoluzione di tutte le mitologie che evolvono. Platone ha visibilmente dei predecessori, vicini e lontani, nella ripulitura della mitologia, ma essi lavoravano ancora in modo mitologico; operavano all'interno del quadro mitologico e religioso tradizionale; trasformavano la narrazione mitologica.
Lo stereotipo della violenza subita dagli dèi e dagli eroi dapprima si attenua perdendo il suo carattere brutalmente e spettacolarmente collettivo, diventa violenza individuale, e infine scompare addirittura. Gli altri stereotipi della persecuzione hanno evoluzioni consimili e per le stesse ragioni. Quegli uomini che non tolleravano più l'assassinio collettivo del dio non si saranno scandalizzati meno di fronte a crimini che giustificavano questo assassinio. I testi citati mostrano che le due cose vanno di pari passo. Varrone si lamenta dei poeti che "attribuiscono agli dèi tutti i disordini nei quali cade l'uomo, persino l'uomo più spregevole". Beninteso, i poeti non sono responsabili di una tale attribuzione. La mitologia mondiale ne è la prova. Già allora, come ai giorni nostri, i 'poeti', ovvero gli interpreti del periodo precedente, forniscono capri espiatorii sostitutivi e i tradimenti che vengono loro rimproverati legittimano nuove censure.
Si desiderano ormai soltanto divinità che non siano più né criminali né vittime e, nell'impossibilità di capire che si tratta di capri espiatorii, si cancellano a poco a poco le violenze e i crimini commessi dagli dèi, i segni vittimari e persino la crisi stessa. A volte si inverte il senso della crisi e si dà all'indifferenziazione tra dèi e uomini il senso utopico al quale ho già fatto allusione prima.
Via via che una comunità si allontana dalle origini violente del suo culto, il senso del rituale si affievolisce e il dualismo morale si rafforza. Gli dèi e tutte le loro azioni, persino le più malefiche, sono serviti in un primo momento come modelli nei riti. Nelle grandi occasioni rituali, dunque, le religioni lasciano un discreto posto al disordine anche se lo subordinano sempre all'ordine. Tuttavia, giunge sempre il momento nel quale gli uomini cercano soltanto modelli di moralità ed esigono dèi ripuliti da ogni colpa. Non bisogna prendere alla leggera le critiche di un Platone o di un Euripide, che vuole anch'egli riformare gli dèi. Esse riflettono la decomposizione del sacro primitivo, ossia la tendenza dualista che, degli dèi, vuole trattenere soltanto l'aspetto benefico; si sviluppa così un'ideologia tesa o a far ricadere il sacro sui demoni e a differenziare sempre più i demoni dagli dèi, come fa la religione brahmanica, oppure a considerare l'aspetto malefico nullo e non avvenuto, a dichiararlo sovrapposto a una religione più originaria, l'unica veramente conforme all'ideale del riformatore. In realtà, il riformatore si costruisce un'origine sua personale trasponendo questo ideale in un passato del tutto immaginario. D'altronde, è proprio una siffatta trasposizione che trasfigura la crisi originaria in idillio e in utopia. L'indifferenziato conflittuale si inverte in una fusione beata.
La tendenza idealizzante, dunque, trasforma o cancella tutti gli stereotipi, la crisi, i segni vittimari, la violenza collettiva e anche, naturalmente, il crimine della vittima. Lo vediamo chiaramente nel mito di Baldr. Il dio che "non viene fatto uccidere collettivamente" non può essere un dio colpevole. E' un dio il cui crimine è completamente cancellato, un dio perfettamente sublime, esente da ogni colpa. Non è il caso a sopprimere i due stereotipi nello stesso tempo, è la stessa ispirazione nei fedeli. Il castigo e la sua causa sono legati e dovranno sparire insieme, perché spariscono per una sola e identica ragione.
Non ho dunque il diritto di sostenere che vi è stata effettivamente una cancellazione, una sparizione, piuttosto che una pura e semplice assenza. Sì, ho dimostrato di avere questo diritto nel caso dell'assassinio collettivo, ma questa dimostrazione tocca soltanto indirettamente il crimine che io suppongo attribuito, in origine, a ogni divinità. Solo implicitamente affermo che dovette esistere un primo Baldr 'criminale' in una versione più primitiva del mito. In se stesso, come abbiamo visto, il mito di Baldr contiene tutto quello che basta per affermare la formidabile pertinenza dell'assassinio collettivo assente, e dunque il nascondimento di questo assassinio nella versione che ci è pervenuta. Ma le cose non stanno affatto così per il crimine, egualmente assente. Per dimostrare che gli stereotipi della persecuzione sono tutti realmente universali, bisognerebbe dimostrare che essi restano tutti di un'estrema pertinenza anche e soprattutto per i miti "che non li contengono".
Cerchiamo dunque di farlo con lo stereotipo del crimine. L'esame dei miti suggerisce che una fortissima tendenza a minimizzare e poi a sopprimere i crimini degli dèi 'travaglia' le mitologie, in particolare quella greca, molto tempo prima che Platone e i filosofi le dessero un'espressione concettuale.
Anche un confronto superficiale mostra immediatamente che non si possono classificare i miti in due categorie ben distinte in riferimento alla colpa divina, gli dèi colpevoli da una parte, gli dèi non colpevoli dall'altra. Esiste una moltitudine di gradazioni intermedie, uno spettro continuo che va dai crimini più atroci all'innocenza perfetta passando attraverso colpe insignificanti, sbagli o semplici gaffe, che tuttavia possono avere, nella maggior parte dei casi, le stesse conseguenze disastrose dei crimini veramente seri.
Penso che questa gamma non si possa interpretare in modo statico; essa deve avere un carattere evolutivo. Per esserne persuasi, basta osservare l'impressionante insieme di temi che visibilmente hanno per comune denominatore una sola e identica volontà di minimizzare e scusare una colpa la cui definizione letterale resta ovunque la stessa, ma che produce su di noi un'impressione talmente diversa, ancora oggi, che l'identità fondamentale di tutti questi crimini non appare. Gli dèi olimpici della Grecia classica non sono più vittime, lo abbiamo già visto, eppure commettono ancora la maggior parte dei crimini stereotipati che giustificano l'uccisione del delinquente in altre mitologie. Tuttavia, queste azioni sono oggetto di un trattamento così lusinghiero, così pieno d'indulgenza e di raffinatezza che l'effetto prodotto, ancor oggi, appare completamente dissimile da ciò che si avverte a contatto con le stesse azioni nei miti definiti «etnologici».
Quando Zeus si tramuta in cigno per diventare l'amante di Leda, non pensiamo certo al crimine di bestialità, quando il Minotauro sposa Pasifae questo pensiero ci sfiora solo vagamente e accusiamo di "cattivo gusto" lo scrittore che lo suscita in noi, eppure su questo punto non c'è nessuna differenza col mito dogrib della donna-cane o anche con l'orribile favola medioevale della donna ebrea di Binzwangen che partorisce una figliata di maiali. Il nostro modo di reagire alle stesse favole non è sempre identico, esso varia secondo che si abbia la percezione, il presentimento delle loro conseguenze persecutorie o meno. Il trattamento estetico e poetico si riduce ai mille modi di aggiustare gli stereotipi della persecuzione, ossia ad abbellire e dissimulare tutto quello che potrebbe rivelare il meccanismo originario della produzione testuale, il meccanismo del capro espiatorio.
Come tutti i puritanesimi, neanche quello di Platone raggiunge lo scopo, che dovrebbe essere la rivelazione del meccanismo vittimario, la demistificazione delle rappresentazioni persecutorie, ma ha pur sempre maggior grandezza e profondità del lassismo morale dei poeti o dell'estetismo degli esegeti contemporanei che dissolve l'essenziale nel problematico. Platone protesta non solo contro l'attribuzione di tutti i crimini stereotipati agli dèi, ma anche contro il trattamento poetico di questi crimini che fa sì che essi sembrino ormai solo colpe insignificanti, semplici scappatelle, inezie prive di importanza.
La nozione aristotelica di "hamartia" concettualizza la minimizzazione poetica della colpa. Suggerisce la semplice negligenza, la colpa per omissione piuttosto che la pienezza malefica degli antichi miti. Traducendola con «tragica pecca», in inglese "tragic flaw", si evoca un piccolo difetto, un'unica crepa in una massa omogenea d'inattaccabile virtù. La dimensione nefasta del sacro è sempre presente, ma ridotta a quel minimo che è logicamente indispensabile alla giustificazione di conseguenze invariabilmente disastrose. Da qui ai miti in cui il malefico e il benefico si equilibrano, la distanza è grande. La maggior parte dei miti cosiddetti «primitivi» ci è giunta in questo primo stato di equilibrio e a ragione, credo, l'antica etnologia li qualificava appunto con il termine primitivi: ne aveva intuito la maggiore prossimità all'effetto di capro espiatorio che li fonda, cioè agli effetti prodotti dalla riuscita di una proiezione malefica estremamente violenta.
Perché la volontà di scusare il dio non sfoci immediatamente nell'eliminazione completa della sua colpa - una cosa che, all'altro capo della catena, esige chiaramente un Platone - è necessaria una forza che si eserciti a lungo nel senso di un rispetto estremo per il testo tradizionale, e ciò non può essere che l'effetto prolungato del capro espiatorio, la logica propria del religioso primitivo nella sua fase rituale e sacrificale. Il dio incarna il flagello come ho detto prima; egli sta non al di là del bene e del male ma al di qua. La differenza che egli incarna non si è ancora specificata in distinzioni morali; la trascendenza della vittima non si è ancora frammentata in una potenza buona e divina da un lato, cattiva e demoniaca dall'altro.
Soltanto a partire dallo stadio in cui questa divisione si attua, e bisogna pure che si attui sotto l'effetto delle pressioni che agiscono in tutti i sensi sull'insieme mitico originario, l'equilibrio si rompe nei miti ora in favore del malefico, ora in favore del benefico, ora nelle due direzioni insieme; l'equivoca divinità primitiva può allora scindersi in un eroe perfettamente buono e in un mostro perfettamente cattivo che devasta la comunità: Edipo e la sfinge, san Giorgio e il drago, il serpente d'acqua del mito arawak e il suo uccisore-liberatore. Il mostro eredita tutto ciò che nella vicenda è spregevole, la "crisi", i "crimini", i "criteri" di selezione vittimaria, i tre primi stereotipi persecutòri. L'eroe incarna soltanto il quarto stereotipo, l'uccisione, la decisione sacrificale, tanto più apertamente liberatoria quanto più la cattiveria del mostro ne giustifica appieno la violenza.
Questo genere di divisione è visibilmente tardo, giacché sfocia in racconti e leggende, ossia in forme mitiche talmente degenerate da non essere più oggetto di una credenza propriamente religiosa. Torniamo dunque indietro.
Non si tratta di sopprimere d'un sol colpo il crimine del dio. Effettuata senza precauzioni, questa censura risolverebbe un problema soltanto per crearne un altro. Sempre più perspicaci dei nostri etnologi, coloro che vivevano di queste mitologie capivano benissimo che la violenza inflitta al loro dio si giustificava con la colpa da lui commessa precedentemente. Cancellare questa giustificazione senz'altra forma di processo significa, certo, assolvere il personaggio più sacro, ma anche criminalizzare la comunità che lo punisce, così crede, a giusto titolo. Ora, questa comunità di linciatori è quasi altrettanto sacra della vittima fondatrice giacché genera la comunità dei fedeli. Il desiderio di moralizzare la mitologia sfocia in un dilemma. Noi possiamo dedurre senza difficoltà questo dilemma dai temi mitici primordiali, ma possiamo anche leggerne direttamente le conseguenze nei testi più palesemente evoluti, dalle sfumature a volte molto sottili della colpevolezza divina, fino adesso incomprensibili, ma che d'improvviso si chiariscono se viste come soluzioni più o meno ingegnose inventate dai fedeli nel corso delle epoche e dei miti per 'discolpare' simultaneamente tutti gli attori del dramma sacro.
La soluzione più semplice consiste nel conservare inalterati i crimini della vittima, pretendendo tuttavia che essi non sono stati da lei voluti. La vittima ha effettivamente fatto ciò di cui la si accusa, ma "non l'ha fatto apposta". Edipo ha effettivamente ucciso suo padre e fatto l'amore con sua madre, ma credeva di fare tutt'altra cosa. In definitiva, nessuno è colpevole, e tutte le esigenze morali sono soddisfatte nel rispetto "quasi" totale del testo tradizionale. Giunti a uno stadio un po' "critico" della loro evoluzione, cioè della loro interpretazione, i miti esibiscono frequentemente dei colpevoli innocenti come Edipo, giustapposti a comunità innocentemente colpevoli.
Si ritrova un po' la stessa cosa nel caso di Hödhr, il dio scandinavo, analizzato prima. Benché fisicamente responsabile dell'assassinio, l'uccisore dell'eccellente Baldr è persino più innocente di Edipo, se possibile, dato che, come abbiamo visto, egli ha molte ottime ragioni per vedere nel proprio atto omicida unicamente una mimica inoffensiva, una divertente parodia senza conseguenze spiacevoli per il bersaglio fraterno, anche se da lui effettivamente preso di mira. Hödhr non può assolutamente prevedere quello che accadrà.
Agli dèi primitivi la cui colpevolezza è totale, succedono dunque altri dèi la cui colpevolezza è limitata o persino inesistente. Ma questa assoluzione non è mai veramente universale. L'eliminazione della colpa in un luogo qualsiasi si salda di solito al suo rinascere altrove, generalmente ai margini, in forma esacerbata. Vediamo allora apparire un dio o piuttosto una specie di demone la cui colpevolezza viene rafforzata, un Loki o un Crono che, in definitiva, ha il ruolo di un capro espiatorio di secondo grado, rigorosamente conforme al testo, in apparenza, ma che in realtà fa sempre riferimento, se risaliamo all'origine, a qualche vittima reale.
Esistono anche altri metodi per ridurre la colpevolezza divina senza addossarla sulla comunità violenta e soprattutto senza rivelare il non-rivelabile per eccellenza, il meccanismo del capro espiatorio. Si trovano vittime colpevoli di azioni che non sono intrinsecamente cattive, ma che, a causa di circostanze particolari di cui queste vittime sono all'oscuro, portano a conseguenze tali da giustificare la violenza collettiva. Si tratta, in verità, soltanto di una variante del crimine privo di intenzione criminale.
La forma suprema di questa duplice giustificazione consiste nel leggere i rapporti tra la vittima e la comunità dei linciatori nei termini di un puro e semplice malinteso, di un messaggio mal interpretato.
Si dà anche il caso che i crimini degli dèi siano considerati reali, ma che i miti attribuiscano loro una causa supplementare, una forza naturale forse, ma irresistibile, che costringe il dio a comportarsi male senza che la sua volontà vi abbia minimamente parte: un liquore inebriante che gli hanno fatto bere o magari la puntura di un insetto velenoso.
Riassumo ciò che dice Eliade, nella sua "Histoire des croyances et des idées religieuses", di un dio ittita punto da un'ape:
«Poiché l'inizio del racconto è andato perduto, non sappiamo per quale motivo Telipinu decida di 'scomparire'. [...] Ma le conseguenze della sua scomparsa si fanno sentire immediatamente. Il fuoco si spegne nei focolari, gli dèi e gli uomini si sentono 'prostrati'; la pecora abbandona l'agnello e la mucca il suo vitello; 'l'orzo e il grano non maturano più', gli animali e gli uomini non si accoppiano; i pascoli inaridiscono e le sorgenti si prosciugano [...]. Infine la dea madre manda l'ape; questa trova il dio addormentato in un boschetto e lo sveglia con il suo pungiglione. Furente, Telipinu provoca calamità tali nel paese che gli dèi si impauriscono e per calmarlo ricorrono alla magia. Grazie a certe cerimonie e formule magiche, Telipinu è purgato dalla rabbia e dal 'male'. Pacificato, egli ritorna infine tra gli dèi - e la vita riprende i suoi ritmi» (3).
Sono molto evidenti due stereotipi persecutòri: la crisi e la colpa del dio che la suscita. La responsabilità divina è al contempo aggravata e attenuata dalla puntura dell'ape. Non è la violenza collettiva che capovolge direttamente il malefico in benefico, bensì il suo equivalente rituale. Pur tuttavia, l'azione magica rivela questa violenza; essa mira sempre a riprodurre l'effetto originario di capro espiatorio, e ha d'altronde un carattere collettivo. Sono "tutti gli altri dèi" a impaurirsi e ad intervenire "contro" Telipinu per metter fine alla sua attività distruttrice. Ma la violenza di questo intervento è velata; gli dèi non sono più nemici di Telipinu di quanto Telipinu sia veramente nemico degli uomini. Vi è disordine nella comunità e la causa è divina, ma nessuno ha un'intenzione sinceramente cattiva, né Telipinu nel suo rapporto con gli uomini né gli altri dèi nel loro rapporto con Telipinu.
Tra le varianti della colpa minimizzata, bisogna includere le attività del "trickster" nord-americano e di tutti gli dèi «bricconi» un po' ovunque. Questi dèi sono capri espiatorii come gli altri. I loro benefici si riducono tutti a un patto sociale rinsaldato a spese della vittima. Sono invariabilmente preceduti da misfatti sentiti come indubitabili e giustamente puniti. Si ha qui, come dappertutto altrove, il paradosso del dio proficuo perché nocivo, portatore di ordine perché fautore di disordine. All'interno di una rappresentazione mitico-persecutoria ancora intatta, il problema delle intenzioni divine non può, alla lunga, non emergere. Perché il dio mette in cattive acque coloro che in ultima analisi vuole aiutare e proteggere, perché si mette egli stesso, per questo stesso fatto, in cattive acque? Accanto agli dèi che fanno il male perché non sanno che si tratta del male e agli dèi che lo fanno perché vi sono irresistibilmente spinti, sarà inevitabile inventare una terza soluzione: il dio che fa il male per divertirsi, il dio cattivo burlone. Finisce sempre con l'aiutare, ma adora gli scherzi di cattivo gusto e ne fa sempre. E' proprio in questo che egli si fa conoscere. Spinge la burla sino al punto di non poterne più controllare le conseguenze. E' l'apprendista stregone che appicca il fuoco al mondo accendendo una fiamma minuscola, e che spandendo urina inonda tutta la terra. Giustifica dunque tutti gli "interventi correttivi" e, come sempre, è proprio in virtù di questi che egli si trasforma in benefattore.
Il "trickster" appare a volte talmente furbo, a volte talmente stupido e goffo nel compiere la sua missione, da provocare degli incidenti, involontari o volontari, che compromettono il risultato desiderato e nello stesso tempo lo assicurano, poiché ricostituiscono contro il maldestro l'unanimità necessaria al buon funzionamento della comunità.
Si deve dunque riconoscere nel "trickster" la fissazione in sistema di una delle grandi teologie che scaturiscono dal capro espiatorio sacralizzato, la teologia del "capriccio divino". L'altra teologia è quella della "collera divina", altra soluzione al problema posto ai prigionieri della rappresentazione persecutoria dall'efficacia riconciliatrice di colui che appare ai loro occhi come il colpevole reale. Se non sembrasse tale, se i beneficiari del meccanismo potessero mettere in dubbio la causalità del capro espiatorio, non vi sarebbe né riconciliazione né divinità.
In questa prospettiva il dio è, come sempre, fondamentalmente buono, ma si trasforma temporaneamente in un dio cattivo. E' per meglio riportare i suoi fedeli sulla giusta strada che egli li opprime, per correggere in essi quelle mancanze che gli vietano di mostrarsi immediatamente benefico. Chi ben ama, ben punisce. Questa soluzione, pur essendo meno allegra della precedente, è più profonda poiché introduce l'idea rarissima tra gli uomini che il loro capro espiatorio non sia l'unica incarnazione della violenza. La comunità spartisce fra se stessa e il proprio dio la responsabilità di questo male; comincia a diventare colpevole dei propri disordini. La teologia della collera si avvicina alla verità, ma si situa ancora all'interno della rappresentazione persecutoria. Non si può sfuggire a quest'ultima senza analizzare il meccanismo del capro espiatorio, senza sciogliere il nodo che racchiude la rappresentazione mitologica su se stessa.
Per concludere riguardo alla colpa del dio e per mostrare che non bisogna fissare in categorie rigide le soluzioni brevemente descritte, voglio parlare di un mito che ritroviamo in punti della terra lontanissimi tra loro e che riesce, molto ingegnosamente, a combinare gli aspetti vantaggiosi tra i quali le soluzioni precedenti dovevano invece scegliere.
Dopo aver ucciso il drago, Cadmo, l'antenato di tutta la mitologia tebana, semina i denti del mostro e immediatamente dal terreno scaturiscono guerrieri armati di tutto punto. Questa nuova minaccia, figlia della precedente, illustra chiaramente il rapporto tra la crisi persecutoria all'interno delle comunità umane, da una parte, e i draghi e le bestie fantastiche dall'altra. Per sbarazzarsi dei guerrieri, Cadmo ricorre a un'astuzia semplicissima. Di nascosto, raccoglie un sasso e lo getta in mezzo alla truppa. Nessuno dei guerrieri è colpito, ma il rumore prodotto dal sasso cadendo fa sì che ognuno creda di essere stato provocato dall'altro; un istante dopo si scatenerà la zuffa e quasi tutti si uccideranno a vicenda.
Cadmo appare qui come una sorta di "trickster". In un certo senso, è lui la causa della crisi sociale, del gran disordine che devasta un gruppo umano fino alla sua totale distruzione. Il caso in sé non è gravissimo, il sasso non ha fatto male a nessuno; lo scherzo diventa veramente cattivo soltanto in virtù della stupida brutalità dei guerrieri, della loro cieca propensione a intensificare il conflitto. Una cattiva reciprocità alimenta ed esaspera tanto più rapidamente questo conflitto in quanto i partecipanti non la individuano.
Quel che stupisce in questo mito è il fatto che rivelando in modo spettacolare la reciprocità sempre meno differita, dunque sempre più accelerata che si impadronisce delle società in crisi - ne ho parlato prima - esso svela implicitamente sia la ragione d'essere del capro espiatorio, sia la ragione della sua efficacia. Una volta scatenata, la cattiva reciprocità non può che peggiorare, per il fatto stesso che tutti i motivi di risentimento, non ancora reali in un dato momento, lo diventano un istante dopo. Vi è sempre all'incirca una metà dei combattenti che giudica ristabilita la giustizia perché si sente vendicata, mentre l'altra metà si sforza di ristabilire questa stessa giustizia assestando alla metà provvisoriamente soddisfatta il colpo che la vendicherà definitivamente.
Il meccanismo è tale che per fermarlo bisognerebbe che tutti si accordassero per riconoscere la cattiva reciprocità. Ma chiedere loro di comprendere che i rapporti in seno al gruppo bastano non soltanto a nutrire ma a partorire la loro sventura, è chiedere troppo. Una comunità può passare dalla buona alla cattiva reciprocità per ragioni insignificanti o al contrario così costrittive e massicce che i risultati si equivalgono. Tutti sono sempre responsabili, pressappoco alla stessa maniera, ma nessuno vuole riconoscerlo. Se anche prendessero coscienza della loro cattiva reciprocità, vorrebbero comunque che essa avesse un autore, una origine reale e punibile; forse accetterebbero di sminuirne l'importanza ma vorrebbero sempre una causa primaria suscettibile di un "intervento correttivo", per usare il linguaggio di Evans-Pritchard, una causa "significativa sul piano dei rapporti sociali".
Si comprende facilmente come e perché il meccanismo del capro espiatorio sopraggiunga talvolta a interrompere questo processo. L'istinto cieco delle rappresaglie, la reciprocità imbecille che precipita ciascuno sull'avversario più vicino o più visibile, non si basa su niente di veramente determinato; tutti possono dunque convergere, pressoché in un qualsiasi momento ma di preferenza nel momento più isterico, su chicchessia. Basta un accenno di convergenza del tutto accidentale, o motivato da un qualche segno vittimario. Basta che un potenziale bersaglio sembri un po' più attraente degli altri, perché tutti si spostino di colpo nella certezza senza contraddizione possibile, nella beata unanimità riconciliatrice...
Poiché per la violenza non c'è mai altra causa se non la credenza universale in una causa altra, basta che questa universalità si incarni in un altro reale, il capro espiatorio, diventato così l'altro di tutti, perché "l'intervento correttivo" cessi di "apparire" efficace e lo diventi realmente, nella pura e semplice estinzione di ogni volontà di rappresaglia in tutti i sopravvissuti. Soltanto il capro espiatorio potrebbe volersi vendicare ma, secondo ogni evidenza, non è in grado di farlo.
In altri termini, perché la distruzione reciproca si interrompa, nel mito di Cadmo, basterebbe che i guerrieri scoprissero la funzione di agente provocatore dello stesso Cadmo, e si riconciliassero a sua insaputa. Poco importa che l'agente sia o non sia reale, basta che tutti siano convinti della sua realtà e della sua identità. Come essere sicuri che si è individuato il vero colpevole se non è successo altro che la caduta di un piccolo sasso, il rumore di un semplice sasso che rotola su altri sassi? Un incidente simile può prodursi in qualsiasi momento senza che vi sia intenzione perversa da parte del suo autore, senza che vi sia un vero autore. Qui conta solo la "fede" più o meno intensa e più o meno universale, che ispira l'eventuale capro espiatorio, nella sua volontà e nella sua capacità di seminare il disordine, dunque di ristabilire l'ordine. Non riuscendo a scoprire ciò che è realmente successo o, se si preferisce, un capro espiatorio abbastanza convincente, i guerrieri non smettono di battersi e la crisi continua fino all'annientamento finale.
I sopravvissuti rappresentano la comunità scaturita dal mito di Cadmo; i morti rappresentano disordine, in opposizione a Cadmo stesso. Per il mito, Cadmo è simultaneamente potenza di disordine - è lui che semina i denti del drago - e potenza d'ordine - è lui che libera l'umanità distruggendo prima il drago, poi la moltitudine dei guerrieri, "draco redivivus", il nuovo mostro dalle mille teste sorto dai resti del mostro precedente. Cadmo è dunque uno di quegli dèi che provocano sempre il disordine, ma "soltanto" per porvi fine. Cadmo non è dunque un capro espiatorio esplicito nel suo mito e grazie a quel mito; è un capro espiatorio implicito, capro espiatorio sacralizzato dal mito stesso, il dio dei Tebani, e questo mito, alla fin fine, è soltanto astuto; non rivela fino in fondo, e non può rivelarlo, il segreto della propria elaborazione, poggia ancora su un meccanismo di capro espiatorio.
I miti del tipo «piccola causa, grandi effetti», o se si preferisce «piccolo capro espiatorio, grande crisi», si ritrovano nelle cinque parti del mondo e in forme a volte troppo singolari nei dettagli perché ci si possa sbarazzare di essi col pretesto che sono frutto di influenze reciproche ed effetto del diffusionismo. La versione indiana del mito di Cadmo può anche rientrare tra le 'influenze' indoeuropee, ma la faccenda si fa più delicata per la versione sudamericana che appare da qualche parte in "Mythologiques" di Lévi-Strauss. Invisibile in un albero, un pappagallo antropomorfo semina la discordia sotto di sé lasciando cadere dal becco certi proiettili. E' difficile sostenere che tutti questi miti hanno soltanto un significato esclusivamente logico e differenziatore, e che non hanno niente a che vedere con la violenza tra gli uomini.
Non tutti i testi che riprendono miti più antichi cancellano l'assassinio collettivo. Vi sono alcune eccezioni importanti, tra i commentatori religiosi, i grandi scrittori - i tragici in particolare - e anche tra gli storici. Nel leggere il mio commento, bisogna tenere ben presenti le analisi che ho appena fatte. Esse gettano una luce nuova, penso, sia sulle «dicerie» a proposito di Romolo, sia su molte «dicerie» analoghe concernenti un certo numero di fondatori di città e di fondatori di religioni. Freud è l'unico autore importante, fra i moderni, che abbia preso sul serio queste dicerie. Nel suo scritto "L'uomo Mosè e la religione monoteistica", egli ha utilizzato per fini sfortunatamente troppo polemici certe «dicerie» marginali della tradizione ebraica, secondo le quali Mosè sarebbe stato anche lui vittima di un assassinio collettivo. Ma per una strana carenza nell'autore di "Totem e tabù", che forse si spiega con la sua critica troppo parziale della religione ebraica, egli non trae mai le dovute conseguenze dalla notevole convergenza tra queste «dicerie» a proposito di Mosè e quelle relative a molti altri legislatori e fondatori di religioni. Alcune fonti suggeriscono, ad esempio, che Zarathustra morì assassinato dai membri, travestiti da lupi, di una di quelle associazioni rituali di cui egli aveva combattuto la violenza sacrificale, una violenza che ha anche qui il carattere collettivo e unanime dell'assassinio fondatore che essa ripete. In margine alle biografie ufficiali, esiste spesso una tradizione più o meno 'esoterica' dell'assassinio collettivo.
Gli storici moderni non prendono sul serio simili storie. Non possiamo certo rimproverarli per questo: essi non dispongono dei mezzi che permetterebbero loro di incorporarle nelle loro analisi. In realtà una scelta l'hanno: o interpretarle in riferimento a un solo autore, il «loro», come dicono, e in questo caso possono vedervi soltanto ciò che, ironicamente o prudentemente, vi vedono le loro stesse fonti, ossia storie non verificabili, «chiacchiere da donnette», oppure, al contrario, interpretarle nell'ambito della mitologia o, se vogliamo, della storia universale. In quest'ultima ipotesi dovrebbero sentirsi costretti a riconoscere che il tema, benché non sia affatto universale, ritorna troppo spesso perché non gli si debba una spiegazione. Non ci si può limitare a dirlo mitologico e basta, giacché sono pur sempre miti quelli che, categoricamente, contraddice. Eccoli dunque con le spalle al muro, i nostri uomini: forse che a questo punto si decidono ad affrontare questo loro problema o, almeno, a riconoscere che un problema esiste? Non contateci; quando si tratta di fuggire di fronte al vero, le risorse sono inesauribili. Il rifiuto del senso ricorre qui alla sua arma suprema, al suo vero raggio della morte. Esso definisce meramente retorico il tema che disturba. Decide che ogni insistenza su questo assassinio collettivo assente, ogni ritorno sospettoso su questa sua assenza, lascia il tempo che trova. Sarebbe da ingenui lasciarsene incantare. Di tutte le possibili tavole di salvezza non ne esiste una più inaffondabile: dopo una lunga assenza ecco che torna a galla nella nostra epoca, e le tempeste della nostra apocalisse si accaniscono invano contro di essa; ancora più ingombra della zattera della "Medusa", non c'è verso di farla affondare.
Nessuno, insomma, dà all'assassinio collettivo la minima importanza. Torniamo dunque a Tito Livio, più interessante della cultura universitaria che lo tiene in ostaggio. Lo storico romano ci racconta che, durante una forte tempesta, Romolo «fu avvolto da una nube così densa che lo sottrasse agli sguardi dell'assemblea. Da allora, non riapparve mai più sulla terra». Dopo un attimo di sbigottimento «la gioventù romana acclama in Romolo un nuovo dio». Ma:
«Vi furono, credo, già allora alcuni scettici che sostennero a bassa voce che il re era stato fatto a pezzi dai Padri con le loro stesse mani: anche questa voce infatti si divulgò, in gran mistero, ma il prestigio dell'eroe e i pericoli del momento resero popolare l'altra versione» (4).
Anche Plutarco riporta numerose versioni della morte di Romolo. Tre di esse sono varianti di un assassinio collettivo. Secondo alcuni, Romolo morì soffocato nel suo letto dai suoi nemici, secondo altri, invece, fu fatto a pezzi dai senatori nel tempio di Vulcano. Secondo altri ancora, la vicenda si svolse nella palude Caprea, durante la forte tempesta di cui parla Tito Livio. La tempesta fece «scappare il popolino» mentre "i senatori serrarono le fila". Come in Tito Livio, sono i senatori, ossia gli assassini, che instaurarono il culto del nuovo dio "perché essi avevano serrato le fila contro di lui":
«Il grosso della plebaglia prese per buona la spiegazione, furono contenti di udirla e se ne andarono adorando Romolo di tutto cuore e pieni di speranza; ma ci furono alcuni che, cercando la verità dell'accaduto con asprezza e acredine, misero in gran scompiglio i patrizi, accusandoli di voler ingannare quella rozza moltitudine con vane e folli persuasioni, mentre invece erano stati proprio loro stessi a uccidere il re con le proprie mani» (5).
La leggenda, se tale è, è una controleggenda. Nasce da una volontà esplicita di demistificazione analoga, in ultima analisi, a quella di Freud. E' la versione ufficiale che passa per leggendaria, e il potere ha interesse a diffonderla per consolidare la sua autorità. La morte di Romolo assomiglia a quella di Penteo nelle "Baccanti":
«Eppure alcuni supposero che i senatori si fossero avventati tutti insieme su di lui [...] e, dopo averlo fatto a pezzi, ognuno ne avesse portato via un pezzo nelle pieghe della propria veste».
Questa fine ricorda il "diasparagmos" dionisiaco; la vittima muore fatta a pezzi dalla moltitudine. Gli echi mitologici e religiosi sono dunque indiscutibili, ma il "diasparagmos" si riproduce spontaneamente nelle folle in preda a frenesia assassina. La storia dei grandi tumulti popolari in Francia durante le guerre di religione pullula di esempi analoghi al testo di Plutarco. I rivoltosi si contendono persino i più piccoli brandelli della loro vittima; vedono in essi preziose reliquie che potranno in seguito essere oggetto di un vero commercio e raggiungere prezzi esorbitanti. Innumerevoli esempi indicano l'esistenza di un rapporto stretto tra la violenza collettiva e un certo processo di sacralizzazione che non esige, per formarsi, una vittima già potente e rinomata. La metamorfosi dei brandelli in reliquie è attestata anche in alcune forme di linciaggio razzista nel mondo contemporaneo.
Insomma, sono gli assassini stessi che sacralizzano la loro vittima. Ed è proprio quello che attestano le «dicerie» a proposito di Romolo. E lo dicono in modo particolarmente moderno, perché vedono in questa vicenda una specie di complotto politico, una storia inventata da cima a fondo da gente che non ha mai perso la testa e che ha sempre saputo ciò che voleva. Il testo riflette la prospettiva plebea. La lotta contro l'aristocrazia riduce la divinizzazione di Romolo a una specie di complotto contro il popolo, a uno strumento della propaganda senatoria. L'idea che la sacralizzazione trasfiguri un avvenimento in realtà sordido è molto importante, ma la tesi di un camuffamento deliberato, per quanto seducente possa essere per lo spirito contemporaneo di cui annuncia alcune tendenze, non può soddisfare del tutto quegli osservatori che intuiscono il ruolo essenziale dei fenomeni di folla e di ipermimetismo collettivo nella genesi del sacro.
Facendo del processo mitologico un'invenzione che non perde mai la propria consapevolezza, in nessuna delle sue tappe, le "dicerie" che Tito Livio e Plutarco documentano ci farebbero ricadere, se le prendessimo alla lettera, negli errori del razionalismo moderno in materia religiosa. Il loro interesse maggiore sta nel rapporto che esse indicano tra la genesi mitologica e la folla scatenata. Non altrimenti fa l'erudito Ottocento, quando di queste "dicerie" accoglie soltanto la parte non autentica: il religioso si riduce così a un complotto dei potenti contro i deboli.
Bisogna soffermarsi su tutte le tracce di violenza collettiva senza eccezione e criticarle l'una mediante l'altra. Nella prospettiva aperta dalle analisi precedenti, le "dicerie" acquistano una dimensione che sfugge al positivismo tradizionale, ossia all'alternativa grossolana tra 'vero' e 'falso', tra storico e mitologico. Nel quadro di questa alternativa, le nostre "dicerie" non possono inserirsi da nessuna parte; nessuno è abbastanza competente per poterne trattare. Gli storici non possono tenerne conto: le "dicerie" sono ancora più sospette di tutto ciò che essi stessi possono raccontare sulle origini di Roma. Lo stesso Tito Livio lo riconosce. Neanche i mitologi possono interessarsi a ciò che si presenta esplicitamente come antimitologico piuttosto che mitologico. Le dicerie cadono negli interstizi del sapere organizzato. E' quello che succede sempre alle tracce della violenza collettiva. Via via che la cultura si evolve, le tracce si lasciano spazzare e cancellare sempre di più; sotto questo aspetto, la filologia e la critica moderna completano l'opera delle mitologie tarde. E' ciò che viene chiamato «sapere».
L'occultamento dell'assassinio collettivo continua a operare anche in mezzo a noi con la stessa forza insidiosa e irresistibile che in passato. Per mostrarlo, dovrò ricorrere una seconda volta all'insieme mitologico di Romolo e Remo. Esso ci permetterà di vedere questo processo in azione, oso dire, persino oggi e in mezzo a noi. Ci aiuterà inoltre a comprendere che l'occultamento delle tracce continua per nostro tramite e, inevitabilmente, a nostra insaputa, nell'uso che noi stessi facciamo del testo di Tito Livio.
La maggior parte dei miei lettori sono convinti, suppongo, che le versioni eretiche della morte di Romolo costituiscano "l'unica" rappresentazione dell'assassinio collettivo nell'insieme mitologico in questione. Nessuno ignora, certo, che il mito contiene un'altra morte violenta, da sempre presentata come un assassinio, ma come un assassinio "individuale": la morte di Remo.
Romolo è l'unico assassino. Interrogate tutte le persone colte che conoscete e tutte senza eccezione vi diranno che è proprio così. Romolo uccide suo fratello in un impeto di collera perché questi ha varcato con un salto, per farsene beffa, il limite simbolico della città di Roma che lui, Romolo, aveva appena tracciato.
Questa versione dell'assassinio figura effettivamente in Tito Livio, ma non è né l'unica né la prima. La prima è una versione collettiva. E, a differenza della seconda, è un esempio classico di mito che non ha ancora eliminato la sua rappresentazione dell'assassinio collettivo. La prima versione s'innesta sulla controversia per l'interpretazione dei presagi. Il volo degli uccelli non riesce a dare la supremazia a uno dei gemelli nemici, Romolo e Remo. La storia è risaputa; non è occultata da nessuno perché si combina senza difficoltà con la seconda versione del mito, quella che fornisce al mito la sua conclusione, e che noi tutti scegliamo senza accorgercene "perché è la versione che elimina l'assassinio collettivo". Dopo aver raccontato come i due fratelli concepirono il progetto di costruire una città nuova sul luogo stesso nel quale «erano stati abbandonati e allevati», Tito Livio aggiunge:
«A questi progetti si mescolò ben presto la passione ereditaria, l'avidità di regnare, e tale passione fece nascere un conflitto criminale da un'impresa inizialmente assai mite. Siccome tra questi due gemelli la scelta non era possibile, neppure in ragione dell'età, toccava agli dèi protettori di quel luogo designare mediante presagi colui che avrebbe dovuto dare il suo nome alla futura città, fondarla e governarla...
«Fu per primo Remo, si dice, a ottenere un presagio: sei avvoltoi. Lo aveva appena segnalato quando a Romolo ne apparvero il doppio. Ciascuno dei due fu proclamato re dai propri partigiani. Gli uni pretendevano la sovranità facendo valere la priorità, gli altri il numero degli uccelli. Vennero a parole; passarono a vie di fatto; gli animi adirati si esasperarono e degenerarono in una lotta omicida. Fu allora che "nella rissa" Remo cadde colpito a morte» (6).
Tra i due gemelli tutto è sempre uguale; vi è conflitto perché vi è concorso, concorrenza, rivalità. Il conflitto non sta nella differenza bensì nell'assenza di questa. Ecco perché lo strutturalismo delle opposizioni binarie differenziate non è in grado di capire il problema dei gemelli nemici più di quanto lo sia la psicoanalisi «strutturata come un linguaggio». Tito Livio capisce esattamente la stessa cosa che capiscono i tragici greci quando ci parlano dei loro gemelli, Eteocle e Polinice, cioè che il tema dei gemelli è tutt'uno con il tema del conflitto indecisibile perché indifferenziato; significa assenza di separazione in quanto separazione assoluta: "siccome tra questi due gemelli la scelta non era possibile, neppure in ragione dell'età", ci si affida agli dèi, ma gli dèi stessi danno solo una parvenza di decisione, una "decisione" essa stessa "indecisibile", che non fa altro che alimentare il litigio e farlo divampare sempre più. Ciascuno dei due fratelli desidera ciò che desidera l'altro, anche se si tratta di una cosa che non esiste ancora, la città di Roma. La rivalità è puramente mimetica e fa tutt'uno con la crisi sacrificale che uniforma tutti coloro che sono partecipi dello stesso desiderio conflittuale, mutandoli tutti, e non soltanto i due fratelli, in gemelli della loro stessa violenza.
La traduzione che ho citato, quella della collezione Budé, non è che sia scorretta, ma ha un non so che di fuorviante, di inadeguato. Essa "rende invisibile l'essenziale". Il carattere collettivo dell'assassinio di Remo, nettissimo nel latino di Tito Livio, diventa quasi impercettibile nel testo francese. Le parole latine "in turba", ossia "nella folla", sono tradotte in francese «"dans la bagarre"», «nella rissa».
E' stato Michel Serres a farmi notare l'originale latino: "ibi in turba ictus Remus cecidit", e anche il notevole processo di attenuazione e di minimizzazione che la traduzione citata adotta. Mi si dirà che la parola "bagarre" in questo contesto indica di per sé una pluralità di contendenti. E' vero. Ma la parola "turba" ha un valore quasi tecnico: è quella usata quando si vuole mettere in rilievo l'elemento "perturbatore" e "perturbato" di una folla; è la parola che torna più spesso nei numerosi racconti di assassinii collettivi nel primo libro di Tito Livio. La sua importanza è tale che il suo equivalente letterale è indispensabile in ogni traduzione, e la sua assenza costituisce inevitabilmente qualcosa di analogo, meno spettacolare ma altrettanto efficace, alla scomparsa dell'assassinio collettivo in testi come il mito di Baldr o il mito dei Cureti. Vale a dire che in tutte le tappe della cultura, noi ricadiamo sempre nello stesso tipo di fenomeno: l'occultamento dell'assassinio fondatore. E' un processo che continua ad agire anche oggi, per il tramite delle ideologie più diverse - l'umanesimo classico, per esempio, o la lotta contro l'«etnocentrismo occidentale» .
Si dirà che io farnetico. Ma non è vero, e la prova sta nella concezione alla quale alludevo prima, l'illusione quasi universale che non vi sia rappresentazione dell'assassinio collettivo in un mito come quello di Romolo e Remo. In realtà questa rappresentazione c'è, ed è anzi assolutamente centrale, ma essa scompare a poco a poco grazie a un processo di soffocamento o di strangolamento, vero equivalente intellettuale di ciò che i patrizi fanno subire allo stesso Romolo in uno degli assassinii di Plutarco. Ci sono diversi altri assassinii che, come mostra Michel Serres, galleggiano al largo, respinti sempre più lontano fino al momento, in verità ormai quasi arrivato, in cui la loro espulsione sarà completa. Alla prima allusione, i «veri esperti» aggrottano le sopracciglia, alla seconda venite automaticamente esclusi dalla comunità dei cosiddetti ricercatori «seri», di coloro, cioè, che ormai sostengono che il fenomeno religioso probabilmente non esiste. Venite trattato come una specie di avventuriero intellettuale, avido di sensazioni oscure e di pubblicità. Nella migliore delle ipotesi sarete considerato uno che sfrutta in modo vergognoso l'assassinio collettivo, questo mostro di Lochness degli studi mitologici.
Voglio precisare ancora una volta che, ai miei occhi, l'interesse di Tito Livio non sta nel fatto che le varianti collettive e sovversive della morte di Romolo e soprattutto la versione occultata dell'assassinio di Remo, versione sempre dimenticata e più o meno falsificata, permettono di inserire un altro mito nella schiera dei miti provvisti di una rappresentazione dell'assassinio collettivo. Anche se si potesse dimostrare che tutti i miti sono in origine provvisti di questa rappresentazione, la dimostrazione avrebbe soltanto un interesse secondario. Molto più interessante è il processo di cancellazione, perché è troppo costante per essere fortuito. E' la mitologia stessa, insomma, a testimoniare in modo indiretto, ma imponente, contro l'ostinazione di cui diamo prova nel misconoscere il suo punto nevralgico.
Tito Livio fa emergere in modo rigoroso quel che potremmo chiamare il dramma mitologico elementare: il (non)-significato dei gemelli, la loro rivalità mimetica, la crisi sacrificale che ne risulta, l'assassinio - collettivo - che la risolve. D'altronde, ritroviamo tutto questo nei grandi autori antichi e in tutti i loro grandi imitatori classici. Riconoscere quest'unità, quella di Tito Livio e di Corneille, per esempio, o quella di Euripide e di Racine, significa riconoscere un'evidenza che due o tre secoli di miopia da Ecole des Chartes hanno censurato, e non mettere i grandi testi in un nuovo 'tritatutto critico', secondo lo stile contemporaneo.
E' questo che bisogna ammirare, bisogna imitare, in Tito Livio, come pure il modo in cui egli ci presenta le due versioni dell'assassinio di Remo, quella collettiva e quella individuale, nell'ordine necessario della loro evoluzione diacronica. Diversamente dalle nostre scuole attuali, ancora contratte nella sola sincronia, lo storico romano vede che esiste un tempo dell'elaborazione e che esso si muove sempre nella stessa direzione, tende sempre allo stesso fine che d'altronde non raggiungerà mai malgrado gli innumerevoli aiuti, malgrado l'adesione quasi unanime che esso incontra; questo fine è la cancellazione dell'assassinio collettivo. La versione sprovvista di assassinio collettivo è percepita come successiva a quella che ancora lo contempla. E' quello che io stesso ho tentato di mostrare a proposito di Baldr e dei Cureti. La trasformazione mitologica è a senso unico e si effettua nel senso della cancellazione delle tracce.
E' interessante osservare, in fine, che a Roma è sempre esistita una tradizione propriamente apocalittica: partendo dall'origine violenta della città, essa ne profetizza la distruzione violenta. Nella sua "Histoire des idées et des croyances religieuses", Mircea Eliade parla delle ripercussioni del mito di Romolo e Remo nella coscienza dei Romani:
«Di questo cruento sacrificio, il primo che sia stato offerto alla divinità di Roma, il popolo conserverà sempre un ricordo terribile. Più di settecento anni dopo la fondazione, Orazio lo considererà ancora come una sorta di colpa originaria le cui conseguenze avrebbero dovuto ineluttabilmente provocare la perdizione della città, spingendo i suoi figli a massacrarsi fra di loro. In ogni momento critico della sua storia, Roma si interrogherà con angoscia, credendo di sentire pesare su di sé una maledizione. Neppure alla sua nascita essa era stata in pace né con gli uomini né con gli dèi. Questa ansietà religiosa peserà sul suo destino» (7).
La tradizione è interessante in quanto rende responsabile dell'assassinio fondatore l'intera collettività. Essa si basa necessariamente su una versione collettiva dell'assassinio, e anche se nell'idea che si fa delle ripercussioni lontane di quest'ultimo c'è qualcosa di magico, ci comunica una verità indipendente dal suo modo di esprimersi: l'obbligo per qualsiasi comunità di fondarsi e ordinarsi partendo da una violenza radicalmente distruttrice nel suo principio e che dovrebbe restare tale sino in fondo, ma di cui grazie a chissà quale miracolo la collettività ha potuto "differire" la violenza, e grazie a un qualche rinvio divinamente concesso questa violenza è divenuta provvisoriamente edificatrice e riconciliatrice.
NOTE AL CAPITOLO 7.
(1). "Repubblica", 378 a-b, ed. Léon Robin, Gallimard, Paris, 1950.
(2). Cit. da Georges Dumézil, "La religion romaine archaïque", Payot, Paris, 1966, p. 108 [trad. it. "La religione romana arcaica", Rizzoli, Milano, 1977, p. 100].
(3). Op. cit., vol. 1, p.p. 156-57 [trad. it. "Storia delle credenze e delle idee religiose", cit., I, p.p. 160-61].
(4). Tito Livio, "Storia romana", Libro primo, cap. 16.
(5). Plutarco, "Vita di Romolo", 43-45 [La citazione di Girard è tratta dalla traduzione francese di Amyot, Paris, 1950, p.p. 72-75].
(6). Libro primo, capp. 6-7; il corsivo è mio [La citazione di Girard è tratta dalla traduzione di Gaston Bayet, «Les Belles Lettres», Paris, 1940, p. 13].
(7). Op. cit., vol. 2, p. 109 [trad. it. cit., 2, p. 113].