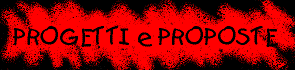
| <<Il gioco del mondo_Arendt 1975 | 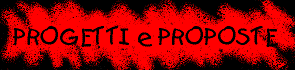 |
art de la fugue>> |
- Qual è stato il tuo percorso di formazione politica e culturale?
Il mio percorso di formazione è complicato, perché
di fatto ho cominciato a stare più o meno a sinistra, ma generica, molto
mendesiana, prima del ’68: forse certi punti erano prossimi ai gaullisti
di gauche, questo è il primo orientamento. Il mio percorso personale
è molto complicato, mio padre non l’ho visto prima della classe
di filosofia, in quanto mia madre aveva voluto così, dal momento che
lui era piuttosto dell’estrema destra e quindi lei temeva che potesse
avere su di me delle forti incidenze intellettuali. Dunque, sono stato allevato
dal suo secondo marito, un corso professore di inglese: questi era molto legato
al partito comunista fino al ’56, poi ha iniziato ad avere forti riserve
e ha chiuso col partito comunista quando siamo partiti per il Brasile nel ’62.
Dopo di che, prima di partire per il Brasile, io ho saputo che mio padre non
era il primo marito di mia madre, cioè Moulier, ma era un altro: l’ho
poi visto e incontrato solamente a partire dal ’66-’67. A quel punto
lì io stavo per fare degli studi di architettura, di fatto c’è
stata una deviazione perché sono andato a fare la Scuola Normale: pur
non condividendo del tutto le scelte politiche di mio padre, pur trovando che
lui aveva un tipo straordinario, ho fatto questa Scuola Normale che mi ha orientato
verso la filosofia, che ho fatto con Louis Clavel. Da una parte ho visto molto
Gabriel Marcel, facendo della filosofia tradizionale e dall’altra parte
ero piuttosto legato per amicizia a persone del movimento prima del ’68,
che si caratterizzavano come gente piuttosto di sinistra, mi ricordo ad esempio
discussioni sulla seconda guerra tra Israele e i palestinesi nel ’67.
Arriviamo poi al ’68, fase in cui sono stato coinvolto molto rapidamente
in un milieau di sinistra: è stata una politicizzazione di massa, di
uno che stava piuttosto dietro le cose e che viene coinvolto in primo piano,
ma portato, non c’era una pianificazione, non avevo pensato di fare così.
Dopo di che ho partecipato a tutte le manifestazioni: io avevo compagni che
erano coinvolti nel Vingtdeux Mars, ho fatto naturalmente il 13 maggio, le barricate
ecc. E’ molto esemplare che, non essendo nulla in questo movimento, ho
portato lo striscione in testa alla manifestazione, dopo di che mio padre ha
visto le foto sui giornali, si è arrabbiato moltissimo, siccome mia nonna,
che avevo visto molto poco, è morta in quel periodo, mi ha detto che
io l’avevo ammazzata; poi, dal momento che sono entrato nella Scuola Normale,
si è un po’ calmato, a quel punto poteva essere una sorta di riconoscenza
tra potenze.
Dall’autunno del ’68 fino al ’71-’72 ho cercato un po’
quello che mi interessava. Avevo già letto Machiavelli, il Manifesto,
le cose classiche, poi ho incominciato a leggere più seriamente e ho
incontrato della gente molto interessante, marxisti parasituazionisti che facevano
una rivista che si chiamava Poesie et Revolution, Jean Ouver e altri; Ouver,
ad esempio, è stato scelto da Maximilian Rubel per aiutarlo nelle edizioni
di Marx nella “Pleiade”. Rapidamente sono entrato in contatto con
l’ultra-gauche, la più pura, si trattava di gente come Daniel Saintgerme,
l’ultima parte di Socialisme ou Barbarie, quella che ha fatta Information
et Corrispondance Ouvriere. Tra l’altro ho partecipato all’ultima
riunione di Noir et Rouge, che erano Vingtdeux Mars, ho incontrato tutta la
sua vecchia guardia. Erano piuttosto anarchici, perché politicamente
io ero assolutamente convinto dell’utilità della critica sociale
e dell’intervento operaio, però non vedevo perché passare
attraverso il PCF e neanche vedevo la pertinenza dei marxisti-leninisti, non
ero molto interessato dai trotzkisti ed ero molto critico sul tipo di appoggio
ai vietcong nella guerra del Vietnam, perché mi sembrava già una
ripetizione della lotta di liberazione algerina. Mi interessavano allora le
Cahiers du Mai, di Information et Corrispondance Ouvriere, ho partecipato per
quasi un anno a tutta questa vicenda; poi andavo alle assemblee e lì
ho incontrato compagni italiani che una volta mi è capitato per caso
di ospitare nella mia casa, perché in quei tempi c’era gente che
veniva da lontano e dopo le assemblee li si ospitava. Sei mesi dopo, nel ’69,
sono stato contattato da uno che si chiamava Beppe Bezza che faceva l’operaio
alla Renault: mi ha chiamato sulla questione della mensualizzazione, il problema
di questa iniziativa capitalistica che è stata la vera risposta al ’68,
Pompidou e il progetto di nuova società, contratto di progresso negli
enti pubblici ecc. Lui mi ha chiamato dicendo che aveva fatto un documento,
un volantone sulla mensualizzazione: ho letto queste tre o quattro pagine, naturalmente
era in un francese orrendo, però sono rimasto stupito perché era
probabilmente la prima volta che leggevo qualcosa che aveva un simile interesse.
Da quel momento lì mi sono stancato della “sceneggiatura”
francese, non ho più partecipato veramente a Information et Corrispondance
Ouvriere e a tutte le altre cose perché il discorso mi sembrava vecchio,
anche se avevo interesse a leggere le critiche di Lenin e a seguire tutta l’agitazione
perché come studente partecipavo ai collettivi antiautoritari. Però,
per il discorso politico ho incontrato questo Beppe Bezza, che era molto interessante,
un personaggio un po’ strano, e lui mi ha portato la cosa decisiva che
è stata Tronti. Io non parlavo per niente l’italiano, non sapevo
neanche leggerlo, però, dato che avevo vissuto in Brasile dai 13 ai 17
anni, mi è diventato facile impararlo e poi leggerlo. Bezza aveva firmato
un tipo di accordo con Edition et Documentation Ouvriere, che era un posto famoso
in cui si facevano delle traduzioni, e Robert Paris, il famoso curatore di Gramsci,
cercava di far tradurre il libro di Tronti; poi sono stato coinvolto in questa
storia dal ’70 fino alla pubblicazione, che è avvenuta nel ’77,
però il testo era finito nel ’74. Questa è stata la mia
formazione: facendo la traduzione di Operai e capitale ho cominciato a leggere
un po’ sistematicamente sia Marx sia Lenin, perché per il resto
avevo piuttosto una formazione di critica, mi interessavano molto Scholieau,
Cardan, i rapporti di produzione in Russia, il che era una discussione importante,
avevo letto tutta la tradizione di Pannekoek e gli altri. Sono tornato a vedere
Tronti, è stata una cosa interessantissima, dopo di che ho incontrato
anche i compagni portoghesi che erano in gran parte ex del PC clandestino, e
durante quel tempo avevano pubblicato due o tre pamphlet sull’Angola e
lo sciopero operaio nel Limburgo; ho lavorato con loro, poi con alcuni studenti
della Scuola Normale abbiamo fatto un gruppetto. Abbiamo fatto anche il go between
tra questi gruppi, gli italiani (che progressivamente si sono rivelati più
o meno tutti di Potere Operaio) e i gruppi francesi, quelli più prossimi,
cioè Vive la Revolution e gli altri. Nel ’71 sono andato ad un
convegno organizzato da Potere Operaio a Firenze, con Lapo Berti e tutti gli
altri: all’inizio io ero piuttosto legato a gente come Sergio Bologna,
decisamente Alquati mi interessava molto, c’era tutta quella parte di
Potere Operaio che era più operaista, la più trontiana, la meno
soggetivista. Nel ’73 ho incontrato Negri, e fino al ’79 non ho
smesso di essere coinvolto nella storia italiana piuttosto che in quella francese.
Dunque, la formazione è tata tipicamente operaista, ho letto tutto quello
che veniva prodotto, come si diceva erano i più grandi marxisti del mondo,
però probabilmente troppo intelligenti, come sosteneva Lapo Berti: “siamo
talmente intelligenti che lo prenderemo nel culo!”. Pensandoci un po’
da capo, erano specialmente un paio le cose che mi interessavano: come capire
questa società dal punto di vista della fabbrica, ho avuto sempre una
curiosità che ho imparato dagli operaisti, che oggi mi serve anche professionalmente,
per i funzionamenti materiali del processo di lavoro, ma leggendoli come processi
politici o come concentrato della politica, per riprendere il nostro caro Lenin,
cioè il vedere questo tecnico come concentrato della politica, come controllo
ecc. Questa mi sembrava una rivoluzione epistemologica. Dunque, interesse per
gli operai, per i movimenti sociali, per il basismo, per la democrazia di massa,
e d’altra parte interesse intellettuale come paradigma. Io mi sono un
po’ autoformato, prima dei vent’anni non sono stato coinvolto nel
marxismo tradizionale come formazione didattica. Dopo di che io sono stato un
autodidatta, con maestri come Alquati, Negri, Bologna e gli altri, si trattava
veramente di una generazione straordinaria. In Francia sono stato molto isolato:
è infatti molto curioso il fatto che sia rimasto completamente estraneo
al paesaggio politico-teorico francese. Non condividevo né l’idea
politica dei maoisti, né quella dei cristiani di sinistra, da Clavel
a tutti quelli che si definivano sartriani, poi non condividevo neanche gli
althusseriani che erano tutti tornati attorno al partito, né Althusser.
Avevo tutti i riferimenti in un altro paese, è stata un’esperienza
di emigrazione teorica. Per di più ho fatto delle iniziative militanti,
nel ’73 abbiamo organizzato alla Scuola Normale un seminario che probabilmente
era molto emblematico di quello che io cercavo inconsciamente: da una parte
abbiamo fatto venire Negri, Daghini, in un dibattito sul concetto di capitale,
sulla crisi della legge del valore, al tempo in cui Althusser mandava le persone
a vedere e queste non capivano niente di quella cosa lì; poi, dall’altra
parte, abbiamo fatto un incontro con gli operai dell’auto con Romano Alquati
e alcuni altri. Il peso politico di queste cose era però quasi nullo,
tranne che per un piccolo circo non aveva riferimenti massicci. Naturalmente
durante questi anni ci sono state discussioni con gli italiani, coordinamenti
internazionali a Zurigo, e lì io mi sono confrontato con questa storia
del partito, con la fase leninista di Potere Operaio, e probabilmente c’era
chi aveva la percezione immediata del limite della questione, già Alquati
e Bologna erano molto dubbiosi su questa cosa dal ’72, di fatto nel ’73
è diventato chiaro. Dunque, non condividevo tutta quella parte un po’
“piperniana” di Potere Operaio, anche se erano compagni molto simpatici:
noi dalla Francia vedevamo il limite di questa impostazione, queste fasi iperleniniste
io non le condividevo perché venivo da un’esperienza anche teorica
dell’ultra-gauche, dunque estremamente contraria a quel tipo di forzatura.
Ma d’altra parte io direi che era la più bella esemplificazione
teorica del progetto di partito, il che è triste, avrebbe dovuto esserci
questa teorizzazione negli anni ’20, quando non esisteva e lì avrebbe
potuto essere molto interessante, però a quel punto era la nottola di
Minerva. Dunque, c’è tutta questa storia, i quadri di Potere Operaio
si chiedevano se la vicenda del ’17 era un accidente, un miracolo, cosa
che si trova anche in Tronti, ossia il fatto che la rivoluzione come concetto
scientifico non esiste. Di fatto a livello francese non era tanto politica,
era una formazione, era l’incontro con alcuni compagni, anche francesi,
formazione di gente molto isolata e molto dubbiosa sulla situazione francese,
sul tipo di avvenire dei gruppetti.
Dal ’73 in poi, fino al ’76-’77, si è scatenata la
crisi del gruppismo dell’estrema sinistra, un po’ dappertutto; in
Italia, con la scissione di PO a Rosolina, ma anche in Francia dove le cose
sono avvenute prima: il ’68 prima del ’69, la crisi dei gruppi,
di qualsiasi gruppo, prima dell’Italia. Forse gli italiani hanno pensato
di essere più intelligenti (il che era vero), più formati, più
sofisticati dei francesi, che erano un po’ pratici; però, di fatto
si è rivelata essere la stessa crisi, come ha dimostrato il ’77.
Questo avrebbe potuto essere un dramma o una depressione, cosa che è
effettivamente avvenuta in parecchi casi, per tutta una generazione che ha smesso
di fare politica e che si è messa da parte rispetto ad ogni idea generale,
tale è stata la situazione di gran parte della sinistra extraparlamentare
francese: dopo il fallimento alcuni sono tornati verso il giornale Liberation,
altri mano a mano sono tornati verso gli studi del pensiero ebraico (si prenda
l’esempio di Victor), o veramente hanno smesso di fare non solo politica
ma anche qualsiasi teoria. Durante questo periodo, cioè dopo lo scioglimento
di PO, in Francia direi che si è aperto un certo spazio per l’autonomia:
a me andava molto meglio l’autonomia e l’autonomia dell’operaio
sociale che la forzatura, il partito, le avanguardia per il partito, anche se
era ben scritto non era nulla, mi sembrava più che altro un discorso,
non una reale capacità di organizzare le cose. Dunque, durante questa
parte che va dal ’74-’75 fino al ’79-’80-’81,
c’è stato un vero e proprio inizio di uno sviluppo degli autonomi
francesi, che erano diversi dall’autonomia operaia italiana ma che costituivano
un’interessante realtà. Abbiamo quindi fatto un’esperienza
che era più francese che italiana, sono tornato a fare il leader dell’“autonomia
francese”, che in quel periodo ha fatto veramente una grande attività
sia nelle radio, sia nell’intervento del collettivo disoccupati e dei
sans papiers.
Non ho ancora parlato di un incontro che è stato per me decisivo, ed
è quello con compagni dell’immigrazione. Di fatto la questione
dell’immigrazione interessava ai nostri compagni italiani, specialmente
quelli di PO, però l’immigrazione italiana era interessante come
modo di propagazione, ma non era il problema teorico dell’immigrazione
come una spaccatura nella composizione di classe, come un problema reale di
essa. Mi ricordo che era difficile spiegare ai nostri compagni della Fiat o
a Romano Alquati che avere 22 nazionalità non è la stessa cosa
che avere una classe operaia italiana, anche se c’erano gli italiani del
Sud era comunque un’altra cosa; e quando 300 tunisini sono stati assunti
dalla Fiat nel ’73, mi ricordo perfettamente che ho detto ad Alquati,
a Toni e ad altri che bisognava sorvegliare questo fenomeno perché era
molto importante. Cosa che loro non hanno fatto, penso che sia stato un errore
tremendo: a mio avviso, anche se naturalmente è facile rifare la storia,
però tutto quello che ha seguito, questa radicalizzazione della classe
operaia bianca, in questo includendo i CUB, poi le Brigate Rosse e gli altri
gruppi armati, è accaduto quando nella composizione di classe il partito
invisibile non era più tale perché era già sciolto in varie
situazioni, e il padronato aveva un piano per scomporre tutto completamente,
per sconfiggere. Non mi ricordo quanti operai immigrati c’erano all’epoca
ma certamente nella sconfitta dell’80 alla Fiat questa era già
una variabile importante nel territorio. Ciò è un peccato perché
avremmo potuto veramente organizzare delle cose e cambiare un po’ questa
dinamica. Nel ’70 mi ricordo che Luciano Ferrari Bravo mi aveva chiesto
per L’operaio multinazionale uno scritto che ho fatto sull’immigrazione
in Francia, e lì ho studiato e ho scoperto una cosa che per me era importante,
cioè che mai la classe operaia è stata francese: il che era una
scoperta, perché si diceva che esisteva prima una classe operaia francese,
poi è stata scomposta dall’immigrazione, ma di fatto, riprendendo
da capo, ci si accorge che non è mai esistita una cosa del genere. E
c’era una traccia di ciò, la famosa discussione sulla classe operaia
di Francia o la classe operaia francese: è stata una discussione nel
Partito Socialista dell’Internazionale in Francia sopra la denominazione,
Parti Ouvrier de France o Parti Ouvrier Francais. La cosa corretta era piuttosto
Parti Ouvrier de France, perché già la classe operaia era completamente
mezzo italiana, poi polacca ecc. Mi ricordo perfettamente che l’anno in
cui è scoppiata la famosa questione attorno alla catastrofe di Formi
(se non sbaglio attorno al ’93 dell’800) è esattamente il
punto in cui arriva l’operaio italiano e gli operai francesi smettono
di ricavare metà del loro reddito dall’agricoltura: essendo stato
tagliato questo “giardino” dell’operaio francese, questo operaio
si trovava con il salario solamente come mezzo di reddito e con il salario della
fabbrica, si rifiuta di stare nella fabbrica, e comincia la crisi, si chiamano
quindi gli italiani e gli altri, e si degradano anche le condizioni di lavoro,
perché questo Formi è l’inizio della fuga dei francesi dalla
miniera, l’inizio della sostituzione molto rapida con i minatori polacchi,
italiani ecc. Questa cosa è stata importante per il resto della ricerca
che ho fatto sulla schiavitù; ma nello stesso momento in cui io facevo
questa ricerca sulla composizione della classe operaia francese o di Francia,
mi ricordo perfettamente che incontrai i piccoli gruppi di militanti che intervenivano
sull’immigrazione, attorno agli immigrati arabi. Con questi amici portoghesi
avevamo fatto già allora un collettivo sui sans papiers, sui senza documenti,
poi abbiamo incontrato dei compagni del MTA, che erano usciti dal comitato Palestina,
scioltosi quando la Gauche Proletarienne è scoppiata completamente. Questo
movimento di lavoratori arabi ha fatto una cosa pazzesca, un grande sciopero,
è riuscito a fare il blocco della fabbrica Citroen di 25.000 operai in
cui c’erano 22 nazionalità. Era molto affascinante vedere come
un piccolo gruppetto fosse in sciopero contro il razzismo: c’erano infatti
stati dei moti di lavoratori algerini che erano stati ammazzati a Marsiglia
e avevano quindi fatto questo sciopero contro il razzismo, non sapendo quasi
nulla dell’interno della fabbrica, mentre invece tutti i gruppetti di
Vive la Revolution e gli altri stavano lavorando lì da anni per tentare
di entrare dentro e di fare qualche cosa. C’è stato il corteo interno
e poi hanno bloccato la fabbrica: questa cosa era molto interessante, perché
ti dava anche una lezione di politica. Sono poi rimasto in contatto con questi
soggetti che erano veramente interessanti come tipo di militanti e per il rapporto
tra il territorio e l’interno della fabbrica, una cosa molto interessante
anche per quanto riguarda la soggettività operaia. Vivevano in condizioni
pazzesche, direi di miserie, di vita incredibile, ma erano legati ad un’esperienza
collettiva, ad una comunità esterna alla fabbrica, e hanno resistito
perfettamente alla sconfitta interna, non faceva loro nulla. Mi sono probabilmente
reso conto a quel punto che l’organizzazione interna della fabbrica non
interessava più questo nuovo tipo di militanti, cioè che dal territorio
si prendeva la fabbrica, non il contrario. Queste persone erano anche legate
ad esperienze violentissime, perché i comitati Palestina nel ’72
erano veramente considerati dei terroristi da qualsiasi ente statale; però,
questi avevano anche una capacità di sentire quello che si può
fare e quello che non si può fare che non esisteva più all’interno
della fabbrica. Penso che anche questa forza interna è diventata una
debolezza. Dunque, per me l’esperienza politica italiana era più
la fine di un processo terzinternazionalista che l’inizio di uno nuovo.
Allora, tornando alla questione dell’immigrazione, abbiamo fatto lo sciopero
dei sans papiers, sciopero della fame, organizzazione delle nuove nazionalità,
e poi abbiamo fatto anche intervento sulla scuola da piccolo gruppo, perché
ogni due anni nella scuola c’era una nuova onda di contestazione. Il che
era accomunato a questa storia dell’autonomia, abbiamo fatto una rivista,
in piccolo abbiamo vissuto un po’ tutti i percorsi italiani, però
in una situazione da una parte molto più debole, dall’altra molto
più prefigurativa del futuro, perché attorno alla vicenda del
’77, dell’appello contro la repressione in Italia, c’è
il legame con tutta una parte di gente attorno a Guattari. Si è così
determinata un’area dell’autonomia che andava dai desideranti ai
più organizzati ed era significativa, che immediatamente si è
confrontata con delle questioni non facili, come la ristrutturazione della siderurgia
e il nucleare. Sulla ristrutturazione della siderurgia abbiamo avuto un intervento
veramente importante, che ha preoccupato seriamente anche il PCF, ed è
la manifestazione dei metalmeccanici a Parigi nel ’79: è stato
molto significativo, se ne è discusso, ci sono stati arresti per dimostrare
che questi autonomi facevano casino, hanno arrestato 300 prima della manifestazione,
ma questa si è fatta comunque ed è stata importante. E’
stata una componente vitale della svolta politica dell’81, dall’altra
parte c’erano anche i movimenti dei disoccupati, perché abbiamo
lanciato i primi comitati non per l’impiego ma all’interno delle
strutture della disoccupazione, che sono stati più o meno la base su
cui si è organizzato il movimento ma 15 anni dopo. E’ stato un
po’ un laboratorio di questa gente perché c’è anche
una continuità con dei compagni che hanno fatto questa esperienza e che
sono dentro un movimento, naturalmente con una dialettica con i trotzkisti e
altre componenti, c’è stata questa presenza interna al movimento
dei disoccupati. Naturalmente la questione del razzismo è diventata importante,
mi ricordo perfettamente tutto il movimento e poi la discussione con i compagni
inglesi: tutto questo ha fatto sì che diventasse una cosa un po’
più pesante e un po’ più difficile ma interessante. Sul
nucleare abbiamo vinto in Bretagna, abbiamo perso altrove, specialmente a Parigi,
perché non avevamo la capacità di organizzare e diffondere, il
movimento non era abbastanza ricco per affrontare tutto ciò, c’era
una sollecitazione tremenda dello Stato ad andare a scontri più duri,
ogni passo verso questi scontri di fatto aveva come risultato un progresso della
parte più militarizzata del movimento e una spaccatura dell’altra
parte che rifiutava quel tipo di militarizzazione: a mio avviso ciò è
molto illustrativo di quello che possiamo avere nella radicalizzazione della
“controglobalizzazione”, aggiungiamo venti Goteborg e avremo questa
spaccatura nel movimento, uno scontro durissimo di una parte più militarizzata
e più militante e tutta una nebulosa di gente che non può più
far niente perché non ha lo spazio nella strada, non può neanche
manifestare pacificamente. Ciò era molto interessante come processo,
ma durante quel periodo abbiamo avuto anche il problema rinascente di tutti
quelli che pensavano che la Gauche Proletarienne si fosse sciolta per una sorta
di arretramento, sciogliendo l’apparato militare: i giovani ritenevano
che fosse un disegno volontario di smantellamento della capacità offensiva.
Questi hanno ripreso una dimensione pazzesca, hanno pensato che liquidando il
Tramoni che aveva ammazzato Loverné si poteva riaprire un ciclo nuovo:
naturalmente non hanno fatto niente. Però, questa è stata per
noi una grossa discussione, perché anche dai nostri collettivi è
uscita una parte della gente che dopo ha gravitato intorno ad Action Direct,
e abbiamo dovuto discutere molto fermamente, è stato assai difficile.
Ho fatto una registrazione alla televisione su queste cose, non so quando uscirà,
era importante perché quel tipo di radicalizzazione che li ha portati
due anni dopo ad ammazzare il capo della Renault era una cosa che è uscita
dal fallimento del movimento e dalla ricerca di forme politiche in cui questa
volontà di trasformazione avrebbe potuto essere usata altrimenti: ciò
si è perso e questi compagni la pagano duramente, uno è diventato
completamente matto e l’altra è malata, e sono già in carcere
da 25 anni. Poi c’è stata l’ondata repressiva italiana che
naturalmente ci ha fatto pensare, perché eravamo talmente legati a Negri
e agli altri che mi ricordo che uno di Liberation si aspettava l’arresto
di me o di qualcun altro, cosa che non è accaduta.
Tuttavia, già una parte del movimento autonomo si era ricomposto sulle
questioni di inquinamento, del nucleare ecc.; qui abbiamo incontrato i Verdi,
che non erano ancora quelli che poi sono diventati. Anche Guattari è
entrato nei Verdi, ha giocato un ruolo importante durante gli anni ’80
a mettere insieme rosso e verde, per fare questo partito che poi è diventato
quello dei Verdi francesi, spostandoli da una posizione di centro o comunque
non di sinistra verso la sinistra. Questa era l’ultima cosa a cui abbiamo
partecipato, io nel giornale La Gueule Ouverte, che poi è diventata La
Gueule. Nell’81 io ho poi fatto l’ipotesi della svolta e della vittoria
di Mitterand, che fra l’altro non era molto condivisa anche dai miei amici,
perché io ho pensato che lì c’era qualcosa importante, la
pena di morte, la svolta verso situazioni nuove. C’è tutta una
generazione che si è rimessa a fare politica, e non completamente schiacciata
fra lo scontro contro lo Stato e una società civile o partiti istituzionali
completamente vecchissimi. A quel punto lì ho smesso di fare della politica
in modo attivo, cioè ho seguito le cose però non sono stato molto
coinvolto, osservavo il Partito Socialista, seguivo la scomposizione del PCF
ecc. Ho seguito un po’ Futur Anterieur, ero un po’ dubbioso sulla
sua impostazione politica più che sulla impostazione teorica, perché
io avevo dei problemi con una parte del ceto paratrotzkista, Jean-Marie Vincent
e altri, che erano legati alla rivista con gli italiani. Di fatto non avevamo
uno spazio specifico, perché i francesi consideravano gli italiani, Negri
e i rifugiati, come una parte, mentre per loro tutti gli altri erano francesi,
quindi i francesi che non erano trotzkisti come Vincent erano anch’essi
degli italiani. Dunque, quando Toni è uscito, tornando in Italia, pensavamo
a cambiare la rivista, io non ero dentro anche se avevo fatto vari contributi,
perché specificamente non ero d’accordo con l’impostazione
sull’Europa, pensavo che bisognasse andare molto più avanti sulla
questione europea: io non ero contro Maastricht, non ero contro la guerra dell’Iraq,
mi dava fastidio, e infine io non condividevo del tutto l’orrore contro
la Nato, la guerra del Kosovo e tutto il resto, perché pensavo piuttosto
che era la prima guerra europea, cioè la prima guerra della nuova potenza
politica. Per me era molto importante capire che, per esempio, l’Inghilterra
e la Francia avevano fatto l’unione dell’industria e della difesa
europea, e questa svolta era decisiva, marcava anche la reintegrazione della
Germania dopo la riunificazione. Si trattava di una sorta di “tripode”
dell’Europa che si dispiegava sulla costruzione di un ente politico assai
nuovo, che era di fatto un nuovo tipo di impero, essendo l’Unione Europea
una potenza vera, cercando di crearsi come tale. Mi ricordo che su questa cosa
Toni non era del tutto d’accordo, era molto scettico, pensava che sarebbe
fallita; io, invece, pensavo che si sarebbe fatta perché non esistevano
altre soluzioni, e in questo senso era una questione molto forte in quanto costruita
nella delusione assoluta: non era il prodotto di una grande manifestazione dopo
di che c’è un riflusso, ma era una cosa fredda fatta dalla realpolitik,
tipo l’unificazione tedesca fatta da Bismarck. Per me capire queste cose
era molto più importante del resto, perché fare della politica
senza mettersi in questo quadro significava veramente sbagliarsi completamente,
fare della ripetizione. Toni ha un po’ cambiato sull’euro, c’era
genete che diceva che non si sarebbe fatto, mentre io ero sicuro del contrario.
Dunque, quanto Toni è partito per l’Italia con una correzione di
linea sulla questione europea, io sono entrato in Futur Anterieur, ma è
durato un anno, perché poi è scoppiato lo scontro con Jean-Marie
Vincent e gli altri, non siamo riusciti a fare la rivista che volevamo con una
nuova formula; ci sono stati anche problemi sul resoconto del libro di Agamben,
poi su questioni ideologiche sul presunto (tra l’altro falso) negazionismo
di alcuni compagni dell’estrema sinistra. E infine, siccome io avevo pensato
di aprire la rivista a molta gente, i nostri amici trotzkisti si sono rifiutati
perché erano minoranze e non potevano accettare, e non c’era Toni
per fare la mediazione. Dunque, nel ’99, un po’ prima del Kosovo,
ci hanno detto che non volevano più lavorare con noi e quindi abbiamo
fatto un’altra rivista che è Multitudes, e attorno a quella abbiamo
preso tre quarti della gente, muovendoci su dei terreni più interessanti,
il biopolitico, l’Europa, la nuova economia ecc., riprendendo da capo
un’esperienza teorica legata strettamente alle questioni della rete, di
Internet e via dicendo, e poi facendo dei collegamenti con delle forze come
gli hackers o i sindacati di difesa. Abbiamo fatto un lavoro che comincia ad
essere interessante. Dunque, mi sono inserito in questa nuova esperienza politica
nello stesso momento in cui sono entrato nei Verdi, nel ’99, per la campagna
europea di Daniel Cohn-Bendit, di cui sono stato un po’ un consigliere,
il più a sinistra, mentre invece il vecchio Laidi era il più a
destra. Nei Verdi sono stato anche un po’ il consigliere di Mamere rispetto
a Lipietz, uno che ritengo molto classico, della classica estrema sinistra.
Adesso faccio in parte politica all’interno del comitato dei Verdi, senza
avere un mandato elettorale, faccio un po’ il consigliere, sono ad esempio
stato chiamato a discutere nel comitato esecutivo sulla questione del calo della
crescita economica, sul come reagire, sui salariati e via dicendo.
Questa è la parte politica, mentre per quanto riguarda la parte teorica
la questione delle migrazioni e della composizione di classe mi ha dato un certo
percorso. Nell’84 c’è stato un convegno a Montreal organizzato
da Piperno, di cui è uscito un libro, ho tentato di fare una presentazione
globale dell’operaismo, del perché era stato sconfitto.
- Avevi fatto in particolare una relazione sulla composizione di classe.
Composizione, ricomposizione, le questioni della soggettività,
il perché questo movimento si era spaccato dentro la soggettività
oggettiva di Tronti, che è un po’ un bernsteinismo dell’operaismo,
e la soggettività esasperata di Negri che è l’opposto. Però,
ambedue non ci portano nella politica: quella di Negri è più produttiva,
mentre ho letto quello che Tronti ha scritto per la recente prefazione di Operai
e capitale che è apparsa a Madrid quest’anno e mi sembra che il
discorso sia meno preciso, molto più allargato e molto più vago.
Dall’altra parte in Empire di Negri e Hardt, che è un libro importante,
sulla parte propriamente programmatica mi sembra che manchino delle mediazioni,
manca ricchezza di proposizione ecc., oltre al reddito garantito, la cittadinanza
universale, non c’è gran cosa come proposta strategica, specialmente
sull’Europa e altre questioni. Dunque, il problema di come trattare non
tanto la fine del lavoro ma la fine di un certo tipo di movimento operaio, era
legato alla questione delle migrazioni, del culturalismo, del multiculturalismo,
di tutti questi nodi; in questo senso ho cominciato a trattare il problema dei
diritti, dei diritti civili, degli statuti, come base fondamentale per capire
molte cose, specialmente per capire il movimento di liberazione. Cioè,
il movimento di liberazione è interno alla questione dello sfruttamento:
non esiste lo sfruttamento che non sia movimento contrario, di liberazione della
gente, perché questa è sempre liberazione rispetto a un certo
status giuridico. E su questa cosa, prendendo le questioni delle migrazioni,
ho tirato un filo rosso che mi ha portato alla schiavitù. E’ per
questo che ho fatto il libro De l’esclavage au salariat e adesso stiamo
lavorando sulla questione: esiste una soggettività nella fuga, esiste
quel tipo di organizzazione della fuga, esiste una soggettività dell’exit,
e non una soggettività del voice. Ciò è importante, perché
mi ricordo che quello che mi piaceva del partito invisibile di Mirafiori non
era naturalmente il partito ma piuttosto l’invisibilità. Allora,
esiste questa cosa, come si può configurare, e a quel punto c’è
l’esperienza della prima classe operaia di fatto, perché gli schiavi
neri della piantagione sono stati la prima classe operaia. C’è
naturalmente forzatura in questo, ma lo penso veramente: l’ingovernabilità
della piantagione e delle prime forme del lavoro dipendente, salariato non libero
direi, è stato talmente forte che ha prodotto il ciclo tecnologico che
ha permesso l’inserimento di tutti quei poveri che durante il XVI, XVII
e XVIII secolo non è stato possibile mettere in fabbrica, cioè
l’addomesticamento e la disciplinarizzazione è stata possibile
nell’Europa, nel centro del capitalismo industriale, solo perché
c’era stata questa esperienza delle lotte prima, nel primo capitalismo.
Dunque, in quella transizione tutti i limiti pesanti del movimento operaio sono
dovuti probabilmente a questa spaccatura, il fatto cioè che la classe
operaia non ha avuto la memoria dei poveri e di essere stata nera prima di essere
stata bianca. Questo è importante quando torniamo all’oggi, al
passaggio al terzo capitalismo, perché per me è chiaro che striamo
vivendo un’epoca di questo tipo: il liberalismo, come già nella
nascita del capitalismo industriale, non è il nemico fondamentale, in
quanto è un’ideologia della transizione, non è un regime.
E’ un’ideologia della transizione che segna, con questa ipermercatizzazione
del mondo, la ricerca da parte capitalistica di nuovi centri di controllo, di
nuove strutture e anche probabilmente del capire quello che sta accadendo. E’
ciò che io chiamo la carta delle esternalità, positiva o negativa,
all’interno del sistema dell’economia-mondo, in cui il capitale
sta cercando di vedere come controllare le fughe del sistema. Dunque, in questo
periodo si apre uno sfasamento della vecchia cultura della classe operaia, del
lavoro salariato classico, e si apre una stranissima battaglia delle new enclosures,
e riconfigurazione totale del potere. Per me l’impero americano ha avuto
un apogeo, quello del crollo dell’Unione Sovietica, la riunificazione
tedesca, la guerra del Golfo fino alla guerra del Kosovo; ma quest’ultima
non è il segno della potenza massima della Nato, è l’inizio
del declino, perché questa guerra è stata fatta dagli americani
ma loro non volevano farla all’inizio, è stata un’invenzione
dei Fischer e il reinserimento della Germania all’interno del gioco, il
terzo polo del tripode di cui parlavo prima. E’ stranissimo perché
nessuno l’ha visto e notato: c’è stato un incontro molto
simbolico in Africa tra i rappresentanti francesi e inglesi per mettere fine
all’antica e bisecolare lotta d’influenza in quel continente, per
riprendere la cosa dagli americani, perché questi andavano facendo nell’Africa
centrale un casino quasi genocidiario. Quindi, c’è stata questa
iniziativa, anche se poi naturalmente vedere questa costituzione dell’Europa
come una cosa puramente positiva sarebbe stupido: con una potenza del genere
che si configura si assiste alla prima guerra delle frontiere dell’impero
europeo, c’è tutta questa zona dell’Est che è molto
fragile e che tra l’altro è in decolonizzazione, perché
la Russia si sta decolonizzando quarant’anni dopo le altre potenze europee,
sta perdendo la Georgia, la Cecenia, sta perdendo tutto, è una cosa legata
al suo intervento nell’Afganistan, che è l’ultima conquista
che ha messo in crisi tutto. Ciò assomiglia molto alla situazione americana,
quando gli americani vedevano la decomposizione dell’impero spagnolo.
Dunque, io penso che lì ci sia una questione importante e in questa guerra
del Kosovo gli americani sono apparentemente i prepotenti, quelli che fanno
ciò che vogliono, ma questo non è vero, perché già
comincia la contestazione: per parlare come Tucidide, la talassocrazia americana
ha avuto un periodo di egemonia assoluta estremamente corto, cioè di
dieci anni, e io interpreto questa pressione sui diritti adesso, l’OMC,
la questione della negoziazione sulla proprietà intellettuale ecc., come
il tentativo attraverso il diritto di sfruttare il vantaggio competitivo che
gli americani hanno preso durante gli anni ’90, avendo sia la prepotenza
militare che la prepotenza tecnologica con il modello della nuova economia,
che adesso si sviluppa dappertutto, però comincia a contestare l’egemonia
americana. Perché la rete adesso si mondializza e l’Europa recupera
della forza, e a mio avviso una cosa come il progetto del Giappone (che adesso
è ufficiale) di creare un mondo con lo yen rispetto al dollaro è
importante, in quanto ciò significa anche la messa in discussione del
tipo di equilibrio nato a Bretton Woods nel ’71, quando il dollaro ha
smesso di essere legato all’oro con il regime di tasso flessibile. Per
esempio, l’Europa è stata la prima a rifiutare questi yo-yo dei
tassi di interesse e dei tassi della moneta locale, e il Giappone ha fatto un’analisi
del suo stop and go che è molto vicina a quella inglese degli anni ’60,
malgrado un uso keynesiano che non è mai stato visto nella storia, cioè
il tipo di spese che hanno fatto a livello statale è enorme. Probabilmente
loro ritengono di non poter più sopportare questo scaricamento delle
tensioni interne americane sul resto del mondo in termini di scambio flessibile.
Ma non sono i soli, si prenda per esempio il Mercosur brasiliano, argentino
(i cileni hanno smesso di far parte di questa cosa): è vero che c’è
stata l’ultima svalutazione del real come risposta americana all’attacco
brasiliano al progetto di grande mercato nordamericano e alla produzione di
medici generici nell’Africa del sud, cosa emblematica, cioè il
Brasile, adesso che è diventata un’importante potenza industriale,
non può sopportare di vedere in quattro giorni la sua moneta abbassata
del 25%. Dunque, probabilmente dopo un’area tobiniana si apre un’area
di ritorno ai tassi di scambio fissi, perché non è che non sia
funzionale il ciclo del dollaro ecc., ma con il cambiamento dei poteri locali
e questa emergenza del tripode americano-europeo-giapponese, con la minaccia
della Cina, nessuno sa dove va a parare la situazione. Allora, in questo senso
penso che ci saranno delle pressioni fortissime verso tassi di scambio fissi
all’interno di grandi aree, e naturalmente ci sono i rapporti di questa
moneta con il dollaro che diventano più o meno antagonisti; cioè,
fine di questa regolazione liberale del mercato, dunque in un certo modo è
un livello più efficace per lottare contro la speculazione, ossia la
famosa Tobin Tax. Allora, queste cose sono importanti per determinare anche
che spazio c’è nell’Europa oggi, perché due anni fa
nessuno credeva che ci sarebbe stata un’accelerazione tanto rapida a livello
dello sbocco istituzionale europeo; tanta gente diceva che con questo allargamento
ci sarebbe stata una dilazione di tutto e che questi passi sarebbero andati
allo smantellamento dell’edificio nato nel dopoguerra, nato dalla Comunità
Europea e dal trattato di Roma. Invece, quello che si produce è il contrario.
Allora, il problema è perché, che tipi di composizione si producono.
Probabilmente non esiste altro modo di controllare il grado di scontro interno
all’Europa senza un livello federale. Essendo di matrice operaista, io
mi fermerei a questa ipotesi di ricerca, il cercare perché questa Europa
viene fatta malgrado i governanti: che spinta ha dietro, perché funziona
così? Perché probabilmente il mondo liberale non funziona, come
modello politico è chiaro che l’Europa è il cuore del rifiuto
di un modello politico di tipo imperiale o anglosassone. Ma probabilmente ci
sono delle cose più interessanti ancora: già un’unificazione
di fatto delle lotte e dei bisogni che non può essere ricondotta al progetto
di crescita nazionale. Dunque, questa è un’ipotesi sulla modernizzazione
del potere che non è solamente sviluppo capitalistico, è una cosa
più interessante perché ci apre anche delle finestre politiche,
in quanto siamo usciti da questi venticinque anni di inverno, come diceva Guattari.
Questa è una parte, l’altra è la questione teorica che mi
interessa: in questa transizione da un capitalismo all’altro, come dice
l’attesa della modernizzazione, oggi è un po’ la stessa cosa:
bisogna andare a vedere i rapporti con la nuova economia non tanto e non solo
come una modernizzazione del capitalismo con gli strumenti finanziari e liberali,
ma veramente come una crisi dell’ipotesi del capitalismo industriale,
cioè ristabilire questa dimensione della crisi. Perché quando
c’è potere finanziario c’è dietro una crisi, cioè
quando il potere si configura solamente con il comando della moneta probabilmente
c’è un’ipotesi di crisi fortissima del centro del potere.
Quindi, dovremmo cercare di vedere queste cose e probabilmente anche la posizione
che si assume se caratterizziamo questo passaggio al terzo capitalismo come
un capitalismo cognitivo, che cosa cambia nel quadro del marxismo classico,
direi anche dell’operaismo. Per esempio, stavo pensando alla riduzione
del lavoro vivo al lavoro morto, leggendo naturalmente i Grundrisse e gli altri
classici, e adesso penso che abbiamo veramente un nuovo tipo di sfruttamento,
che è produzione del lavoro vivo a mezzo del lavoro vivo tramite lavoro
vivo. Cioè, l’impossibilità di eliminare o di ridurre il
lavoro vivente a mero macchinario, capitale ecc. Il che cambia tutto sulla questione
del comando, perché questo non può essere dato dall’apparato
del capitale fisso: dunque il comando ridiventa il comando degli affetti, questi
nuovi operai cognitivi hanno più potere di quello che avevano i tecnici
sul capitale materiale, perché non sono più riducibili e ricontrollabili
tramite il peso del capitale. Dunque, tutta questa storia sul digiuno del capitalismo,
cioè di farlo diventare più svelto e più magro, non è
una storia solo di profittabilità, è piuttosto il contrario. Si
prenda ad esempio l’allargamento nelle start-up: è chiaro che il
capitale vero di quelle start-up sono i salari, sono il lavoro vivo, ma ciò
nella contabilità classica ed economica non può essere valutato
in questa maniera, perché il salario è visto come un costo ma
non come un investimento. Non sto parlando del fordismo, ma non è visto
a livello della produzione come il vero capitale, mentre invece nella produzione
dell’hardware e del software, il wetware (che è la mente) e il
netware (che è la rete) sono più importanti, sono legati completamente
tra di loro: più o meno a livello dell’economia politica siamo
tornati a Quesnay, abbiamo bisogno di un nuovo Tableau General perché
adesso la produzione di valore e di ricchezza ha completamente cambiato di senso.
Questo probabilmente significa che senza un mutamento radicale del salariato,
un indebolimento del salariato come tipo di controllo, non si darà un
regime stabile di controllo di questo lavoro dipendente che produce conoscenza;
nel terzo capitalismo, detto cognitivo (mi sto riferendo anche al lavoro di
Rullani, anche se noi stiamo lavorando a una problematica vicina ma un po’
diversa), la produzione del valore si fa producendo novità; però,
la novità non è più innovazione rispetto alla diffusione
e via dicendo, ma è direttamente la produzione di innovazione usando
la rete, usando l’attenzione. Dunque, il controllo dell’attenzione
e della rete non si può dare con il salariato classico, è probabilmente
necessario il suo indebolimento, siccome la conquista della libertà formale,
giuridica, il diritto alla fuga è stata la conquista fondamentale del
salariato puro, anche se ha funzionato nell’economia e anche altrove nel
centro, come l’ho chiamato io, con un salariato imbrigliato, con il 35-40%
della forza-lavoro mondiale che è stata imbrigliata, non libera; però,
adesso penso che il lavoro dipendente, producendo la parte maggiore del valore,
dovrà probabilmente riconfigurarsi con il tipo di cose che sono la garanzia
del reddito universale, cioè una base fondamentale molto più larga
che lascia la capacità di attività agli individui, cioè
crearsi il senso perché il capitalismo abbia il problema di pagare i
costi di transazione di questa cosa, che stanno diventando altissimi, ma che
spontaneamente si organizzano molto bene. Dunque, penso che probabilmente questo
aggiornamento radicale del salariato è la cosa che manca oggi, e il welfare-state
vi è legato naturalmente, perché finché non avremo questo
regime avremo l’instabilità finanziaria, c’è la gestione
del rischio sistemico che abbiamo ora in quanto non c’è questa
liberazione del salariato. E questa è un po’ la chiave di comprensione
per il futuro, per il tipo di battaglia sia attorno alla riforma dello Stato
sia alla forma del diritto del lavoro ecc., per l’organizzazione del lavoro
indipendente, ma in modo operaio, che funzioni come la nuova classe. Quali sono
oggi i nostri famosi fisiocratici, probabilmente tutto questo settore che fa
a meno del 10% della forza-lavoro sono un po’ i nostri operai di Manchester.
Bisogna pensare come organizzare la politica, l’intervento, anche l’idea
di liberazione di soggettività, di creazione, di trasformazione attorno
a questa ipotesi fondamentale. Naturalmente in questa ipotesi fondamentale la
fabbrica diventa quella che Peter Brooker ha definito come una scatola vuota,
cioè un tipo di rapporto giuridico: non a caso l’Alcatel ha annunciato
che nel futuro sarà una ditta senza impresa, senza stabilimenti che sono
trasferibili dappertutto. C’è un rapporto dell’OCD, ancora
più o meno confidenziale, che dice che l’80% di tutti i lavori
materiali che vengono sviluppati nelle metropoli europee possono essere fatti
da qualche altra parte del mondo molto facilmente. Dunque, questo probabilmente
significa che torniamo ad una situazione in cui le fabbriche sono ditte sul
territorio, che lo governano, con delle combinazioni di una parte dell’hardware,
essendo il prodotto o qui o là, ma ciò non importa perché
può essere cambiato domani. Questa riorganizzazione cambia enormemente,
perché probabilmente il tipo di rapporto ottocentesco fra società
e fabbrica, isolandosi, non esiste più, e questo è interessante
anche come problema di intervento. La crisi del sindacalismo, la crisi di ripresentazione
di questo lavoro mi interessa se legata a tale questione: il problema non è
che i sindacalisti non sono abbastanza bravi, che la gente non si mobilita ecc.,
questo non mi interessa, mi interessano invece le trasformazioni sistemiche
che possono dare un quadro complessivo di spiegazione.
- Rispetto all’operaismo politico e a questa ricerca, Romano ha formulato un’ipotesi che sicuramente si riferisce ad un’esperienza trascorsa, ma che può offrire dei fondamentali nodi analitici aperti nel presente. Romano sostiene infatti che l’operaismo si è mosso all’interno di un particolare poligono, cercando di fare i conti con i suoi vertici, in parte riuscendovi ed in parte no. I vertici sono rappresentati dalla politica e dal politico, dagli operai e dalla loro soggettività (questione ben poco affrontata dagli operaisti), dalla cultura (che tutto sommato è rimasta quella umanistica di derivazione desacntisiana-crociana-gramsciana), dalla questione generazionale e giovanile; si può poi aggiungere un quinto vertice costituito dalle donne. L’importanza dell’operaismo politico (in particolare di quello sviluppatosi tra la fine degli anni ’50 e i ’60) è stata di collocarsi, oggettivamente e soprattutto soggettivamente, in una cruciale fase di transizione capitalistica, quella del passaggio (che per l’Italia è avvenuto in ritardo rispetto ad altri paesi dell’occidente sviluppato) al taylorismo-fordismo; anche tu hai prima sottolineato la diversità della situazione francese rispetto all’anomalia italiana, che è sostanzialmente segnata da un periodo di reindustrializzazione. In questa particolare fase, l’importanza dell’operaismo è consistita da una parte nell’avere avuto una lettura nuova del sistema socio-economico, in questo rompendo con un PCI e una sinistra fermi al discorso sul capitale monopolistico; dall’altra, nell’individuare l’operaio-massa come forza baricentrale non solo per una prospettiva anticapitalista, ma anche per l’ipotesi di un’operaietà contro se stessa. In questo c’è stata la capacità di cambiare effettivamente segno rispetto alla cultura di sinistra che si è formata sull’operaio di mestiere, da cui il lavorismo, lo scientismo, il tecnicismo, lo sviluppismo di cui continua a essere impregnata la sinistra oggi. In questo senso si è riusciti ad andare avanti, verso una rottura con una certa sinistra e un certo marxismo; dall’altra parte, però, l’operaismo non riesce a ri-elaborare nuovi obiettivi, un nuovo progetto e una nuova cultura politica adeguata all’operaio-massa come referente collettivo, all’ipotesi di una classe operaia contro se stessa. A quel punto l’operaismo torna indietro, ad una cultura politica ottocentesca, quella formatasi sull’operaio di mestiere. Dalle interviste si può significativamente vedere come quasi tutti gli operaisti, con tutte le differenze di percorsi e di opzioni che si sono dati (Tronti nel PCI, Negri in un partitino ad esso alternativo), tutto sommato intendono la politica e soprattutto il politico come mera questione di organizzazione, e non come ri-elaborazione di nuovi fini, di un nuovo progetto e di una nuova cultura politica.
Si tratta della famosa affermazione che il compito non è niente, non abbiamo che fare, rifiuto immediato, il che produce la cultura del rifiuto.
- L’individuazione della classe come strategia, riduce il partito e la politica ad una questione tattica. Questo modo di intendere la politica è diventato piuttosto caratterizzante di tutte le varie ipotesi operaiste. C’è quindi un operaismo che va avanti e rompe con la sinistra e con un certo marxismo, e c’è un operaismo che torna indietro alla cultura politica ottocentesca formatasi sull’operaio di mestiere.
Probabilmente è per questo che, per esempio, è stata mancata la critica dell’ecologia politica, che è potente. Perché potevamo dire durante gli anni trontiani che l’unica anarchia del capitale era la classe operaia, ma oggi, se torniamo a grandissimi fatti, non possiamo dire solamente questo, perché c’è un livello di sviluppo che è in crisi, che non è più sostenibile, e lì dunque si riapre una discussione etica. Non a caso secondo me l’unica novità in termini di partiti politici in Europa è l’emergenza dei verdi, è veramente la novità di fatto. La gestione della città e delle metropoli adesso diventa una cosa rosa e verde, ha smesso di essere rossa, diventa rosa e verde dappertutto, anche a Parigi. E’ una situazione generale, perché l’intreccio tra questioni di sicurezza, di salute, di sanità, di destino individuale della gente, di tutte queste cose sono legatissime ad un progetto globale di società. E io direi che non possiamo più fare della politica dicendo quello che si poteva dire negli anni ’60, “ce ne freghiamo del progetto globale di società”; a chi gli aveva chiesto che tipo di società volevano nel futuro, Cohn-Bendit (che non era del tutto un operaista) aveva risposto: “innanzitutto non lo so esattamente, ma se lo sapessi non ve lo direi!”. Ma questo non funziona perché non possiamo dire che non ne parliamo del tipo di società che vogliamo, in quanto adesso la gente ne parla per la strada, il summit del G8 è tutto legato ad un’alternativa globale. Dunque, lì c’è un pesante limite. Ma altri limiti che dovrebbero essere esaminati sono limiti italiani. Non sono assolutamente sicuro che il ritardo e il recupero sia la migliore interpretazione, perché questa metafora è stata molto discussa da Gershenkron, e se di fatto torniamo alla Russia vediamo che essere in ritardo su un piano, è stato essere in avanti su un altro. Si potrebbe anche parlare dell’anomalia teorica dell’operaismo, perché è un’anomalia teorica rispetto al marxismo classico occidentale. Non la possiamo spiegare unicamente per il ritardo italiano, questo non funziona, ma è vero che funzionano anche dei limiti che sono per esempio assenza di multicomposizone: di fatto l’esperienza italiana è stata quella di una situazione unificata all’interno di una medesima lingua, un territorio molto unificato culturalmente rispetto alla Francia, che paradossalmente aveva un’unità molto più forte, ma era probabilmente un tentativo dialettico di imporre un’unità che non era del tutto visibile, che era cioè molto più separata, molto più eterogenea di quello che si pensa. Allora, forse sull’Italia questo ha pesato come un limite. Il secondo limite è costituito da questa egemonia culturale del PCI. Mi ricordo che uno degli operaisti mi diceva un po’ sdegnosamente: “come fate ad avere ancora un segretario generale del Partito Comunista che è un operaio?”, comparando Marchais a Berlinguer o ad altri; e da quel punto di vista poteva essere visto come una sofisticazione altissima del discorso, mentre invece in Francia quel distacco intellettuale col Partito Comunista si è rivelato molto più tosto, dopo il ’56 io credo che della gente sofisticata poteva al massimo essere d’accordo col PCF ma sicuramente non esserne coinvolta. E non a caso il divario è sulla questione algerina, la posizione molto ambigua del PCF sulla questione coloniale gli è costata la maggior parte della gente, io direi la più rivoluzionaria. In Italia c’era questo Partito Comunista che era un’idra senza testa, che ha protetto il dibattito politico e culturale italiano dell’apertura internazionale ai livelli più duri e più brutti. Dunque, alcuni cambiamenti si sono dati solamente nel ’77: io ho avuto l’impressione di una certa regressione, quando uno come Bifo si è messo a leggere Foucault, Deleuze (e lui aveva cominciato con i nuovi filosofi, ci si figuri), questo ci ha fatto un po’ sorridere in Francia, perché si diceva: “ma guarda, questi italiani che hanno un discorso talmente elaborato, sofisticato, che di fatto era sulla politica e non sulla teoria, e d’altro canto sono talmente nativi dal punto di vista teorico che prendono le cose francesi per i lumi, cioè prendono delle cose che di fatto hanno prodotto una certa distruzione del paradigma PC, della cultura politica”. In questo senso mi sembra che tutti siano rimasti fortemente legati a certi schemi. Prendiamo per esempio la questione della guerra del Kosovo: l’Italia è rimasta terribilmente legata a un certo antiamericanismo degli anni ’50, c’è una cultura antiimperialistica classica che è una cosa stranissima, perché d’altra parte se si prendono gli scritti trontiani sugli Stati Uniti sembrano il contrario, ma nella cultura politica immediata e nella cultura dell’organizzazione c’era questo. Non è un nazionalismo, in Francia è diverso, c’è un nazionalismo puro: in Italia non è così, è piuttosto una questione di vero riformismo, ma come i veri riformismi non appaiono mai, sono molto difficile da vedere e da sconfiggere. E questo probabilmente ha fatto durare dieci anni di più certe ipotesi all’interno dell’operaismo, che altrimenti sarebbero state cancellate. Penso che probabilmente sarebbe stata utile un’apertura più forte al dibattito con i radicali anglosassoni, a cui veniva tolta ogni possibilità di fare della bella politica: questo spazio civico della politica generale è stato distrutto nei paesi anglosassoni, non esiste, perché esistono lotte radicali, punti di vista radicali, ma questa idea del ceto politico di sinistra che si nutre di una certa tradizione illuministica, poi statale, poi storica, non esiste nel paese, ed è di fatto la condizione generale. Credo che ciò l’operaismo l’abbia pagato, e rileggendolo (perché io ho letto delle cose vecchie dell’operaismo) c’è tutta una parte di retorica che è legata a questa cosa. Per esempio, Operai e capitale è stato tradotto in Spagna e io mi chiedo veramente come persone giovani di 25 anni possano leggere queste cose: è stata una riedizione, come leggere Lenin in Inghilterra quando tu non hai più quella cultura marxista classica? E’ per questo che io penso che dobbiamo ritrovare dei riferimenti, delle ipotesi operaiste: io non ho fatto molto di più che riprendere anche l’ipotesi operaista all’interno del mio discorso sul lavoro salariato, però cambiando di terreno, non più sulla vecchia Europa ottocentesca o novecentesca, ma su un terreno mondiale di confronto di forme di sfruttamento nuove.
- Quali sono secondo te gli autori e le figure che possono offrire degli spunti e delle chiavi di lettura politica importanti nell’analisi della presente transizione e in prospettiva futura?
Io sto lavorando con Maurizio Lazzarato, tentiamo di
trovare uno spazio che non sia lontano da Marx in un certo modo; lui litiga
anche con Toni su delle cose del genere, ma io penso di trovare un luogo di
discussione. Poi naturalmente ci sono stati Deleuze, Guattari, Foucault. E’
difficile rispondere a questa domanda, perché di fatto a un certo punto
a me piace leggere piuttosto la storia di parti sconosciute, storia delle piantagioni,
o oggi storia del cognitariato: queste figure ibride che sono esploratori e
che sono sempre la frontiera. In queste fase di transizione è gente che
sta un po’ in un mondo, un po’ nell’altro e poi nell’altro
ancora, e questo crea una differenza di potenziale interessante. Direi che sono
tutte queste figure nella frontiera ad esempio americana, che erano i cacciatori,
i contrabbandieri, i pirati, tutto questo tipo di figure ibride dal punto di
vista culturale. Mentre invece oggi trovare il corrispondente nella nostra società
moderna, calda e naturalmente nascosta, perché non si vede immediatamente.
Questi contrabbandieri erano dei marginali nel loro tempo, e oggi qual è
questa gente? Allora, per esempio ho trovato queste persone che vivono in Internet,
è probabilmente gente che sta elaborando dei valori, un certo tipo di
convivialità, che vi assomiglia più o meno, ma questa volta non
come delle basi rosse, con tutta questa figura un po’ retorica delle basi
rosse: vive in un certo mondo, un mondo virtuale che però è anche
un mondo effettivo della cooperazione cognitiva, che diventa pure immediatamente
cooperazione intellettuale e politica. Prendo sempre l’esempio di questi
ricercatori interni alla Monsanto che successivamente alla pubblicazione sull’Intranet
della firma del progetto, l’hanno diffuso nel web e hanno raccolto 8000
firme contro questo progetto, e di fatto tre giorni dopo la firma ha dovuto
cambiare. Questo è il tipo di organizzazione, è affascinante capire
come funziona. Penso ad alcune cose di Romano legate a questa idea, sono di
fatto realizzate, sono diventati fatti reali, e oggi funzionano come la ricreazione
di uno spazio pubblico e comune che precisamente è tolto nella società
classica, che non esiste più, perché la piazza non è più
il luogo delle manifestazioni, i comizi e le elezioni non sono più il
luogo della politica, e la politica si è spostata su questo tipo di cose.
Cioè, l’intelligenza critica del mondo si fa oggi con tutta questa
gente che va sul net, prende delle informazioni, e questa è anche diventata
forza produttiva, ma anche forza produttiva di denaro, non solo di critica.
Leggere tutta questa cultura (perché ci sono vari autori che cercano
di sapere come funziona) mi sembra una cosa molto interessante oggi per le ricerche
che sto facendo. Ma dire autori precisi non è facile. La cosa più
interessante che ho visto recentemente è stata trattata per il nostro
prossimo numero sulla critica dell’universale, ragione mestizia, si tratta
del concetto della colonialidad del potere, elaborato da gente che cerca di
sapere come funzionava e funziona ancora dopo la decolonizzazione un colonialismo
del potere interno a tutto, alla politica, alla scienza ecc. E’ interno
a una geopolitica del sapere, e non più solo a una geopolitica della
geografia, della forza. Dunque, c’è il problema di che tipo di
sapere, che pensiero c’è ai margini, dentro e contro: ma questo
dentro e contro non è più quello dell’operaio dentro la
fabbrica, ma è il dentro perché tutti siamo coinvolti nel movimento
del capitale mondiale, però è ai margini per avere una visione,
ad esempio, di quelli che sono stati emarginati. Cioè, ricostruire il
punto di vista della totalità, però non per fare una fusione,
ma per guardare questa divisione, questa spaccatura, questa scissione, e quindi
la duplicità del pensiero intellettuale che è allo stesso tempo
interno alla globalizzazione ma pensa anche a tutto quello che la globalizzazione
continua a colonizzare, come continui ad essere un potere coloniale, non solo
un potere classico. Un potere che si nutre di cose che sono ben al di là
della fabbrica o dello sfruttamento.
| ^^TOP |