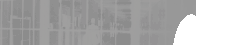«Tenere su il morale» significava comprendere la necessità, per la resistenza antitedesca e antifascista - a qualche mese dall'8 settembre -, di ricercare lontano le ragioni per divenire qualcosa di serio e di unitario. Così nacque un po' dovunque l'impegno della riscoperta e della riaffermazione dei valori risorgimentali, della conoscenza della realtà economica e sociale del nostro Paese, del contatto e del dibattito sul pensiero politico dell'Europa moderna, in modo da mutare in giudizio critico la ribellione sentimentale contro il fascismo e in meditato fatto politico il nostro "no". Non si può dire, naturalmente, che vi sia stato in proposito un piano, un programma organico e definito, un intento preciso da parte di qualche gruppo, di qualche autorità. La spinta non viene dalle gerarchie militari che sono crollate con l'armistizio né dai comandi italiani dei campi che i tedeschi lasciano funzionare per regolare la vita interna; l'ispirazione non parte né da un partito né da un qualche C.L.N. (che solo al termine della prigionia si riveleranno). L'iniziativa sorge dapprima da un bisogno quasi istintivo di chiarezza e insieme di difesa dell'individuo. Ed è giusto notare come accanto al filone della ricerca dettata da una volontà politica si pone e in esso si confonde quello, a carattere nettamente strumentale, della distrazione culturale e ricreativa. «Tenere su il morale» comprendeva, anche se non sempre chiara negli stessi promotori, la spinta a difendere il più possibile la massa dall'inerzia, dall'ozio, dal pericolo continuo della degradazione e dell'imbarbarimento. Restare uomini era in quella situazione un problema essenziale e per continuare a essere uomini valeva non già trattenere il fiato, non sprecare energie, non far lavorare né muscoli né cervello quanto invece l'impegnarsi in qualche cosa, appassionarsi in qualche interesse, magari un gioco, uno spettacolo, lo studio, la discussione e la ricerca sui perché della prigionia e sul futuro nostro e del nostro Paese. Per resistere bisognava restare uomini e per essere uomini occorreva anche rendersi conto dei motivi della nostra resistenza.
La lettura, lo studio, il dibattito delle idee, le conferenze, i corsi veri e propri, apparvero pertanto un utile e indispensabile mezzo di tutela della nostra umanità, un diversivo, un passatempo anche, così come in qualche periodo si organizzarono nei lager degli ufficiali competizioni sportive e spettacoli musicali e drammatici. Nello stesso tempo era necessario fare il possibile per offrire ai più giovani l'occasione di riprendere in qualche modo un corso di studi, una preparazione culturale e tecnica che la guerra prima e la prigionia poi avevano drasticamente interrotti.
In alcuni campi si giunse a poco a poco alla creazione di una sorta di università vera e propria. Non mancavano infatti, in quella enorme massa di internati, competenze e capacità anche notevoli e talvolta di primo piano, nei più diversi ambiti culturali e scientifici, né difettavano ascoltatori e studenti. Non era difficile avere un pubblico; difficile era trovare un qualsiasi ambiente dove tenere una lezione o una conferenza. Non dimenticherò mai, ad esempio, i pastori valdesi che, nel campo di Sandbostel, tenevano conferenze all'aperto, tra una baracca e l'altra, e avevano sempre un uditorio numeroso, e non formato certo dai soli correligionari. E' vero che le loro parole esercitavano un fascino particolare, soprattutto per quanti, e non erano pochi, non avevano mai avuto occasione di ascoltare sacerdoti nei quali il senso religioso fosse tanto vivo e tanto fortemente si unisse al gusto della libertà.
All'inizio tuttavia il dibattito culturale e politico si svolse soprattutto nel microcosmo della baracca e condusse alla formazione di piccoli gruppi omogenei, quasi di scuole. La vita del lager, del resto, era ferreamente fondata su principi organizzativi tali - il blocco, la baracca, la camerata - da rendere inevitabile la formazione di gruppi. E d'altra parte la vastità di quegli agglomerati umani, la durezza dell'esistenza, il difetto inevitabile di forme generali di solidarietà e di assistenza, la minaccia continua della fame e della malattia acuivano il bisogno di superare l'isolamento, di stringere un legame di amicizia in una qualche società, in un qualche patto di difesa e di lotta. Credo che siano stati rarissimi i casi di internati che abbiano percorso l'intero cammino della prigionia senza il conforto o l'aiuto dell'amicizia e della fratellanza. Il mondo del lager non conosceva pietà per chi restava solo, e isolarsi significava diminuire le possibilità di resistere.
Come si formavano i gruppi, le piccole unioni, le ristrette solidarietà? Una parte importante bisogna riconoscerla al caso, all'incontro fortuito, all'accostamento cieco in una baracca o in un camerone e più ancora alla comunanza della vicenda militare, della lotta dell'8 settembre, al vincolo dell'arma o del reparto, alla suggestione della regione o della terra di origine. Ma in generale agivano affinità più sottili e segrete, umane e politiche e culturali; non tanto il calcolo utilitario quanto la comunione del temperamento, delle idee, degli interessi.
Ho vissuto per molti mesi, a Küstrin e a Sandbostel, in una vera e propria società. Eravamo in sette: José, Geppino, Ferruccio, Cecco, i due capitani P. e S. e io. Mi chiedo ora, a distanza di tanti anni, che cosa ci avesse uniti. La risposta è semplice per ciò che riguarda Cecco: la nostra fratellanza risaliva ai giorni di Rodi, agli episodi dell'8 settembre, al viaggio dall'Egeo in Germania. Avevamo vissuto e continuammo a vivere fino al ritorno in Italia come fratelli, sulla base di un affetto umano, semplice e pieno. Cecco era un antifascista per istinto e bizzoso come sono talvolta i toscani, ma non contava tanto questo punto di contatto quanto piuttosto, in lui, un'inclinazione schiva e prepotente a proteggere, ad aiutare chi gli sembrava più debole. Non c'erano problemi né dispute ideologiche o culturali fra noi, ma un'intesa e un affiatamento che sembravano trovare ragione quasi nella voce del sangue, nel rapporto tra il fratello maggiore e il minore.
Ma gli altri? Non avevamo in comune né il paese né la vita militare, né l'arma né, inizialmente, la baracca. Geppino - una barbetta rada, il monocolo, una palandrana incredibile e un paio di zoccoli da gigante - lo incontrai dopo una conferenza che avevo tenuto nel teatro di Küstrin, mi pare, sul Pisacane. Era un liberale crociano. Scoprimmo immediatamente amicizie comuni e comuni interessi ed ebbe così inizio tra noi una conversazione ininterrotta di mesi e mesi. Quanto discutemmo in quella fresca estate di Küstrin, passeggiando tra le due file di baracche sul selciato malamente connesso di quella sorta di via principale del lager! Fino a sera, talvolta, quando i riflettori cominciavano a sfrecciare sospettosi e Geppino inciampava più del solito.
Egli fu il tramite per l'incontro con José, con il quale aveva dimestichezza già dall'inverno di Polonia. José, ufficiale di cavalleria, teneva a Küstrin lezioni di storia dei trattati. La sua origine politica era ben diversa dalla nostra e l'amicizia si inaugurò sotto il segno del dibattito delle idee, quasi della diffidenza. Restò armata ma divenne via via schietta e cordiale perché bisognava riconoscergli la rettitudine intransigente, il senso dell'onore, un'intelligenza acuta, uno sforzo spassionato di chiarezza e di comprensione delle cose. Con Ferruccio, giornalista e correttore di bozze di un grande quotidiano, le cose furono più facili. Il ponte di unione consisteva in un comune bagaglio di idee e di propositi politici, nel gusto accanito della ricerca e della discussione antifascista. Era di Parma: la grande chioma rossa pareva si accendesse quando entrava impetuoso nel dibattito. Il capitano P. fu tra gli eroi oscuri dell'attività culturale. Quando giunse, dopo infinite traversie, dall'Albania a Küstrin era lacero, patito, senza forze, senza una camicia, senza un paio di scarpe, ma aveva avuto il coraggio di trascinarsi dietro un carico prezioso di libri. La passione per lo studio e per la lettura, l'ansia e l'ambizione di conoscere facevano di quell'avvocato genovese, di idee largamente liberali, un consigliere illuminato, un fervente promotore e propagandista di tutte le iniziative culturali.
Il capitano S. era un siciliano di Roma. Non obbediva, come gli altri, a un particolare richiamo di natura politica, a un'esigenza di chiarificazione e di confronto delle proprie idee. Si avvicinò per simpatia, per la suggestione forse della sicurezza che emanava da quel gruppetto di giovani «intellettuali».
Così ci incontrammo e ci conoscemmo misurando e dibattendo le nostre convinzioni e i nostri propositi. Quando decidemmo di mettere in comune le nostre risorse e di aiutarci vicendevolmente, avevamo già constatato l'esistenza di un dato comune, di una piattaforma di idee. Certo non si poteva dire che militassimo sotto la stessa bandiera, e probabilmente, se oggi fosse possibile un incontro, le differenze e i contrasti di allora verrebbero ancora una volta alla luce. L'ambiente sociale in cui avevamo vissuto, la formazione culturale, le esperienze che ci avevano maturato risultavano diversissime, ma un accordo si era stabilito sulla base della necessità di resistere fino in fondo, di discutere fra noi e con gli altri, di chiarirci il più possibile i problemi. Restammo uniti a lungo; fino al ritorno in Italia, si può dire, anche se la nostra società subì il travaglio e le crisi inevitabili nella ferocia di quel mondo, anche se talvolta avvertimmo il peso intollerabile della convivenza.
Allo stesso modo per una scelta necessaria o per affinità impellente si formarono nel lager numerosi piccoli sodalizi e gruppi di amici. Essi costituirono le cellule prime della discussione e dell'attività politica e culturale e male si comprenderebbe lo sviluppo e la forza della resistenza antitedesca se non si ponesse mente a questa rete sottilissima, tenace, nell'organizzazione degli internati. I problemi di fronte ai quali ci trovammo richiedevano senza dubbio e in ultima istanza la decisione autonoma e responsabile del singolo, ma è nel gruppo, e nella baracca, attraverso le discussioni, le dispute, i contrasti, l'esame minuto ed esasperante, che si definivano le posizioni e che derivava a ognuno la volontà e il coraggio di compiere il gesto, di pronunciare la parola del rifiuto di fronte al nemico.
In questo scambio continuo e intenso di esperienze, in questa circolazione delle idee, assicurata da un'infinita serie di rapporti e di contatti personali, si trova l'origine e la ragione del successo dell'opera di chiarificazione culturale estesa all'intero lager.
In essa, nella scelta della materia, nel tono, negli accenti si espressero dapprima, e con qualche timidezza, i diversi interessi politici, le contrastanti posizioni ideologiche. Sia nell'ambito della baracca che in quelle quasi «ufficiali» lezioni e conferenze sarebbe stato certo difficile definirsi e presentarsi sul terreno politico come democratici cristiani o comunisti, come liberali o socialisti, perché al di là delle difficoltà obiettive (tra i tanti divieti v'era anche quello relativo alle discussioni politiche), altre ne esistevano, e ben più gravi, determinate dalle condizioni di assoluto disorientamento e diseducazione della grande maggioranza degli internati. Occorreva in sostanza una specie di cura omeopatica, di presa di contatto con idee e principi che per molti avevano un sapore di novità assoluta. Bisognava nello stesso tempo far scaturire una nuova fede politica da un esercizio il più possibile autonomo e critico, in modo da non creare il sospetto di voler sostituire un credo a un altro.
Il distacco e la condanna del fascismo significarono d'altra parte per molti sospetto e fastidio verso la politica in genere, quasi che gli errori, le colpe, i crimini di un partito, di un regime, di una ideologia fossero da attribuire a un astratto e diabolico ente quale la «politica».
Essere «apolitici», in un'ibrida e assurda formula in cui concetti prequalunquisti si mischiavano ai vecchi pregiudizi dell'esercito che sta al di sopra della mischia, pareva il rimedio migliore contro la terribile «scottatura» del fascismo, quasi un rifugio dal rischio di altri errori e pericoli.
Era naturale perciò che la rivelazione delle ideologie, delle concezioni, dei programmi politici avvenisse sul terreno della cultura e per lenta incubazione, il che da una parte costituì un vantaggio in quanto attenuò lo scontro e i contrasti, ponendosi in luce soprattutto i principi e le aspirazioni comuni. Dall'altra fu senza dubbio un limite, perché la formazione unitaria si arrestò spesso alla superficie, non approfondendo sufficientemente i temi e i motivi politici che in quel medesimo periodo erano in Italia oggetto di discussione e di lotta nell'ambito del movimento di Liberazione e che gli internati si sarebbero trovati di fronte al loro ritorno in Patria. L'episodio che già ho riferito in merito al tentativo di una discussione sul problema istituzionale è a tale proposito significativo, sia perché nell'impostazione i «repubblicani» si rifacevano a un esame storico della funzione della monarchia in Italia, a quell'esaurirsi del suo compito e della sua legittimità e introducevano il problema politico solo come tema di riflessione sul quale dopo la guerra si sarebbe imposta una decisione, sia perché nella difesa dei «monarchici» campeggiava il proposito del «quieta non movere», del non tirare in campo questioni che potevano dividere gli animi e la volontà degli internati.
Accadde così che talvolta l'unità venne intesa come accantonamento e rinvio della discussione di determinati problemi, come un accordo generico che occorreva fare il possibile per non turbare. Siamo d'accordo: era un ritornello che concludeva molto spesso le discussioni, mascherando le sostanziali differenze di idee e di programmi. Ricordo un ufficiale che diceva di essere stato federale fascista di una provincia siciliana e che non aveva aderito né intendeva riconoscere la repubblica di Salò. Costui, nelle infinite discussioni che intorno al fascismo, alle sue responsabilità, ai suoi crimini, si accendevano, indicava sempre come motivo della sua permanenza nel lager una serie di soprusi e di torti di cui era stato vittima e concludeva osservando che non conveniva, del resto, farsi infinocchiare ancora da Mussolini. E se da altre parti erano messe in campo ragioni più valide e dure di condanna, se ci si addentrava in qualche analisi della struttura classista e della politica antinazionale del «regime», alzava di colpo le mani, quasi in segno di resa, e diceva: «Ma siamo d'accordo!» Oggi tuttavia se fosse vivo non mi meraviglierei se militasse tra i neofascisti.
Pure a poco a poco le diverse posizioni si precisarono, intuendosi anche il valore che l'orientamento di quella grande massa di uomini avrebbe avuto nel futuro nella vita politica della Nazione, e in quella scuola di democrazia che pur faticosamente riuscì a essere l'esperienza dell'internamento, vennero assumendo fisionomia e contorni chiari i diversi gruppi e partiti politici, sicché in prossimità della liberazione o subito dopo poterono anche nei campi costituirsi i C.L.N.